Shinsetsu. Il potere della gentilezza- Clóvis De Barros

SINTESI DEL LIBRO:
Suntsu è cinese. Shinsetsu, giapponese. Il primo è maschile. La seconda
tende al femminile. Ma non per questo evoca meno donne guerriere come la
mia. E uomini gentili e rispettosi. Come cerco di essere io in ogni
occasione. Non c’è alcuna certezza in merito al fatto che sia esistito un
soldato di nome Suntsu. Potrebbe essere un personaggio inventato, come la
Shinsetsu di questo libro.
Suntsu non significa guerra. Insegna l’arte della guerra. Shinsetsu non vuol
dire pace (heiwa in giapponese). Insegna l’arte della pace. Suntsu è lo
strumento che ci consente di fare la guerra in modo efficace. Shinsetsu è lo
strumento che ci consente di fare la pace in modo altrettanto efficace.
Suntsu è uno stile di combattimento. Shinsetsu è uno stile di armonia. Chi
agisce con Suntsu rispetta i principi. E lo fa anche chi agisce con Shinsetsu.
Suntsu rincorre la vittoria sull’avversario. Shinsetsu rincorre la felicità
dell’altro. Entrambi pretendono di raggiungere il risultato.
Suntsu è usato in determinati scenari di conflitto e lotta; Shinsetsu, in
scenari di solidarietà. Suntsu cerca di occupare il campo di battaglia prima
dell’avversario. Shinsetsu, invece, cede il posto più comodo all’altro.
Suntsu agisce, in guerra, difendendo gli interessi della nazione. Shinsetsu
agisce, in pace, proteggendo gli interessi dell’umanità.
Suntsu implica che il capo conosca a fondo i propri subordinati in modo da
sfruttare al meglio le loro competenze. Sempre in vista della vittoria.
Shinsetsu prende in considerazione l’altro in generale, ne conosce i punti di
forza e di debolezza in modo da aiutarlo, ove possibile, a diventare una
persona migliore. In nome di una convivenza armonica tra tutti.
Suntsu e Shinsetsu non sono concetti filosofici. Questo libro non è
filosofico. Il suo autore non è, non è mai stato e mai sarà un filosofo. In
molti si sono già occupati di Suntsu. Ora a Shinsetsu vengono dedicate le
pagine che state leggendo.
Capitolo 2
IL PIÙ GRANDE RIMPIANTO
In oltre cinquant’anni di vita non ho mai perso di vista il mondo. La mia
esistenza è sempre stata vivida come ora. Sempre. Con il mondo davanti ai
miei occhi, ai lati e persino dietro. Immagino che sarà così fino alla fine,
che continuerò a interagire con esso. Con i suoi corpi, le sue cose. Vivere è
relazionarsi. Ogni scudo è un’illusione.
Può essere che ci siano altre cose. Al di là dei marchi che il mondo
imprime su corpo e anima di chi vive in esso. Risorse già presenti in me.
Anteriori, pertanto, alle prime esperienze. Come talenti naturali o idee
innate e un certo modo di pensare. Ma l’interazione con altri corpi non si
esaurisce mai. Finché c’è vita. E pure dopo. Quando non resta che la
putrefazione.
Adesso, in questo esatto momento, sto digitando il testo che voi state
leggendo. È domenica pomeriggio. Sono a casa mia. In camera, seduto sul
letto. Il mondo non si ferma. Oltre la casa, la camera e il letto, c’è anche il
materasso. Troppo morbido per l’attività che sto compiendo. C’è anche
l’aria che entra nel mio corpo. È condizionata. Proviene da un apparecchio
posto in alto. Raffredda il calore che giunge dall’esterno. Tante cose in un
solo secondo di vita.
E non ho ancora finito. La televisione accesa su una partita di calcio
allevia la solitudine. Non ha importanza chi stia giocando. La luce dello
schermo affatica la vista. La tastiera è morbida. I figli del vicino di sopra
stanno ancora facendo rotolare le biglie sul pavimento. È di legno.
Calzettoni da calcio, bermuda e maglietta mi coprono a pezzi e creano
attriti.
Tutto ciò, nello stesso istante. Nello stesso momento. Interagisce con me.
Come se le cose fossero vettori di realtà che incidono il mio corpo. Lo
influenzano e lo trasformano. Alcune, migliorando la vita. Altre, la
innervosiscono, irritano, rattristano. L’esperienza del mio corpo influenzato
da ciò che lo circonda è vivida. Costantemente.
L’aria condizionata, il materasso, lo schermo, la tastiera, i vestiti e le
biglie. In mezzo a questi elementi che mi influenzano, c’è pure una persona.
Presente nella stanza. Sistema l’armadio. In silenzio. Indossa un
accappatoio lilla, che a tratti attira la mia attenzione. Mia moglie Marina,
fisioterapista, è anche lei “l’altro”. Fa parte del mondo che interagisce con il
mio corpo.
Ma lo sappiamo tutti: Marina è un altro diverso da quello citato
anteriormente. È altro perché non è me. Non è identica a me. Però ha una
presenza diversa dal pigiama, dal computer o dalle biglie. In questo senso,
Marina è come me.
Forse, proprio per questo, i francesi definiscono autre le cose e autrui la
moglie. O qualunque altra persona. Tale distinzione è assente in molte
lingue. In questo libro tratteremo della relazione con l’autrui, mai con
l’autre.
In cinquantadue anni, in molti istanti di vita, la somma di tutto ciò che mi
ha influenzato è stata, a essere sincero, negativa. Ha prodotto sensazioni più
che sgradevoli. Di abbattimento. Rinunce provvisorie e parziali a continuare
a resistere. Cessazioni momentanee a insistere. Tristezze che regnano
sovrane.
Molti di questi incalcolabili istanti, però, mi sono scivolati addosso, come
avrebbe detto mio padre. La memoria del cuore pare proprio dare priorità ai
bei ricordi. Eliminando quelli più dolorosi. Senza un tale artificio il passato
sarebbe insopportabile. Registri collocati fuori dalla coscienza. Espulsi
dalla mente. Allontanati con cura. Invitati a ritirarsi con decisione e
discrezione.
E ha senso. Se ogni cosa nella vita è uno sforzo volto a preservare noi
stessi, abbiamo tutti dentro qualcosa che lotta per toglierci dalla testa ciò
che ci sminuisce, ci addolora, ci fa soffrire. Sostituendolo con qualcos’altro.
Migliore, da preferire. Mia nonna, quando era viva, la pensava
diversamente. Nel tentativo di curare la tristezza di un abbandono, soleva
affermare che ne sarebbe giunto uno peggiore.
Alcune tristezze sono in apparenza più resistenti. Mi ricordano David
Hume, che confrontava gli effetti dell’arpa (strumento a corda) con quelli
della cornetta (strumento a fiato). Sì, perché gli effetti del mondo sul nostro
corpo perdurano di più dello strimpellare che li ha causati. La cornetta
suona solo quando qualcuno vi soffia dentro. Il mondo ci influenza e l’arpa
delle nostre sensazioni continua a vibrare molto più a lungo.
Io provo, e ciò riguarda soltanto me, un genere di tristezza difficile da
digerire. Non riguarda il dolore fisico. E neanche i plateali e numerosi
fallimenti che mi hanno visto come protagonista. I rifiuti – soprattutto quelli
amorosi – li ho sempre presi più o meno con filosofia.
Per me la tristezza peggiore, quella che non si scolla, nasce da situazioni in
cui – nell’agire – avrei dovuto tenere conto di qualcuno e non l’ho fatto.
Causando, di conseguenza, infelicità, malessere, dolore, insicurezza,
eccetera.
Una richiesta di perdono sincero non basta ad alleviare la mia colpa. Mi
resta il nodo alla gola. Essere fonte di tristezza per altri – per mancanza di
attenzione, pigrizia, abitudine o perché il mio ego è andato a caccia del suo
piccolo successo quotidiano – ed esserne consapevole produce in me un
effetto devastante e una vibrazione duratura nell’arpa delle mie emozioni.
Per questo, quando mi domandano se mi sono mai pentito di qualcosa,
rispondo sempre che – nelle innumerevoli decisioni che ho preso – ciò che
più mi turba è, senza dubbio, il non aver colto l’occasione di evitare di
provocare dolore negli altri.
Quindi, nel mio caso, imparare a prendere in considerazione il mio
interlocutore, chiunque egli sia, come potenziale bersaglio delle mie
decisioni ha rappresentato un primo importante passo nella ricerca della
felicità all’interno della società di cui faccio parte. Mi sento particolarmente
bene ogni volta che una mia azione influisce in modo positivo. Non importa
nei confronti di chi. Empatia, simpatia, amore. Chiamatela come volete
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :



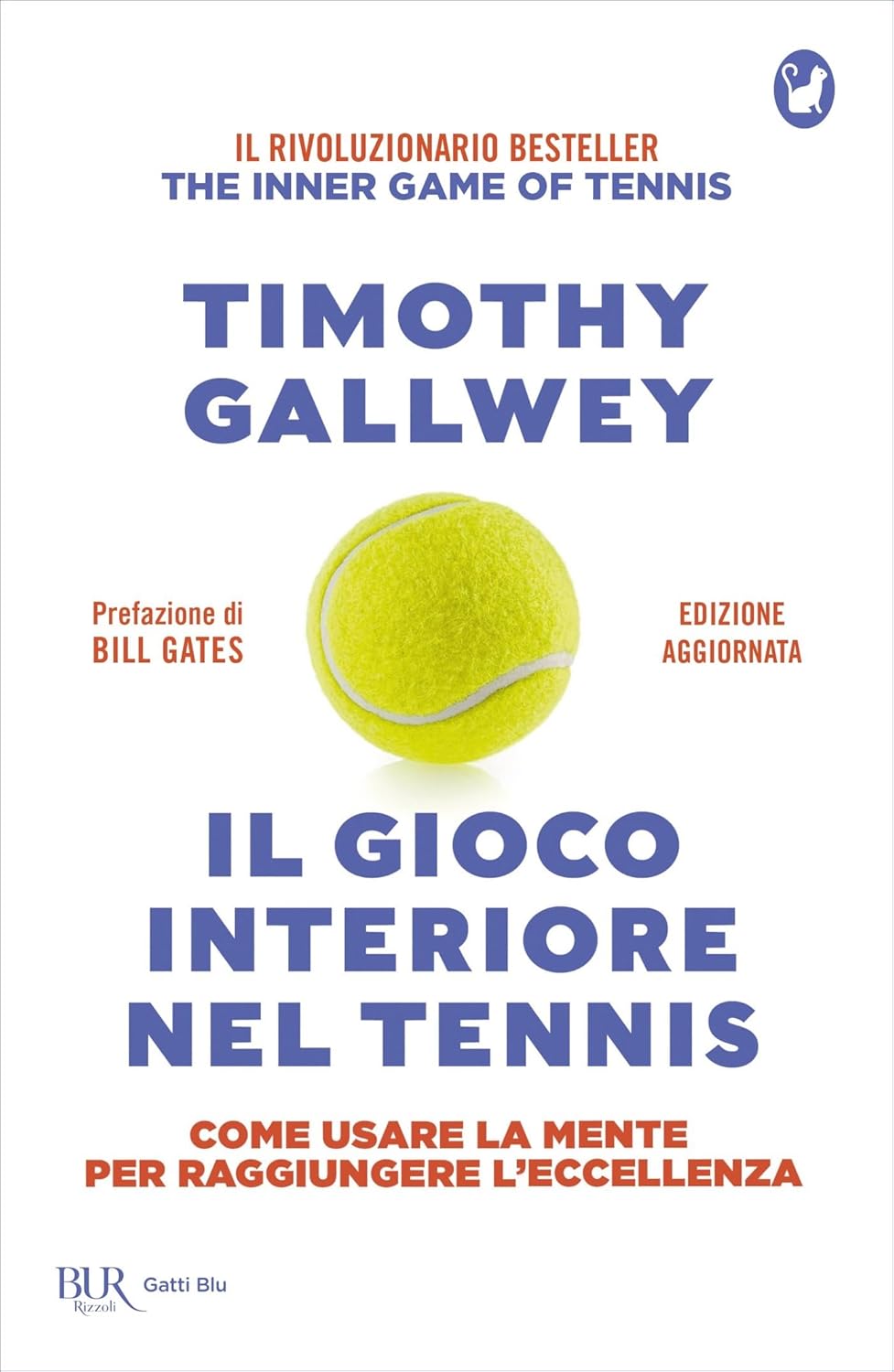
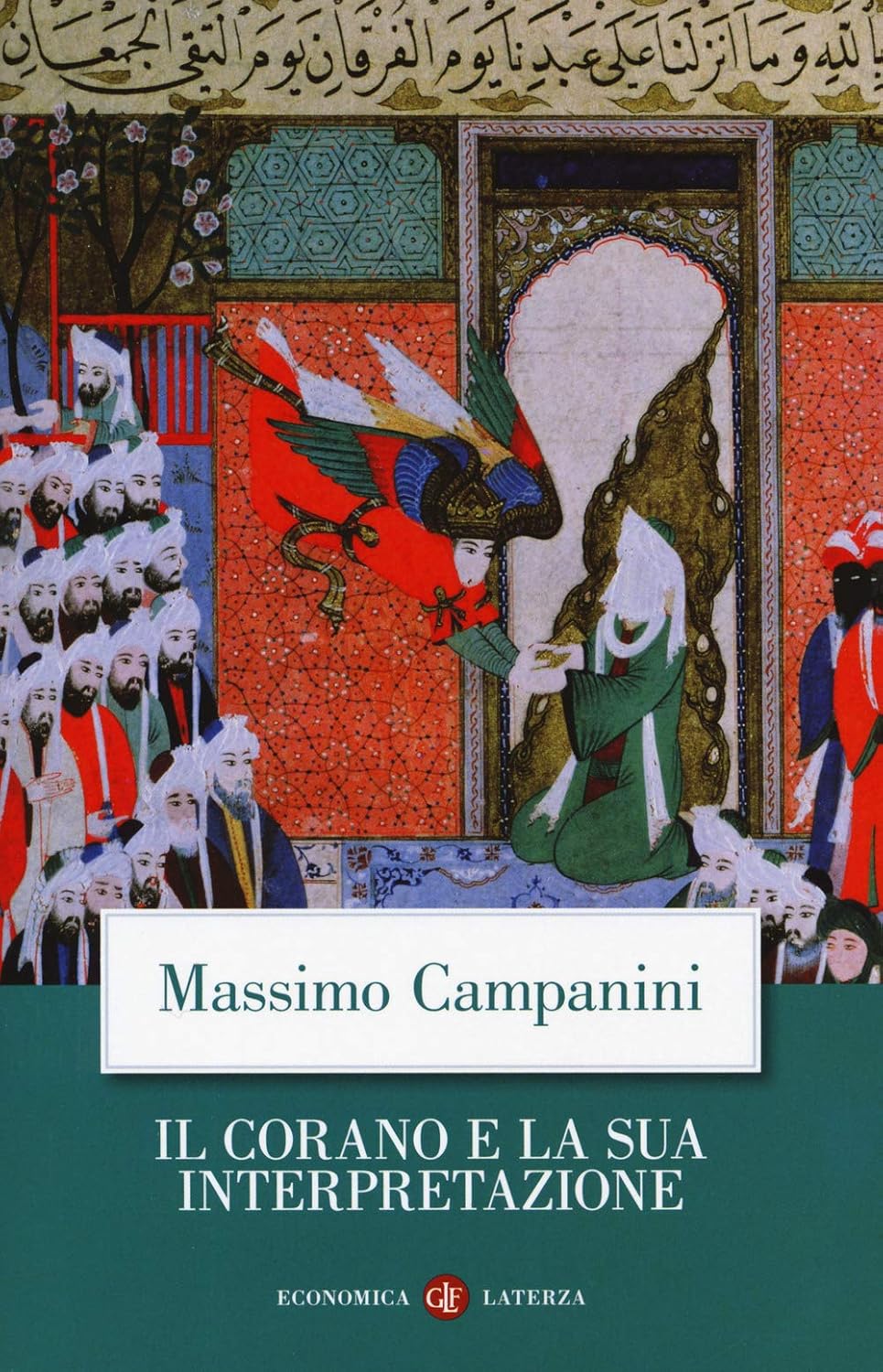

Commento all'articolo