Salute circolare Una rivoluzione necessaria – Ilaria Capua
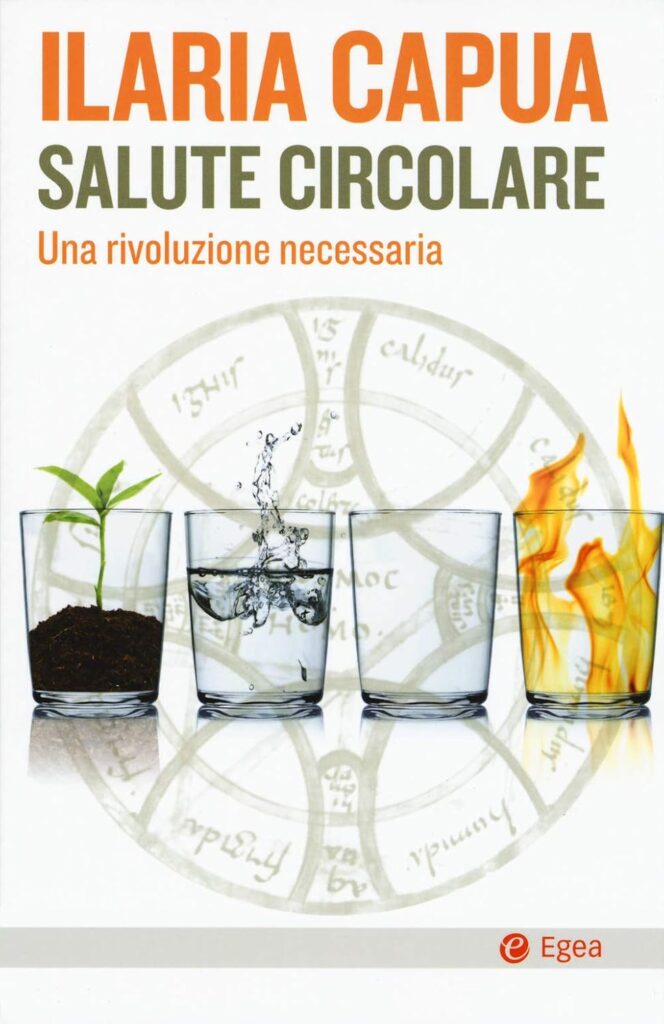
SINTESI DEL LIBRO:
Credo di funzionare un po’ così. La mia bizzarra carriera mi ha insegnato a
cercare in ogni nuova esperienza una consapevolezza diversa da cui partire,
ripartire – o magari anche semplicemente tenerla lì, non si sa mai che un
giorno non possa servire. L’esperienza parlamentare, a sua volta, mi ha aperto
a molte nuove consapevolezze, alcune delle quali mi è parso meritassero uno
specifico approfondimento. In particolare, mi sono resa conto di quanto sia
urgente ripensare il rapporto con la salute e, nel farlo, di come potrebbe
essere utile ripartire da alcuni interrogativi che ci hanno accompagnato da
sempre, da quando siamo in grado di ragionare.
La consapevolezza, poi, deve trovare agganci concreti. In questo caso, ho
preso ispirazione da un libro di Gianrico Carofiglio, Con i piedi nel fango
(Gruppo Abele, 2018), e ho capito che di certe cose bisogna parlare di più,
per riflettere con attenzione; che si possono riproporre alcuni concetti
consolidati in una chiave di lettura diversa e proiettarli così nel futuro; che è
fondamentale elaborare, confrontarsi, per aprire un dialogo. Insomma, in
questo libro voglio raccontare due o tre cose che ho capito in quasi
quarant’anni di curiosità scientifica e di spirito di osservazione da NL
(proprio così, NL).
Che cosa è uscito da questa mia riflessione? Prima di tutto, che secondo
me abbiamo bisogno di vedere la salute come un bene che scorre, come una
linfa vitale che connette fra loro gli uomini, gli animali, le piante e
l’ambiente. Di fatto, uomini, animali, piante e ambiente altro non sono che
vasi comunicanti. Per capirlo fino in fondo, dobbiamo espandere le
conoscenze trasversali e affrontare i problemi nella loro complessità, non
possiamo limitarci a un approccio verticale. La scienza moderna porta nel suo
DNA – giustamente, beninteso – il processo di specializzazione, e per questo
ha saputo dare i risultati che tutti (a parte qualche scettico, chiamiamolo così)
le riconoscono. Ma, in un mondo sempre più complesso, il rischio è anche
quello di perdersi, nell’iperdettaglio o nell’iperconosciuto, e di non avere più
la visione complessiva. Un approccio di più ampio respiro, integrato, è
essenziale per dare il nostro contributo ai 17 Sustainable Development Goals
delle Nazioni Unite, che – per quanto irraggiungibili secondo alcuni –
rappresentano l’unica speranza di revisione di politiche attuali che si rivelano
ogni giorno di più assolutamente insostenibili. Sono quindi completamente
uscita dal mio ambito di iperspecializzazione per volgermi indietro, andando
a frugare nella storia della scienza e focalizzandomi su alcuni personaggi per
riflettere sul metodo e imparare da loro. Una specie di abbrivio all’indietro,
che mi ha permesso di prendere la rincorsa partendo dal passato in
preparazione per un salto concettuale in avanti.
Così, a poco a poco, la linea di riflessione che stavo seguendo si è allargata
in modo naturale dalla scienza alla storia e alla filosofia, alla cronaca, persino
all’arte. E allora ho proposto a Daniele Mont D’Arpizio, mio co-autore nel
libro Io, trafficante di virus (Rizzoli, 2017), di darmi una mano e di calarsi
nel suo ruolo di giornalista intervistatore, ponendomi le domande lungo le
quali si sviluppa questo percorso; poi ho chiesto a Sara Agnelli, adjunct
professor con un PhD in Classics che lavora con me all’One Health Center of
Excellence dell’Università della Florida, e ad Alberto Fioretti, giovane e
volenteroso laureato in filosofia, di aiutarmi a documentare quello che avevo
in testa. La mia nuova consapevolezza.
Ho imparato moltissimo nello scrivere questo libro, che si è rivelato pagina
dopo pagina una passeggiata piena di meraviglia e di sorprese. Perché
abbiamo tutti bisogno ogni tanto di fermarci a riflettere sul senso di quello
che facciamo e sulle nuove consapevolezze: senza la conoscenza del percorso
che abbiamo alle spalle è difficile stabilire la direzione futura. E, allo stesso
tempo, dobbiamo saper cogliere a piene mani le opportunità del presente. Per
farlo, ho cercato di usare il movimento – dobbiamo partire dal passato per
lasciarci trasportare da accelerazioni che ci consentano di immaginare le
potenzialità della tecnologia, alternate a ritorni verso la realtà in cui viviamo
tutti i giorni. Ma dobbiamo anche poter cogliere dei frammenti essenziali e
contemporanei del mondo che ci circonda, come se fossero ingrandimenti al
microscopio ottico oppure osservazioni telescopiche di scenari distanti. Un
esercizio vertiginoso, ma essenziale, grazie al quale possiamo vedere il
concetto di salute in 3D, come se scorresse in un tunnel del tempo.
Con questo libro, vorremmo invitarvi a scoprire il valore della trasversalità
e la sua dirompenza, spesso illuminante, che porta a grandi e rapidi
cambiamenti. Ma vorremmo anche introdurvi alle resistenze che molte idee
rivoluzionarie hanno incontrato, proprio perché rivoluzionarie e
profondamente trasformative. Questa chiacchierata semiseria è quindi
soprattutto un racconto e una riflessione, senza alcuna pretesa di completezza,
su alcuni passaggi e personaggi assolutamente rivoluzionari, sul loro pensiero
e sulle straordinarie scoperte scientifiche che ci hanno permesso di
conquistare la salute che abbiamo oggi – un percorso, però, che ci pone di
fronte a degli interrogativi e a delle decisioni da prendere.
È urgente rifletterci già oggi, ma ancor più guardando al domani: l’era
digitale rappresenta e rappresenterà sempre più una grandissima risorsa per
migliorare la salute. Bisogna metterla bene a frutto – altrimenti, secondo me,
facciamo un dispetto cretino alle nuove generazioni, caricandole di problemi
che potremmo cominciare a risolvere adesso, almeno per provare a render
loro meno difficile la strada.
–6Pazza idea
Ilaria ma che ti sei messa in testa, perché parlare di salute?
Mi pare che sia ovvio. Ce n’è un bisogno disperato. I risultati straordinari che
siamo riusciti a raggiungere in questo campo sono sotto gli occhi di tutti, se
solo ci fosse la volontà di vederli, ma questo non significa che possiamo
accontentarci. Prima di tutto perché i grandi percorsi del pensiero scientifico
vanno protetti e salvaguardati. Inoltre la scienza va avanti, supera sempre se
stessa e quindi abbiamo continuamente bisogno di idee nuove per aggiornare
le precedenti.
Ma questo non c’è sempre stato? Quindi che bisogno c’è adesso?
Ecco, proprio qui ti volevo: è ora di vedere alcune cose in prospettiva e
riflettere e – perché no – inventarci una salute diversa, visto che oggi
abbiamo gli strumenti per farlo.
Partiamo allora dall’ABC: oggi a cosa ci riferiamo quando parliamo di
salute?
La salute ha una caratteristica che è un controsenso: ci pensi quando non c’è,
l’apprezzi soprattutto quando non ce l’hai. Già questo dovrebbe farci capire
come sia sfuggente a ogni definizione, esattamente come altri concetti
basilari, come quelli di bellezza e di giustizia. Ma salute è assenza di
malattia? Essere in salute concerne necessariamente tutto l’organismo o può
riguardarne una sola parte? La salute è soltanto della mente e del corpo
oppure anche dell’anima, qualunque cosa intendiamo per «anima»? È chiaro
che si gioca su più piani ed è riduttivo e complicato cercare di stabilire dei
paletti perimetrali intorno a un concetto tanto fondamentale.
Eppure da un’idea di salute bisogna pur sempre partire…
È più facile parlare di malattia che di salute. La malattia è già un elemento in
più, un «qualcosa» che uno possiede. In un certo senso, la salute vive
all’ombra della malattia. Spesso è proprio quando si è malati che ci si accorge
di che cosa significa essere sani. Agli albori del pensiero dell’uomo, per
comprendere le condizioni di salute e malattia la medicina greca si rivolgeva
allo studio della natura (φύσις, physis), intesa come la totalità delle cose che
esistono, che nascono, che vivono, che muoiono. A partire dal pensiero greco
antico, questo approccio andrà poi ad accomunare autori e testi di epoche e
discipline diverse tra loro. Il caposaldo di un ragionamento tanto logico
quanto ovvio: talmente ovvio che ci erano arrivati in molti pure senza averne
gli strumenti. Ovvero: poiché noi esseri umani siamo assolutamente
dipendenti dalle altre forme di vita sulla Terra dobbiamo impegnarci a
promuovere un approccio diverso. Spesso infatti l’errore che si fa è di
considerare la salute come valore e risorsa che riguarda soltanto gli esseri
umani, e solo in minima parte anche le altre specie viventi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :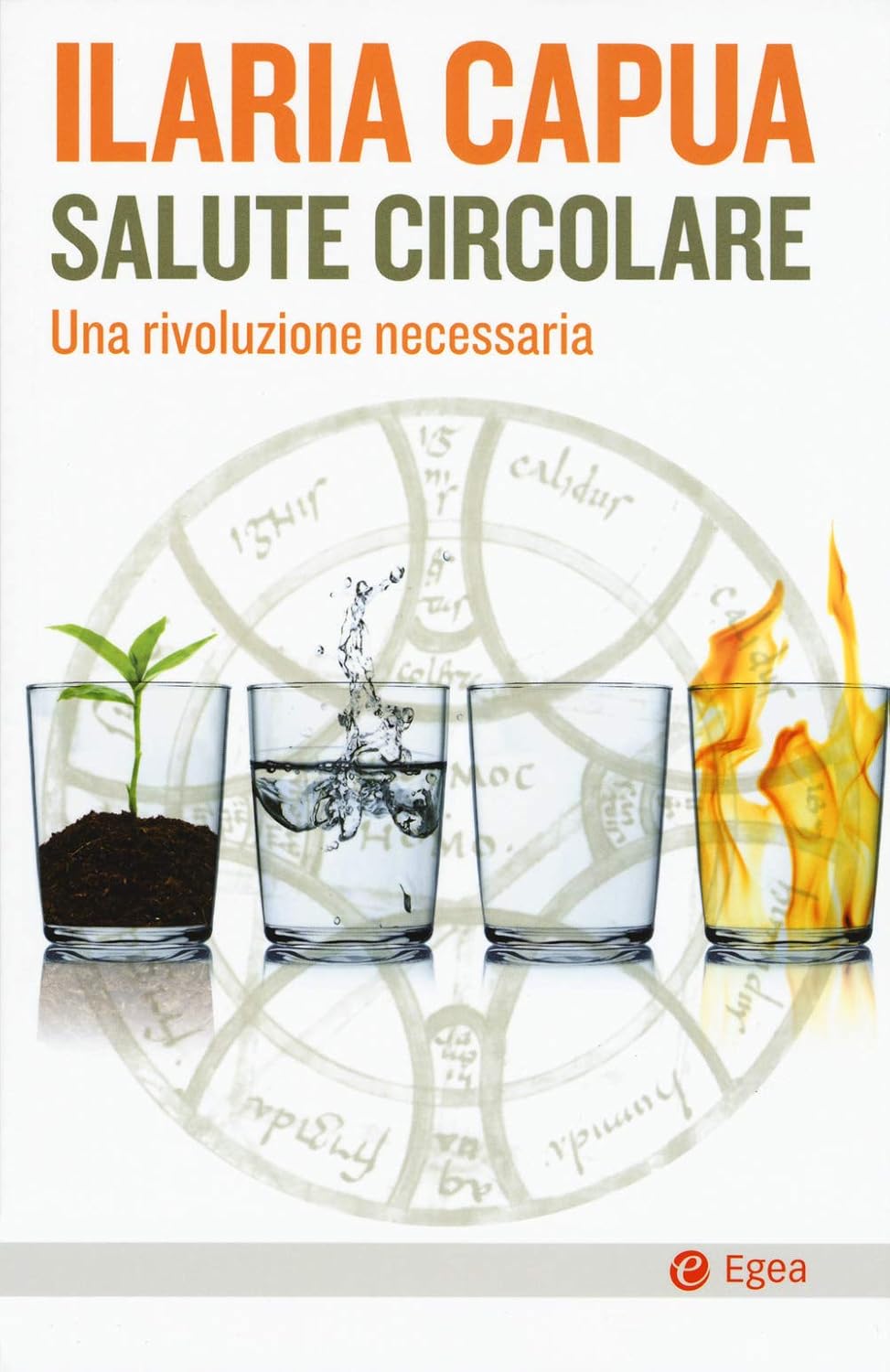






Commento all'articolo