Ritorno Dall’ India – Abraham B. Yehoshua
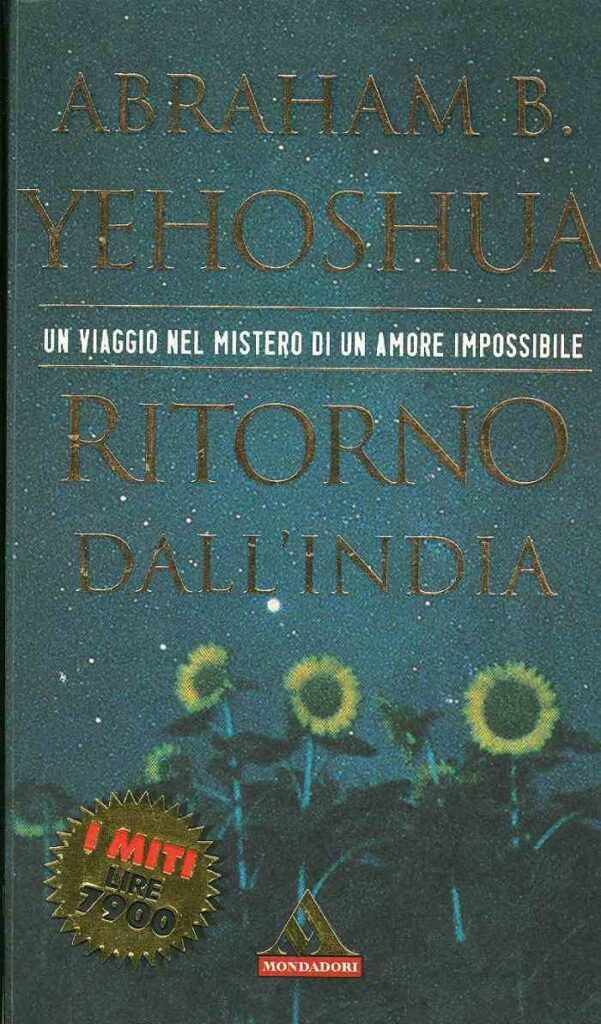
SINTESI DEL LIBRO:
Ora la ferita era pronta per la sutura. L’anestesista si tolse
impaziente la mascherina, e come se non gli bastasse più il grande
respiratore con le sue cifre lampeggianti in continua mutazione, si
alzò, prese con delicatezza la mano inerte per sentire il polso e poi
sorrise con simpatia verso la donna nuda e dormiente, e mi strizzò
l’occhio. Io feci finta di nulla: stavo fissando il professor Hishin per
cercare di capire se aveva intenzione di ricucire da solo o avrebbe
lasciato finire uno di noi. Tremai pensando che mi mettessero da
parte ancora una volta per affidare il lavoro al mio rivale, l’altro
medico che si stava specializzando. Seguii col batticuore i movimenti
delle mani della slavata infermiera, che asciugava ripetutamente le
gocce di sangue intorno al taglio lungo e diritto ancora aperto sul
ventre della donna. Potrei proprio fare bella figura, pensai con
amarezza, concludere l’intervento con una cucitura elegante. Ma
Hishin non dava l’impressione di voler affidare ad altri il lavoro.
Nonostante le tre ore filate trascorse in sala operatoria, con la stessa
suprema concentrazione con cui aveva iniziato l’intervento si era
messo a frugare tra gli aghi. Trovò quello che cercava, e lo porse con
irritazione all’infermiera per un’ulteriore sterilizzazione. Come mai si
sentiva in dovere di ricucire personalmente questa donna? Aveva
ricevuto qualche bustarella? Mi allontanai lentamente dal tavolo
operatorio, consolandomi all’idea che almeno questa volta mi
sarebbe stata risparmiata un’umiliazione, anche se l’altro
specializzando, pur avendo colto anche lui le intenzioni del chirurgo,
restava vicinissimo a quel ventre aperto e continuava a seguire con
estrema attenzione.
Si sentì allora un tramestio presso la grande porta, e dietro un
oblò apparvero una chioma di riccioli brizzolati e una mano che si
agitava vivacemente. L’anestesista capì di chi si trattava e si affrettò
ad aprire, ma l’uomo, arrivato fin lì senza camice né mascherina,
esitò a entrare in sala operatoria e disse soltanto, con voce ferma e
vigorosa: «Non hai ancora finito?» Il chirurgo si voltò, agitò la mano
salutando con un gesto amichevole, e disse: «Vengo subito»,
tornando a chinarsi per completare il lavoro che però abbandonò
dopo pochi minuti; allora si cercò intorno, incontrò il mio sguardo e
sembrò volermi dire qualcosa, ma l’infermiera, che sapeva sempre
leggere nella mente del suo capo, si rese conto delle esitazioni e
sussurrò con fermezza: «Non ci sono problemi professor Hishin, può
terminare il dottor Vardi». Il chirurgo annuì subito mostrandosi
d’accordo, passò l’ago al giovane medico che gli stava accanto, dette
all’infermiera le ultime istruzioni, si strappò di scatto la mascherina,
tese le mani all’infermiera giovane per farsi sfilare i guanti, e prima
di abbandonare la sala operatoria disse: «Se c’è bisogno di me sono
in direzione, da Lazar».
Soffocando la vergogna e l’invidia per non lasciarle trasparire in
uno sguardo, o in un gesto, mi girai verso il tavolo operatorio. Se
anche le donne stanno dalla sua parte, pensai con sconforto, non
sussiste più alcun dubbio su chi, il mese prossimo, quando il nostro
periodo di prova terminerà, sarà scelto per restare in chirurgia:
toccherà a me vagare per altri ospedali alla ricerca di un lavoro.
Questa è la prova lampante della fine della mia carriera in chirurgia.
Ma rimasi impassibile accanto al mio collega, che aveva già sostituito
l’ago passatogli da Hishin; ero pronto a condividere la responsabilità
per l’ultima fase dell’operazione, e seguivo la ferita i cui lembi
andavano rapidamente ricongiungendosi sotto quelle dita alacri e
robuste. Se fosse dipeso da me, avrei ricucito con più precisione, per
non alterare nemmeno di un millimetro le naturali linee di contorno
di quel ventre femminile estremamente pallido, che mi suscitò
all’improvviso una grande compassione. L’anestesista, il dottor
Nakash, si stava già preparando a quello che definiva «l’atterraggio»:
predispose il distacco dei tubi del respiratore, sfilò dalle vene l’ago
della fleboclisi, canticchiando allegramente e continuando a
guardare le mani del chirurgo, in attesa del momento in cui avrebbe
potuto restituire il respiro alla sua legittima proprietaria. Stavo
ancora masticando amaro, quando mi sentii toccare da una mano
leggera. Entrata in sala operatoria senza far rumore, una giovane
infermiera mi comunicò a mezza voce che il primario mi stava
attendendo nell’ufficio del direttore amministrativo, il signor Lazar.
«Subito?» esitai. E l’altro specializzando, che aveva ascoltato quello
scambio di battute, mi incitò: «Vai pure, vai pure, non ti
preoccupare, finisco da solo».
Sbucai precipitosamente dall’abbagliante oscurità della sala
operatoria senza nemmeno togliermi la mascherina, passai oltre le
risate di medici e infermiere nella piccola anticamera, abbassai il
maniglione della porta che isolava il settore e mi ritrovai nella sala
d’attesa, rischiarata da una luce pomeridiana: solo allora mi fermai
per togliermi la mascherina. Un uomo giovane e una donna più
anziana mi riconobbero, e mi vennero incontro rapidamente. «Come
sta? Come sta?» «Bene, – sorrisi, – l’operazione è finita, tra un po la
portano fuori». «Ma lei come sta, come sta?» insistettero.
«Benedissi,, – non vi preoccupate, è come se fosse rinata», e mi
stupii di me stesso per quello che avevo detto, perché dopo tutto non
si trattava di un intervento rischioso. Poi continuai per la mia strada,
con ancora indosso il camice verde imbrattato di sangue, la
mascherina che mi pendeva al collo, il capo coperto, e i sacchetti
sterili di nylon che frusciavano intorno alle scarpe, incrociai qua e là
vari sguardi, salii in ascensore fino alla grande hall e infine mi
addentrai verso la direzione, una zona in cui non avevo mai messo
piede. Mi annunciai quindi a una segretaria che si alzò per
accogliermi, e chiedermi affabilmente che tipo di caffè desiderassi, e
poi mi condusse attraverso una lussuosa sala riunioni vuota, da dove
penetrai in una stanza grande, protetta da tendaggi, arredata come
un’abitazione: un divano, delle poltrone, grandi piante dal lucido
fogliame. Il primario, cioè il professor Hishin, stava studiando dei
documenti e sembrava perfettamente a proprio agio, come se non
avesse ancora addosso il camice da chirurgo. Appena entrai mi
sorrise amichevolmente, e mi indicò al direttore che gli stava
accanto, in piedi. «Ecco, questa è la persona che fa per te».
Il signor Lazar mi strinse la mano con calorosa energia, e si
presentò, mentre Hishin, ignorando la mia recente e dolorosa
frustrazione, mi lanciava sguardi incoraggianti, facendomi segno di
togliere la cuffia e i sacchetti di nylon. «L’operazione è finita, – mi
disse nel suo leggero accento ungherese, con gli occhi che guizzavano
ironici come sempre, – perfino lei si può riposare». Mi tolsi i
sacchetti dalle scarpe, infilai la cuffia in tasca e allungai la mano
verso la tazza di caffè; nel frattempo Hishin aveva cominciato a
raccontare a Lazar la storia della mia vita, dimostrando di conoscerla
in modo preciso e fedele, non l’avrei mai detto. Il signor Lazar
continuava a osservarmi con uno sguardo penetrante, come se il suo
destino dipendesse da me. Hishin concluse: «E non farti trarre in
inganno dai suoi abiti da chirurgo. E’ soprattutto un eccellente
internista, è questa la sua vera forza, e si ostina a voler restare nel
nostro reparto solo perché crede, erroneamente, che sulla vetta della
medicina si trovi una mannaia». Ciò dicendo brandì un coltello
immaginario e si tagliò la testa, deridendo proprio lo strumento che
sapeva suonare con tanto virtuosismo. Seguì una risata amichevole, e
come per addolcire il boccone della sentenza definitiva sulla mia
permanenza in reparto, mi posò una mano sul ginocchio e mi chiese,
con un inaspettato tono di confidenza: «E in India c’è già stato?»
«In India? – domandai stupito. – Perché proprio in India?» Ma
Hishin rideva divertito dalla piccola sorpresa: «Sì, proprio in India,
perché Lazar sta cercando un medico che lo accompagni in una
piccola spedizione da quelle parti». «In India?» ripetei faticando
ancora ad afferrare la notizia. «Ma sì, proprio così, in India. Perché
tanto stupore? Bisogna riportare a casa una giovane donna malata».
«Malata di che?» chiesi subito. «Niente di terribile, – mi
tranquillizzò Hishin, – ma si richiede comunque una certa
attenzione. Epatite acuta, virus B a quanto pare, trascurata, con
conseguente degenerazione. E anche se la situazione dovrebbe
essersi stabilizzata, qui abbiamo pensato tutti che sarebbe meglio
riportare la signorina a casa, e in fretta. Perché senza voler offendere
nessun medico indiano, qui possiamo seguirla nel migliore dei
modi». «Ma di chi si tratta? Chi è questa donna?» domandai con
insistente petulanza. «E’ mia figlia, – il direttore amministrativo
ruppe finalmente il suo silenzio, – è in Estremo Oriente da sei mesi, e
circa un mese fa si è presa questa epatite, per cui è stato necessario
ricoverarla in ospedale in una città che si chiama Gaya, nell’India
orientale, tra Nuova Delhi e Calcutta. Pare che all’inizio non ci
volesse preoccupare, per cui ha cercato di nascondere la malattia, ma
due giorni fa è tornata da laggiù un’amica con una sua lettera in cui
descrive alcuni sintomi della malattia; anche se Hishin e altri amici
mi giurano che non è nulla di grave, sono tutti convinti che sia
meglio riportarla a casa prima che sopraggiungano delle
complicazioni. Pensavamo inoltre che sarebbe meglio farsi
accompagnare da un medico, e poi potrebbe anche essere un viaggio
piacevole. Ho già pianificato tutto l’itinerario, andata e ritorno, con la
mia agenzia di viaggi: si può fare in dodici giorni, massimo due
settimane, e solo perché mia figlia si trova a Gaya, che è un luogo un
po sperduto, poco servito da treni o aerei. Se devo essere sincero, per
prima cosa ho tentato di convincere il suo professore, che in India
non c’è mai stato e avrebbe potuto approfittarne per rilassarsi un
poco, ma lei lo conosce, è sempre convinto di aver delle cose da fare,
e quando è libero preferisce andare in Europa piuttosto che in Asia.
Però ha promesso di trovarci un sostituto, una persona ideale».
Ideale per cosa? Ero profondamente abbacchiato all’idea di
scortare una ragazza malata di epatite su scalcinati treni indiani. Ma
non dissi nulla, e mi voltai verso la segretaria, entrata per annunciare
una persona che attendeva il direttore già da un certo tempo.
«Restate pure, – ci ordinò Lazar, – me la sbrigo subito», e sparì
lasciandoci soli, a tu per tu. Hishin aveva percepito la delusione e
l’amarezza suscitatemi da quella strana proposta, perché
all’improvviso mi venne davanti in tutta la sua imponenza, e prese a
parlarmi con un tono suadente: «Senti, mi rendo conto che la
prospettiva di partire per l’India così su due piedi non ti entusiasmi
in modo particolare, però al tuo posto io accetterei. Non solo per il
fatto che è un viaggio interessante – e gratuito – in un posto in cui
chissà quando avrai occasione di tornare; già, voi giovani pensate che
prima o poi conoscerete tutto il mondo, poi finite come tutti per
restare appiccicati sempre agli stessi luoghi. Te lo dice un incallito
viaggiatore come me. Ma non è questo che conta, piuttosto la
persona stessa, Akiva Lazar, e l’opportunità di stabilire un rapporto
di confidenza che potrà sempre tornarti utile se vuoi continuare a
lavorare qui, all’ospedale, ad esempio in medicina interna, o in un
altro reparto. Capisci? E’ da questa stanza che si dirige l’ospedale. Ed
è questo signore che tiene le redini, quelle vere. Senza contare che è
anche una persona per bene e simpatica. Per cui dammi retta, non
dire di no. Vai, per il tuo bene. Cos’hai da perdere? Se non altro avrai
vissuto un’avventura piacevole. E poi per quel tipo di epatite non è
che ci sia un granché da fare. Non credo che la ragazza abbia dei
danni reali al fegato o ai reni, ma se anche fosse non sarebbe poi la
fine del mondo, la natura prima o poi provvede da sola. Bada solo
che non si manifestino emorragie improvvise e che la glicemia non
scenda; e poi, naturalmente, che la febbre non abbia improvvise
impennate. Ti posso procurare dell’ottimo materiale sull’argomento;
che ne diresti se domani ci incontrassimo con il professor Levin di
medicina interna, ha un debole per l’epatite e sa tutto in materia. Poi
confezioniamo un bel pacchettino di strumenti e medicinali, per
esser pronti ad ogni evenienza. Ah, se vuoi, al ritorno puoi salutarli e
trattenerti qualche giorno in Europa. Quando ho visto il tuo fascicolo
non ho creduto ai miei occhi: in un anno che sei da noi ti sei preso un
solo giorno di vacanza?»
Si vuole dunque sbarazzare di me, constatai con una fitta di
dolore; non aspetta nemmeno il mese che manca alla fine del mio
anno di prova. Non è possibile. In quel momento tornò Lazar, un
uomo tarchiato ed energico. «Allora? – domandò con un largo
sorriso manageriale. – Siamo d’accordo, no?» Ma Hishin lo frenò,
con delicatezza. «Calma un attimo, Lazar. Avrà il diritto di rifletterci
un po su». «Certo, certo, – rispose Lazar guardando l’orologio, – ma
per quanto? Questo viaggio richiede talmente tanti preparativi, e io
avrei programmato di partire dopodomani, per prendere il volo di
martedì da Roma». Interpretando il mio ostinato silenzio come la
minaccia di un rifiuto, smise di insistere e mi propose di andare la
sera a casa sua per discutere dei particolari e decidere con calma.
Non potei dire di no, e poi mi rendevo conto che se avessi sollevato
subito delle obiezioni, quei due individui così determinati mi
avrebbero stroncato. In un attimo l’indirizzo era scritto su un
pezzetto di carta, con tanto di indicazioni su come arrivarci. Stavo già
per uscire quando Lazar mi fermò: «Aspetti, mi stavo dimenticando.
Lei è sposato?» Quando feci cenno di no con il capo, ritrovò di colpo
tutto il suo buonumore, e si volse verso Hishin con un’aria stupita:
«Ma allora, perché pensarci tanto?» E risero entrambi allegramente.
Presi la decisione di declinare l’offerta durante il plumbeo
pomeriggio, correndo fra i letti dei malati nel reparto di terapia
intensiva e lottando per bloccare un’emorragia che si era aperta nel
corpo della giovane donna operata al mattino. Se il primario mi
considerava la persona ideale solo per uno strano viaggio in India,
perché avrei dovuto rinunciare all’ultimo mese che mi spettava?
Imparavo ogni giorno cose nuove e appassionanti, ogni minuto
passato in sala operatoria, non foss’altro che per osservare, era fonte
di emozioni. Cosa avrei avuto da guadagnare da questo improvviso
viaggio in India in pieno inverno? Tornato a casa sul far del
tramonto, stanco e inzuppato, stavo già per telefonare a Lazar,
annunciargli il mio rifiuto e annullare l’appuntamento della sera,
quando pensai che non era davvero il caso di urtare una persona che
mi sarebbe potuta tornare utile. Avrei almeno ascoltato
educatamente i particolari, prima di opporre il mio definitivo rifiuto.
Mi feci una rapida doccia e mi cambiai, poi telefonai ai miei genitori
a Gerusalemme, e siccome sapevo quanto fosse importante per loro
ogni minimo passo nella mia carriera, evitai di procurare loro un
dispiacere dicendo che al reparto di chirurgia avevo i giorni contati.
Alle otto mi trovavo nella zona nord della città, dirigendomi verso un
edificio in un largo viale fiancheggiato da alberi che frusciavano al
vento e alla pioggia. Protessi la moto con il suo rivestimento, ma
quando vidi che la pioggia aumentava cambiai idea e la spinsi fin
sotto i pilastri dell’edificio. All’ultimo piano, in una mansarda bella e
spaziosa, mi attendeva un inquieto signor Lazar, con indosso una
camicia di flanella che lo rendeva più goffo e più vecchio. «Ma come
ho fatto a dimenticarmi di dirle di portare il passaporto? – mi accolse
in tono querulo. – E’ ancora valido? Quando è uscito da Israele
l’ultima volta?» Io, che due anni prima, dopo la laurea, avevo fatto
un breve viaggio in Europa, naturalmente non mi ricordavo se il mio
passaporto fosse ancora valido, e cercai anche di arginare tanto
ardore con un sorriso smarrito, spiegando che ero ancora molto
perplesso, e volevo solo saperne qualcosa di più per poterci pensare.
«Ma cosa c’è da pensare? – replicò con stupore, con una irritazione
quasi infantile. – Guardi se proprio ci tiene, le posso far vedere sulla
cartina dove ho intenzione di portarla, e non si spaventi anche se
avrà l’impressione che sia in capo al mondo, in due settimane si può
andare e tornare, e trovare anche il tempo di vedere qualcosa di
bello, perché non voglio mica proporle un calvario». E mi trascinò in
uno spazioso salotto, dove un ragazzo sui diciassette anni in divisa
scolastica, quasi il ritratto del padre a parte i capelli morbidi e
lunghi, si alzò subito e uscì. Sopra un tavolino basso di vetro c’era un
grande atlante, aperto con sparse tutt’intorno fotografie e guide
turistiche. «Questo viaggio casca fra capo e collo anche a noi, non
solo a lei, – si giustificò Lazar, – ieri ci si è presentata alla porta una
ragazza con la lettera. Prima però dia un’occhiata qui. Questa è
Nuova Delhi, qui è Bombay, ed ecco Calcutta, una specie di triangolo
insomma, e questa qui è Gaya, una città sperduta ma sacra,
circondata di santuari. Domani a Gerusalemme mi faranno
incontrare una persona che ci ha passato qualche mese, e da quello
che dice potremo formarci un’immagine chiara di quanto ci aspetta
laggiù. Ah ecco, aspetti un attimo, prima le presento mia moglie».
Fece il suo ingresso: una signora bruna grassoccia e occhialuta,
sui quarantacinque anni, di media statura, i capelli raccolti sulla
testa in modo un po trascurato. I suoi occhi mi fulminarono con un
sorriso franco e penetrante. Mi alzai, il marito mi presentò, lei annuì
a significare un’accoglienza cordiale, e si mise a sedere davanti a me
con una specie di gesto principesco, incrociando due lunghe gambe
che contrastavano con la pesantezza delle braccia e delle spalle.
Osservava il marito tracciare percorsi sulla carta dell’India e
calcolare orari. Mentre cercavo di seguirlo e di capire come intendeva
organizzare il tragitto, sentivo che lei continuava a esaminarmi, e
quando rialzai il viso i suoi occhi si accesero nuovamente di quel
sorriso penetrante, cordiale e generoso. Annuì in segno di
approvazione e poi, come se si fossa resa conto dei dubbi che mi
rodevano, interruppe a un tratto il marito e si rivolse direttamente a
me: «Pensa che potrà veramente liberarsi dall’ospedale e star via per
più di due settimane?» Visibilmente seccato da quella domanda, il
marito si affrettò a rispondere bruscamente al posto mio: «Primo,
perché parli di più di due settimane? Non ce n’è ragione. Sarà più
breve. E poi anch’io devo essere di ritorno per la domenica della
settimana dopo. E secondo: perché mai non dovrebbe potersi
liberare? Ha a disposizione tutto il tempo che vuole. Hishin gli
concede un permesso, e può prendersi questi giorni sulle sue ferie
oppure, se crede, troveremo il modo di considerarli come un periodo
di lavoro normale». Ma la moglie lo interruppe con un tono risentito:
«Perché dovrebbe prendere dei giorni di ferie? Perché dovrebbe
sacrificare le ferie per noi?» e volse di nuovo gli occhi verso di me,
dicendo con una voce chiara e risoluta che mal si addiceva alle sue
molli forme: «Lei si informi su quanto le spetterebbe per un viaggio
del genere, e noi ci impegneremo a darle la somma richiesta
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :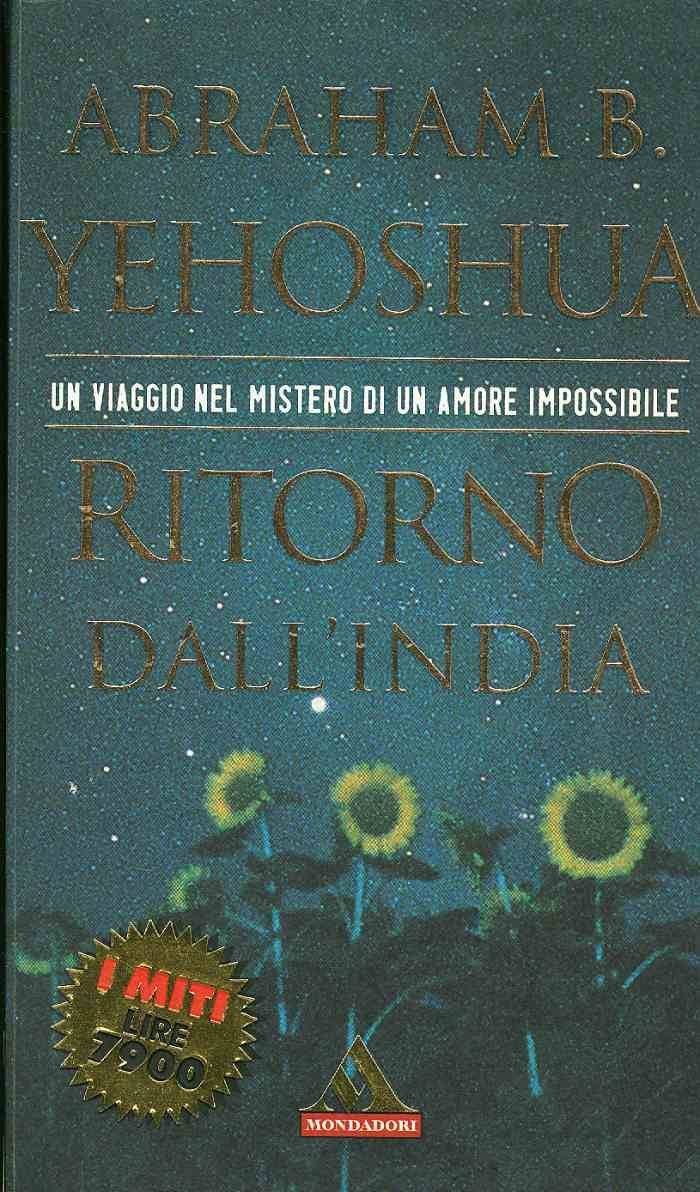






Commento all'articolo