Risvegli – Oliver Sacks
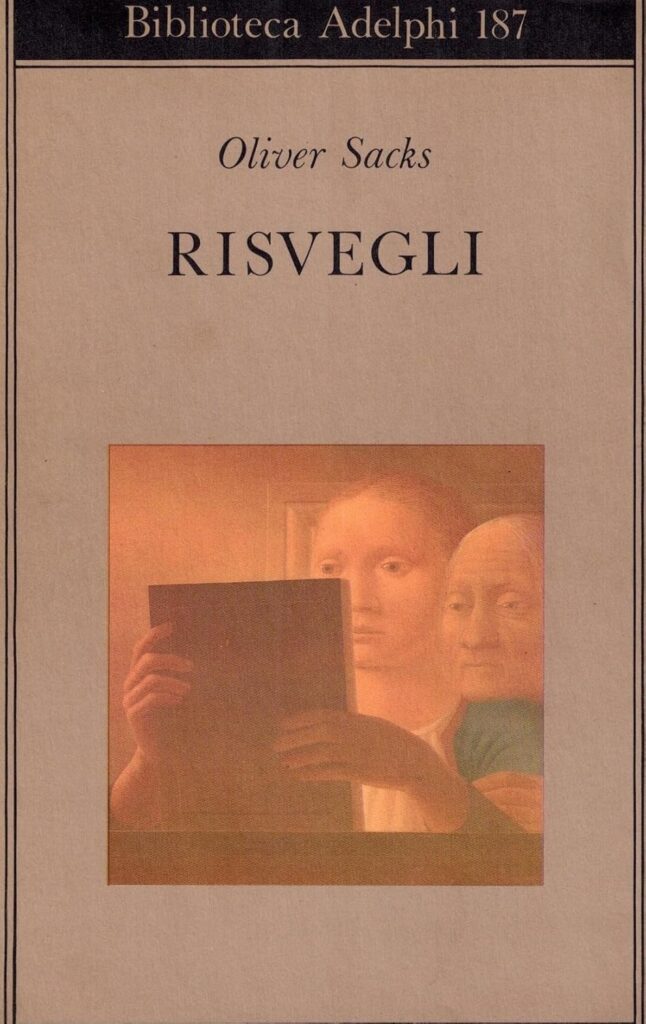
SINTESI DEL LIBRO:
La signorina D., l'ultima e la più intelligente di quattro fratelli, è
nata a New York nel 1904. Frequentava il liceo con ottimi risultati,
allorché, quindicenne, fu colpita da un grave attacco di encefalite
letargica del tipo ipercinetico, piuttosto raro. Nei sei mesi di malattia
acuta, soffrì di insonnia ribelle (restava sveglia fino alle quattro del
mattino, e poi riusciva a dormire al massimo per due o tre ore),
marcata irrequietezza (era tremante, distraibile e ipercinetica durante
le ore di veglia, e durante il sonno seguitava ad agitarsi e rivoltarsi nel
letto) e impulsività (improvvisi stimoli interiori a compiere azioni che
le sembravano senza senso, stimoli che quasi sempre, con uno sforzo
cosciente, riusciva a reprimere). La sindrome acuta fu giudicata
«nevrotica», benché i fatti dicessero che in precedenza la malata aveva
avuto una personalità ben integrata e un'armoniosa vita familiare.
Entro la fine del 1919, irrequietezza e disturbi del ritmo
regredirono in misura sufficiente perché essa potesse riprendere e
portare a termine la scuola, ma seguitarono ad affliggerla, in forma più
lieve, per altri due anni. Poco dopo la fine della malattia acuta,
incominciò a soffrire di «attacchi di affanno», che in un primo tempo
si presentavano due o tre volte alla settimana, in apparenza
spontaneamente, e duravano molte ore; in seguito gli attacchi si fecero
più radi, più brevi e più leggeri, nonché più chiaramente periodici (di
solito si verificavano il venerdì) o collegati alle circostanze (tendevano
a scatenarsi soprattutto quando era presa dall'ira e da un senso di
frustrazione). Le crisi respiratorie (ché tali chiaramente erano, benché
a quell'epoca fossero definite «nevrotiche» anch'esse) si fecero sempre
più rare, per cessare completamente dopo il 1924. Anzi, la signorina D.
non accennò neppure a questi attacchi quando la vidi per la prima
volta, e fu soltanto in seguito, allorché fu interrogata più
particolareggiatamente prima della somministrazione della L-dopa,
che ricordò quegli episodi di mezzo secolo addietro.
Dopo l'ultima crisi respiratoria, ebbe la prima delle sue crisi
oculogire, le quali in realtà continuarono a essere il suo unico sintomo
postencefalitico per venticinque anni (1925-49): conduceva una vita
attiva e piena di soddisfazioni, lavorando come segretaria in uno
studio legale, partecipando a comitati che si occupavano di attività
mondane e civiche, eccetera. Aveva un'esistenza piena, con molte
amicizie e frequenti inviti; amava il teatro e leggeva con passione,
raccoglieva ceramiche antiche e così via. Dotata, simpatica, energica,
emotivamente ben integrata, la signorina D. non presentava quindi
alcun segno di quel «deterioramento» che si diceva così comune dopo
una grave encefalite del tipo ipercinetico Circa vent'anni fa, la
signorina D. incominciò a manifestare una serie di sintomi più sinistri,
in particolare una tendenza a bloccarsi di colpo nei movimenti e nella
parola, e una tendenza opposta ad affrettarsi nel camminare, nel
parlare, nello scrivere. Quando nel 1969 la interrogai per la prima
volta circa i suoi sintomi, mi diede la seguente risposta: «Ho vari
sintomi banali che lei può vedere da sé. Ma il mio sintomo "essenziale"
è che non posso incominciare un'azione e non posso smettere. O sono
tenuta ferma, o sono costretta ad accelerare. Mi sembra di non aver
più stati intermedi». La frase riassume con perfetta precisione i
sintomi paradossali del parkinsonismo. E' istruttivo, pertanto,
osservare che in assenza dei sintomi «banali» (ad esempio rigidità,
tremore, eccetera, che si fecero evidenti solo nel 1963), non si era
giunti a diagnosticare il parkinsonismo, ma era stato formulato un
gran numero di altre diagnosi (quali «catatonia», «isteria» e altre). La
signorina D. fu finalmente riconosciuta come parkinsoniana nel 1964.
Le crisi oculogire, per tornare a questo sintomo cardinale, furono
inizialmente di forte intensità: si presentavano molte volte al mese e
duravano fino a quindici ore. Nello spazio di pochi mesi dal loro primo
verificarsi, assunsero un carattere di notevole periodicità,
presentandosi «con la puntualità di un orologio» ogni cinque giorni,
tanto che essa poteva fare programmi con mesi di anticipo, nella
consapevolezza che avrebbe inevitabilmente avuto una crisi ogni
cinque giorni, e solo in pochissime occasioni in altri momenti. Queste
rare deviazioni dal programma erano solitamente collegate a episodi di
grande irritazione o dolore. Le crisi si scatenavano repentinamente,
senza preavviso; il suo sguardo era costretto dapprima a fissarsi a terra
o lateralmente, a sinistra o a destra, per parecchi minuti, e quindi a un
tratto gli occhi ruotavano verso l'alto e in tale posizione restavano fino
alla fine dell'attacco. In quelle occasioni, dichiarò lei stessa, la sua
faccia assumeva «un'espressione fissa di rabbia o di paura», benché lei
non provasse né rabbia né paura.
Durante le crisi le riusciva difficile muoversi, la sua voce era
anormalmente bassa e i suoi pensieri parevano «incepparsi»; provava
sempre una «sensazione di resistenza», di una forza che si opponeva al
movimento, alla parola e al pensiero. Durante l'attacco si sentiva
sempre estremamente vigile e le era impossibile dormire; allorché la
crisi si avviava alla fine, incominciava a sbadigliare e avvertiva una
profonda sonnolenza; la crisi finiva all'improvviso, con ritorno alla
normalità delle capacità di movimento, di parola, di pensiero (la
signorina D., enigmista appassionata, definiva questo ritorno alla
coscienza normale «resipiscenza»). Oltre a queste classiche crisi
oculogire, incominciò ad avere, dopo il 1955, numerose crisi di tipo
differente; la deviazione forzata degli occhi divenne eccezionale, e fu
sostituita da fissità e impietrimento dello sguardo; alcuni di questi
attacchi erano di una forza inaudita, tale da privarla completamente
della capacità di muoversi e di parlare, e duravano fino a tre giorni.
Nel corso degli Anni Sessanta fu più volte ricoverata in un ospedale
municipale, dopo esser stata trovata dai vicini in preda a un attacco, e
fu esibita, durante le riunioni mediche per l'esame di casi clinici, come
un eccezionale caso di «catatonia periodica». A partire dal 1962, ebbe
anche attacchi di fissità oculare brevi, della durata di pochi minuti,
durante i quali si bloccava e si sentiva «in trance». Un altro sintomo
parossistico era costituito da crisi di rossore e sudorazione, a
comparsa irregolare e di durata variabile da quindici a trenta minuti
(era entrata definitivamente in menopausa intorno al 1945). Dal 1965,
la fissità dello sguardo e le crisi oculogire erano diventate blande e
infrequenti, e quando fu ammessa al Mount Carmel Hospital, all'inizio
del 1969, non ne aveva più avute da oltre un anno, e seguitò a non
esserne colpita fino all'inizio della somministrazione di L-dopa nel
giugno del 1969.
Rigidità e tremore avevano fatto la loro comparsa, come si è già
detto, nel 1963, ma i sintomi più invalidanti per lei, quelli che alla fine
imposero il suo ricovero in un ospedale per malattie croniche, erano i
seguenti tre: una progressiva flessione e distonia del collo e del tronco,
una festinazione incontrollabile con costrizione a correre, avanti o
indietro, e un invincibile «congelamento» che a volte la bloccava nelle
posizioni più strane e scomode per ore e ore.
Un ulteriore sintomo relativamente recente, per il quale non fu
possibile trovare un'eziologia infettiva locale, era costituito dalla
pollachiuria e dal relativo stimolo; a volte quest'ultimo accompagnava
o provocava un «blocco» o una «riluttanza» alla minzione: un
intollerabile accoppiamento di stati contrapposti.
Alla sua ammissione al Mount Carmel nel gennaio del 1969, la
signorina D. poteva camminare liberamente aiutandosi con due
bastoni, e su brevi distanze anche senza sostegno; ora dal giugno di
quell'anno era diventata praticamente incapace di camminare da sola.
La sua postura, già curva al momento del ricovero, si era aggravata nel
corso dei sei mesi successivi fin quasi a piegarla in due. Spostarsi dal
letto alla sedia le era diventato impossibile, così come voltarsi nel letto
o tagliarsi il cibo. Alla luce di questo deterioramento piuttosto rapido e
dell'inutilità di tutti i farmaci antiparkinsoniani convenzionali, l'arrivo
della L-dopa si verificò in un momento critico per la signorina D., che
tutto pareva ormai condannare a un declino sempre più rapido e
irrevocabile.
"Prima della L-dopa".
La signorina D. era piccola, minuta, curva, così cifotica che,
quand'era in piedi, il suo sguardo era forzatamente rivolto a terra.
Era in grado di alzare la testa, ma nel giro di pochi secondi questa
tornava alla posizione abituale di estremo emprostotono, con il mento
inchiodato allo sterno. Questa postura non trovava spiegazione in una
particolare rigidità dei muscoli cervicali: la rigidità non era accresciuta
che in modesta misura nel collo, e durante le crisi oculogire la testa era
costretta ad arrovesciarsi in modo altrettanto eccessivo quanto la
abituale curvatura in avanti.
Si notava un aspetto a maschera alquanto marcato: la sua vivacità e
l'espressione dei suoi stati emotivi erano trasmesse quasi
esclusivamente dagli occhi mobili e allegri, così in contrasto con la
maschera rigida del viso. L'ammiccamento spontaneo era raro. La voce
era chiara e intelligibile, benché fosse monotona nel volume e nel
timbro, mancasse di intonazioni e inflessioni «personali», e solo
momentaneamente riuscisse ad alzarsi al di sopra di un mormorio, di
un'intensità ipofonica smorzata; di tanto in tanto vi erano improvvise
festinazioni vocali, accelerati flussi di parole che terminavano in uno
«schianto» verbale alla fine di una frase.
Gli altri movimenti volontari, come quelli della fonazione, erano
caratterizzati dalla contraddizione acinesia-ipercinesia, fenomeni
alternantisi o paradossalmente simultanei.
Molti movimenti delle mani presentavano acinesia, con debolezza,
scarsità, eccessivo sforzo e decadimento alla ripetizione dei movimenti
stessi. La scrittura, una volta avviata, era larga, priva di sforzo e
rapida, ma se essa si sovreccitava, sfuggiva al suo controllo, e
diventava più larga, rapida e violenta fino a coprire l'intero foglio di
ampi segni a spirale e di scarabocchi, oppure rimpiccioliva, rallentava
e si impuntava fino a ridursi a un punto immobile. La signorina D.
poteva alzarsi dalla sedia senza alcun impedimento, ma una volta
alzatasi in genere si «congelava», spesso per molti minuti, incapace di
muovere il primo passo. In quelle occasioni presentava una fissità di
postura quasi catalettica, quasi piegata in due, che ricordava la fissità
di un film arrestato in pieno scorrimento. Una volta fatto il primo
passo (e l'avvio poteva avvenire in seguito a una piccola spinta da
dietro, a un comando verbale da parte dell'esaminatore, o a un
comando visivo sotto forma di un bastone, un pezzo di carta o altra
presenza chiara posta sul pavimento e da scavalcare), essa avanzava
traballando e con passetti corti e rapidi. Sei mesi prima, al ricovero,
quando camminare le era decisamente più facile, la festinazione era
stata un problema molto serio, tendendo sempre (come le sue
galoppate verbali e l'accelerazione degli scarabocchi) a concludersi in
modo catastrofico.
In notevole contrasto con tutto ciò stava la sua ottima capacità di
salire le scale con grande equilibrio e stabilità. Ogni gradino forniva lo
stimolo per un nuovo passo, ma una volta raggiunto il pianerottolo,
essa si trovava nuovamente «congelata» e incapace di procedere.
Spesso osservava che «se il mondo fosse fatto a scale», lei non avrebbe
avuto nessunissima difficoltà a muoversi (1). La pulsione in qualsiasi
direzione (propulsione, lateropulsione, retropulsione) poteva essere
provocata con pericolosa facilità. Una grave e protratta immobilità
tendeva inoltre a verificarsi allorché si rendeva necessario un qualsiasi
cambiamento di attività: ciò era soprattutto evidente nella
deambulazione, quando essa doveva girarsi, ma si presentava anche,
occasionalmente, quando doveva spostare lo sguardo da un punto
all'altro, o l'attenzione da un'idea a un'altra.
Rigidità e tremore non rivestivano particolare importanza nel
quadro clinico. Un tremore grossolano (a battito d'ala) della mano
destra si presentava, abbastanza di rado, per reazione a una tensione
fisica o emotiva: tipicamente, tendeva a manifestarsi in concomitanza
con il futile e affliggente sforzo del «congelamento», dell'invincibile
immobilità. Vi era ipertonia lieve del braccio sinistro, e ipertonia
marcata («emiplegica») delle gambe. Vi era anche un accenno di
ipereflessia e spasticità nel lato sinistro del corpo. Il quadro clinico era
completato da tutta una serie di movimenti involontari e ipercinesie. I
muscoli intorno alla bocca presentavano brusche contrazioni, con
occasionale increspatura e protrusione delle labbra.
Ogni tanto essa digrignava i denti e faceva movimenti masticatori.
Non aveva mai la testa del tutto immobile; la dondolava su e giù, come
per annuire, in modo irregolare. Questi movimenti della bocca e del
capo si accentuavano, sincineticamente, durante lo sforzo. A intervalli
più o meno regolari, forse cinque o sei volte all'ora, essa era costretta,
come per un tic, a eseguire un'improvvisa e profonda inspirazione. Un
residuo dell'originaria irrequietezza e acatisia era osservabile
nell'incessante movimento della mano destra, una forma di
irrequietezza localizzata che si placava solo quando le mani erano
altrimenti occupate.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :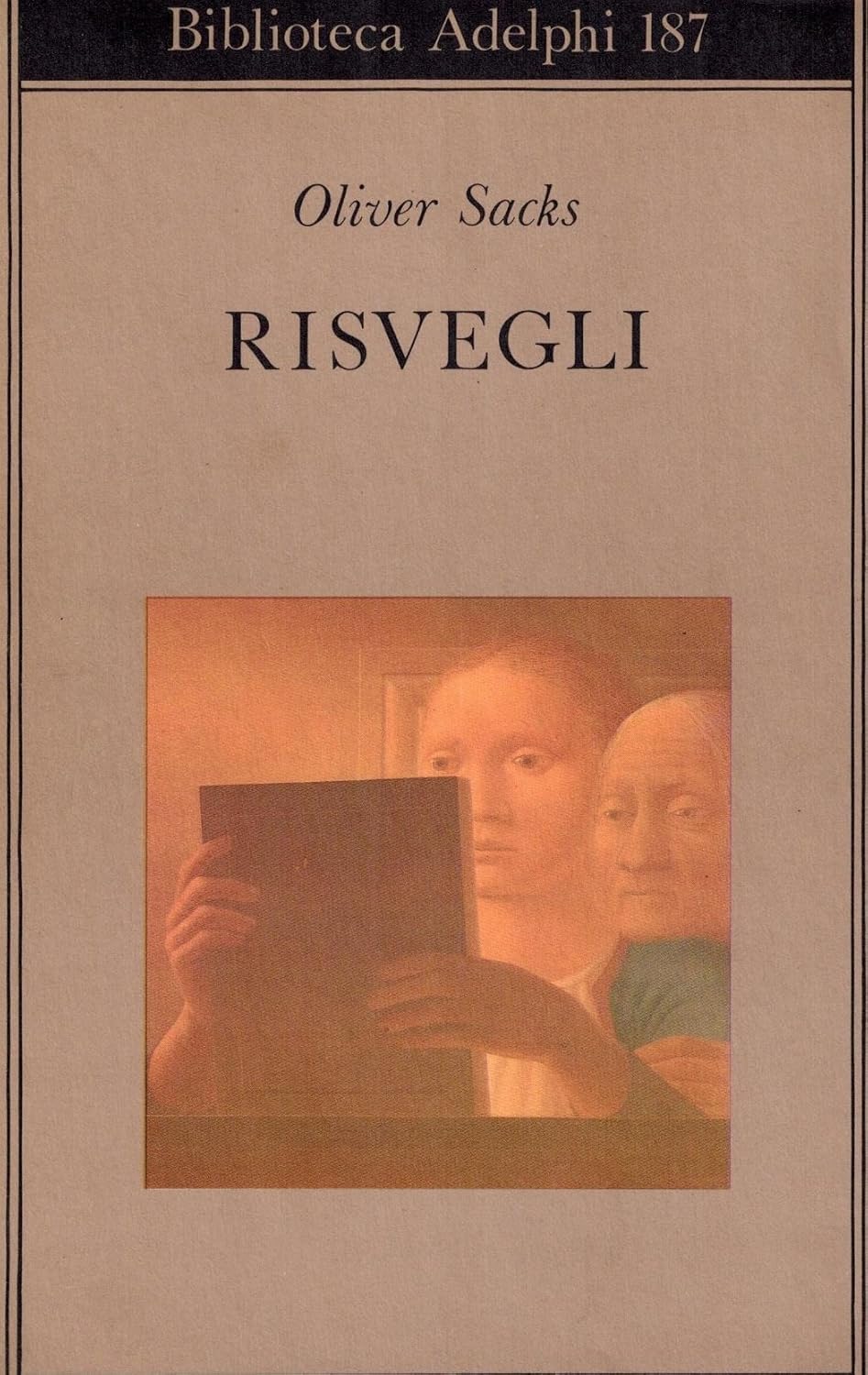





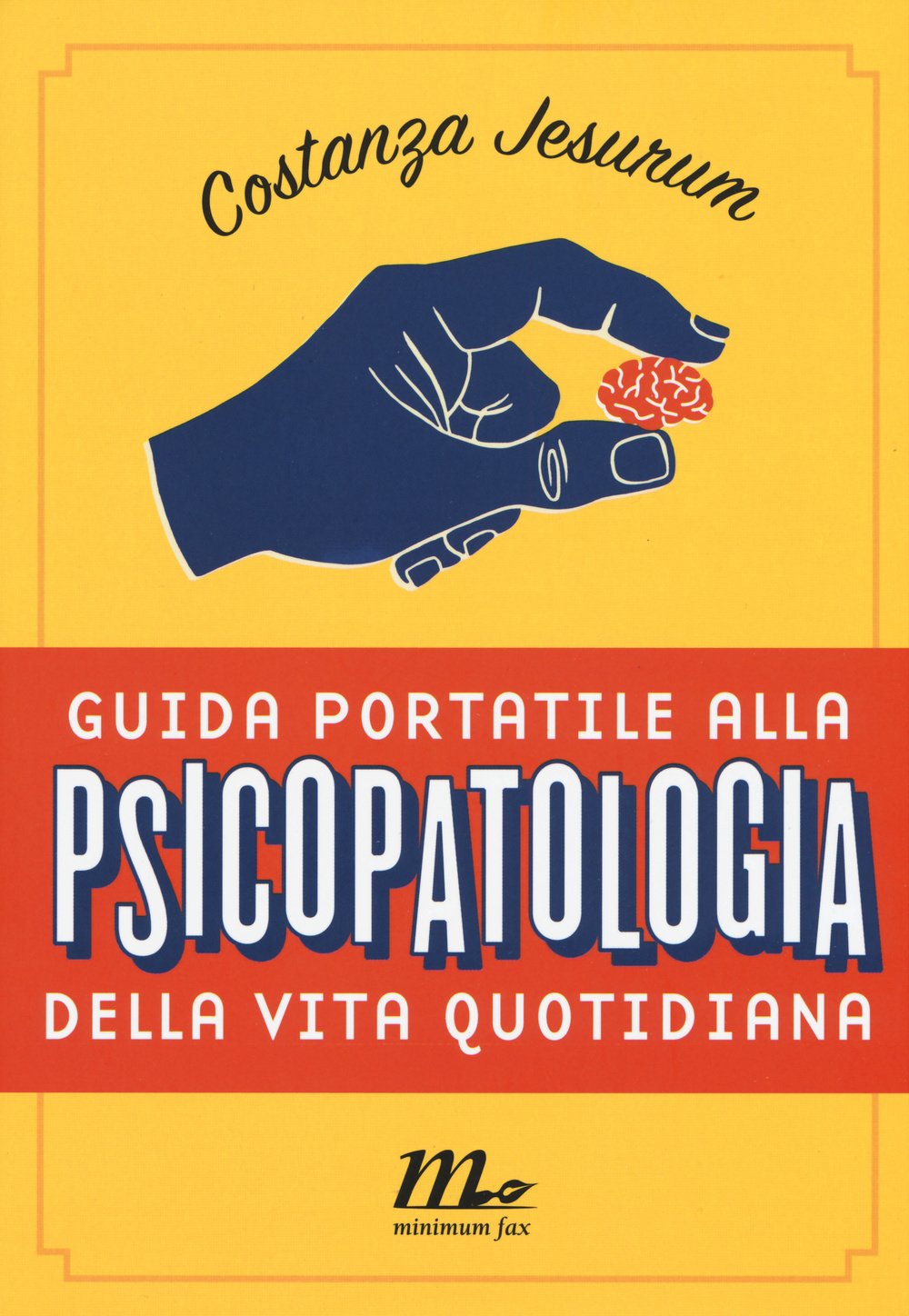
Commento all'articolo