In presenza di Schopenhaue – Michel Houellebecq

SINTESI DEL LIBRO:
Il mondo è la mia rappresentazione
Questa proposizione è una verità per ogni essere vivente e pensante, anche se
solo l’uomo può portarla allo stato di conoscenza astratta e ponderata. Se lo fa
realmente, si può dire che in lui è maturato lo spirito filosofico. Allora possiede
la completa certezza di non conoscere né un sole né una terra, ma soltanto un
occhio che vede un sole, una mano che tocca una terra.1
Schopenhauer è rimasto famoso soprattutto per la sua potente descrizione
della tragedia della volontà, e questo, purtroppo, ha avuto la conseguenza di
avvicinarlo alla categoria dei romanzieri o, peggio ancora, degli psicologi, e
di allontanarlo da quella dei “veri filosofi”. Eppure in lui c’è chiaramente ciò
che è impossibile trovare in Thomas Mann, e ancor meno in Freud: un
sistema filosofico completo, con l’ambizione di rispondere all’insieme delle
domande (metafisiche, estetiche, etiche) poste dalla filosofia sin dalle
origini.
“Il mondo è la mia rappresentazione”: come prima frase di un libro, è
difficile trovarne una più schietta, più sincera. Di questa prima
proposizione, Schopenhauer fa il punto di partenza dello spirito filosofico: è
evidente che in lui la filosofia non ha come origine la morte. In seguito
ammetterà che la coscienza del nostro trapasso è un potente stimolo per la
ricerca della verità o, quantomeno, per la pubblicazione di opere che
manifestino tale obiettivo (in realtà è uno stimolo praticamente per tutto);
ma l’origine primaria di ogni filosofia è la consapevolezza di uno iato, di
un’incertezza nella nostra conoscenza del mondo. La filosofia di
Schopenhauer è innanzitutto un commento sulle condizioni della
conoscenza: un’epistemologia.
Già il nostro stesso corpo è un oggetto e, da questo punto di vista, una
rappresentazione. Esso, infatti, non è altro che un oggetto tra gli oggetti,
sottoposto alle leggi che si applicano agli oggetti; è solo un oggetto immediato.
Come ogni oggetto intuibile, è sottoposto alle condizioni formali di ogni
conoscenza, il tempo e lo spazio, da cui deriva la pluralità.2
C’è qualcosa di confortante nel considerare il nostro corpo come un oggetto
immediato; e di inquietante nel considerare la pluralità, inesauribile fonte di
problemi nella pratica, come una conseguenza delle condizioni formali della
conoscenza; soprattutto quando si sa (e sarà merito del XX secolo averlo
dimostrato) che tali condizioni sono prive dell’inamovibilità attribuita loro
da Kant.
La gravità, invece, a parte talune eccezioni, va attribuita alla conoscenza a
posteriori, contrariamente all’opinione di Kant, che, nei suoi Principi
metafisici della scienza della natura, la considera conoscibile a priori.3
Oggigiorno conosciamo particelle prive di massa, ossia libere dall’azione
della gravità; conosciamo geometrie non euclidee eccetera. In sintesi,
l’uomo è riuscito, non senza fatica, a superare le condizioni a priori della
conoscenza secondo Kant; quelle che per lui escludevano ogni metafisica.
Esistono sì condizioni, definite dal nostro cervello; ma sono estremamente
variabili. E questo, per così dire, ha reso la metafisica doppiamente
impossibile.
L’apprendimento della visione da parte dei bambini e dei ciechi-nati una volta
operati, la visione unica nonostante la percezione doppia degli occhi, la visione
doppia o il doppio tatto causati dall’alterazione degli organi sensoriali rispetto
alle condizioni abituali, la percezione degli oggetti raddrizzata laddove la loro
immagine nell’occhio è capovolta, la creazione dei colori, funzione meramente
interna, la separazione delle luci polarizzate, che è un’attività dell’occhio, e
infine l’esperienza dello stereoscopio: tutti questi fatti sono altrettante prove
certe e inconfutabili di come l’intuizione non sia meramente sensibile e sia
invece intellettuale, ossia consista nella conoscenza della causa tramite l’effetto
per mezzo dell’intelletto, e conseguentemente presupponga la causalità, dalla
quale ogni intuizione, dunque ogni esperienza, deriva la sua prima e totale
possibilità. La causalità, pertanto, non deriva dall’esperienza come vorrebbe lo
scetticismo di Hume, che qui viene confutato.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
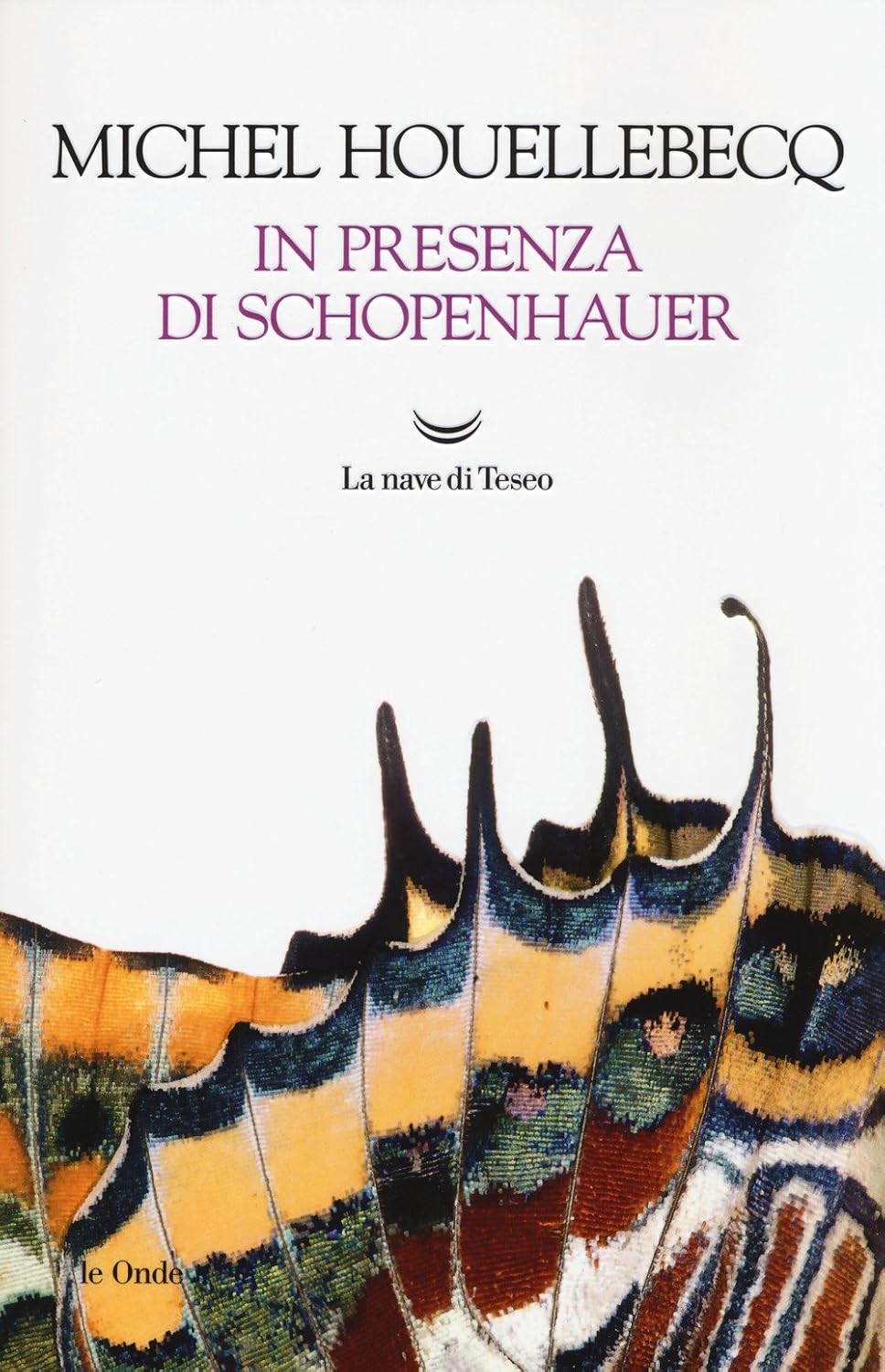






Commento all'articolo