Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo – Francesco Filippi
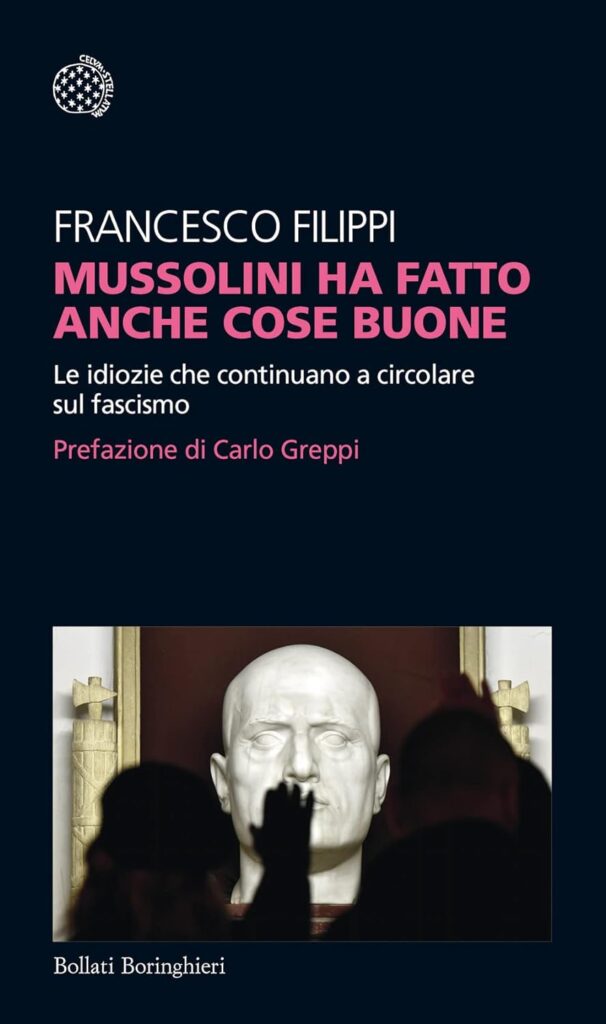
SINTESI DEL LIBRO:
Carlo Greppi (Torino, 1982), storico e scrittore, ha collaborato con Rai Storia,
organizza viaggi della memoria con l’associazione Deina ed è membro del Comitato
scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, che coordina la rete degli Istituti per
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia. I suoi ultimi libri sono 25
aprile 1945 (2018), L’età dei muri. Breve storia del nostro tempo (2019), e la curatela
(con D. Bidussa) di Ferruccio Parri, Come farla finita con il fascismo (2019). Per
Bollati Boringhieri ha curato e tradotto il libro di Piotr M.A. Cywiński, Non c’è
una fine. Trasmettere le memorie di Auschwitz (2017).
Quando c’era Lui
A sessantacinque anni dalla caduta del nazismo, sfaldatosi tra le macerie di
un’Europa in ginocchio di fronte alle sue decine di milioni di morti, il Museo
di Storia tedesca di Berlino inaugurava la mostra Hitler e i tedeschi.
Collettività nazionale e crimine. Era un percorso stupefacente, che tra
documenti di ogni genere illuminava la relazione tra la capacità seduttiva del
Führer e la sua presa letale sulla società tedesca degli anni trenta e quaranta.
Tra le scoperte più sconvolgenti in cui inciampava il visitatore c’era
indubbiamente lo svelamento dell’enorme diffusione che il Mein Kampf – il
“manifesto” di Hitler edito nel 1925 e ristampato in continuazione – aveva
avuto a partire dalla sua pubblicazione.
1 Quel libro era un tentativo di
imporre alla Germania, e al “Reich millenario”, la visione del mondo del suo
leader. Nel dopoguerra quella visione è stata invece annichilita da un
notevole sforzo di “fare i conti” con il nazismo, inchiodato alle sue
responsabilità storiche, agli incontrovertibili fatti che sono emersi a ondate –
dai processi di Norimberga in avanti –, affiancandosi a grandi narrazioni che
hanno sottratto argomenti ai nostalgici, mostrando la spietatezza che l’ascesa
di «Er» – il «Lui» tedesco – aveva riversato sulla Germania, sull’Europa e sul
mondo intero. Ispirandosi esplicitamente al nostro «Lui», Benito Mussolini.
È inutile negare l’effetto straniante che può generare, su un uomo e una
donna del ventunesimo secolo, quel gesticolare eccessivo comune a entrambi
i dittatori, quella retorica gridata, furibonda e pervasiva, ma questo non rende
una sua eventuale riproposizione meno pericolosa o meno attuale. Lo ha
evidenziato il successo di pubblico dello strepitoso romanzo satirico Lui è
tornato di Timur Vermes (2012), che due anni dopo la mostra Hitler e i
tedeschi immaginava un Führer risvegliatosi in carne e ossa nella Berlino del
nostro tempo, un Führer che si rende conto in fretta di quanto possa essere
facile reinterpretare – letteralmente – gli slogan dei fascismi e conquistare
ancora le coscienze dei nostri contemporanei. Nella capitale tedesca, ancora
nel 2013, il chiaroscuro dei baffi di Hitler campeggiava sugli scaffali delle
librerie che espongono la vetta delle classifiche, ed era forse naturale che quel
successo avrebbe dato i suoi frutti e stimolato adattamenti. L’omonimo film
che ne è stato tratto nel 2015 ha infatti avuto un tentativo di emulazione
anche in Italia, con il remake nostrano Sono tornato (2018), che si è però
rivelato un timido fuoco di paglia nel dibattito pubblico italiano sul fascismo.
Ma questo scorcio di anni duemila è particolarmente fertile per ravvivare i
nostri “conti con il fascismo”: evocato dai politici e dai media, nel mirino di
continue polemiche sui suoi luoghi simbolici e sui suoi monumenti, il
fascismo pare essere sempre nei nostri pensieri.
2
Uno degli esempi più graffianti, collocato idealmente sullo stesso scaffale
di Lui è tornato ma più irriverente e dissacrante, è il magistrale Quando c’era
LVI di Daniele Fabbri, Stefano Antonucci e Mario Perrotta (2017), uscito
inizialmente in fumetteria e poi in volume unico, la cui diffusione – almeno
in principio – rimane comunque ascrivibile al circuito dell’underground;
un’operazione che in qualche modo evoca gli sketch di Fascisti su Marte di
Corrado Guzzanti e il film derivato (2006), che trovate citato anche in questo
libro. Quando c’era LVI è una riuscitissima parodia in cui Mussolini torna tra
noi, ancora una volta, «ma è negro», e nella copertina del fascicolo n. 1 è
ritratto a testa in giù mentre fa il saluto romano. L’opera nel suo complesso e
il rimando a Piazzale Loreto furono subito interpretati come “provocazioni”
degne di un raid punitivo in salsa social: la presentazione delle prime tavole
alla fiera Romics di Roma del 2016 ha suscitato l’intrepida reazione di
Davide Di Stefano, dirigente di Casapound, che (filmandosi, tronfio e
divertito) fingendo di inciampare ha versato un bicchiere di Coca-Cola sullo
stand responsabile di aver pubblicato «quel fumetto demmerda».
3 Corre ai
ripari «Il primato nazionale», il “quotidiano sovranista” (sic!) che
ridimensiona l’accaduto e specifica che «altro non si è trattato che di uno
scherzo, di una goliardata» (termine alquanto ricorrente nel giustificare
l’operato dei neofascisti), ma i commenti dei “camerati” non sono sempre
dello stesso tenore. Tale “antonio”, per esempio, scrive in calce al pezzo: «Ha
fatto bene, io ci pisciavo sopra ai libri dei porci antifascisti».
4
Ecco, cari neofascisti del terzo millennio e cari nazionalisti che guardate
con nostalgia a una delle epoche più buie della storia contemporanea: questo
è un libro sul quale proverete a versare ogni forma di liquido, perché queste
pagine scavano e svelano, scardinano e colpiscono dritto nel segno. Arrivano
al bersaglio grosso, senza tentennamenti. Perché a quasi cento anni dal suo
avvento, il tempo del fascismo “all’acqua di rose”, guidato da un leader che
aveva a cuore il proprio popolo e l’umanità intera, dispensatore di felicità e
benessere, deve finire.
Una cosa buona
Il libro che avete tra le mani – agile, a tratti giustamente canzonatorio, ma
serissimo – si colloca sulla scia di una serie di importantissimi lavori che
nell’ultimo quarto di secolo hanno provato a decostruire tutta una serie di
“miti”, del tutto slegati dalla realtà storica, che ammorbano l’Italia dagli anni
venti del Novecento, dimostrando come le loro matrici vadano cercate,
appunto, alla radice. Risalendo la corrente, come i grandi storici sanno fare.
Per citare solo tre volumi ormai classici, è il caso de Il mito del bravo
italiano di David Bidussa (1994), del fortunatissimo Italiani brava gente? di
Angelo Del Boca (2005) e del volume dal titolo provocatoriamente manicheo
Il cattivo tedesco e il bravo italiano di Filippo Focardi (2013), che ci mostra
come già durante il conflitto 1940-1945 il mondo della cultura e quello della
politica si fossero adoperati in uno sforzo convergente. Prefiggendosi
l’obiettivo di riabilitare l’Italia sulla scacchiera internazionale, avevano
riabilitato, in sostanza, il fascismo stesso, che aveva guidato il paese con il
pugno di ferro nel ventennio precedente. Per aggiungere un tassello a questa
incompleta ricognizione, a proposito delle responsabilità della “guerra
fascista”, l’editore che ha il merito di dare oggi alle stampe Mussolini ha fatto
anche cose buone aveva già pubblicato, nel 2003, una pietra miliare quale Il
nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista,
1940-1943 di Davide Rodogno, un saggio che di balbettii giustificatori,
rispetto alla guerra di aggressione fascista, non ne aveva.
5 Molti dei volumi
che di recente hanno contribuito a smascherare le menzogne del e sul
ventennio li trovate qui nella bibliografia e nei riferimenti mirati: da La
macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista di Guido Melis
(2018) a Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura corruzione affarismo (a
cura di Paolo Giovannini e Marco Palla, 2019), da Il massacro di Addis
Abeba. Una vergogna italiana di Ian Campbell (2018) – un volume che
l’autore di questo libro ha fortemente voluto portare in Italia – ad alcune delle
ultime opere di Emilio Gentile, va ribadito come gli storici, costantemente
ripresi in queste pagine, abbiano prodotto un incessante lavorio di
demolizione del “mito” del fascismo buono. Ma, come si dice, non c’è più
sordo di chi non vuol sentire.
Quando, mesi fa, Francesco Filippi ha inviato la «breve raccolta di bufale
fasciste» ai soci fondatori dell’associazione Deina, si trattava di un agile
vademecum di 35 pagine per i tutor che ogni anno accompagnano con noi
migliaia di ragazzi sui luoghi della memoria europei. Era uno strumento
educativo, efficace e tagliente, che in poche parole e senza fronzoli dava alla
nostra squadra di formatori elementi conoscitivi volti a smontare, fonti alla
mano, le idiozie che continuano a circolare sul ventennio. Come qui scrive
Francesco nei ringraziamenti, l’input era arrivato proprio da uno di loro,
Giosuè. L’idea di farne un libro, partendo da quella che abbiamo prontamente
definito “La Matrice”, è corsa così in parallelo al dibattito scatenato
dall’uscita del criticatissimo Istruzioni per diventare fascisti di Michela
Murgia e del romanzo documentario di Antonio Scurati M. Il figlio del secolo
che, ancora una volta, provocava nel paese una serie di reazioni – perplessità
ed elogi, entusiasmi e isterismi – le quali, più che rivolte al volume in sé
(primo di un’annunciata trilogia), sembravano agitarsi intorno al Capo, al suo
irrisolto collocamento nella storia d’Italia, al suo costante difendere un ruolo
tutto sommato di prestigio, di presenza statuaria, di ragion d’essere in un
paese che oggi di nuovo si fa abbindolare dalla forza seduttiva dell’“uomo
forte”, inseguendo «balle» e «leggende» – riprendo lemmi scelti da Francesco
– che riabilitano Mussolini e il suo operato. Perché «pensare un ipotetico
passato positivo», ci mette in guardia Francesco, «lascia una speranza
nell’animo di chi è scontento del proprio presente».
«Molte delle bufale sul fascismo», scrive ancora Francesco in apertura di
questo libro, «nacquero dal fascismo stesso», ed è questo, credo, il fil rouge
che tiene insieme ogni suo capitolo. Il problema, al di là delle giustificate
preoccupazioni per le derive autoritarie del presente, è che il fascismo,
quell’«oggetto dotato di tratti peculiari»
6 non esattamente replicabili, è
un’esperienza conclusa, finita. Come ha sottolineato efficacemente un
articolo de «Linkiesta», che rifletteva sull’uscita in sala del remake Sono
tornato, la questione di fondo, però, «è che non se n’è mai andato»
7 per
davvero.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :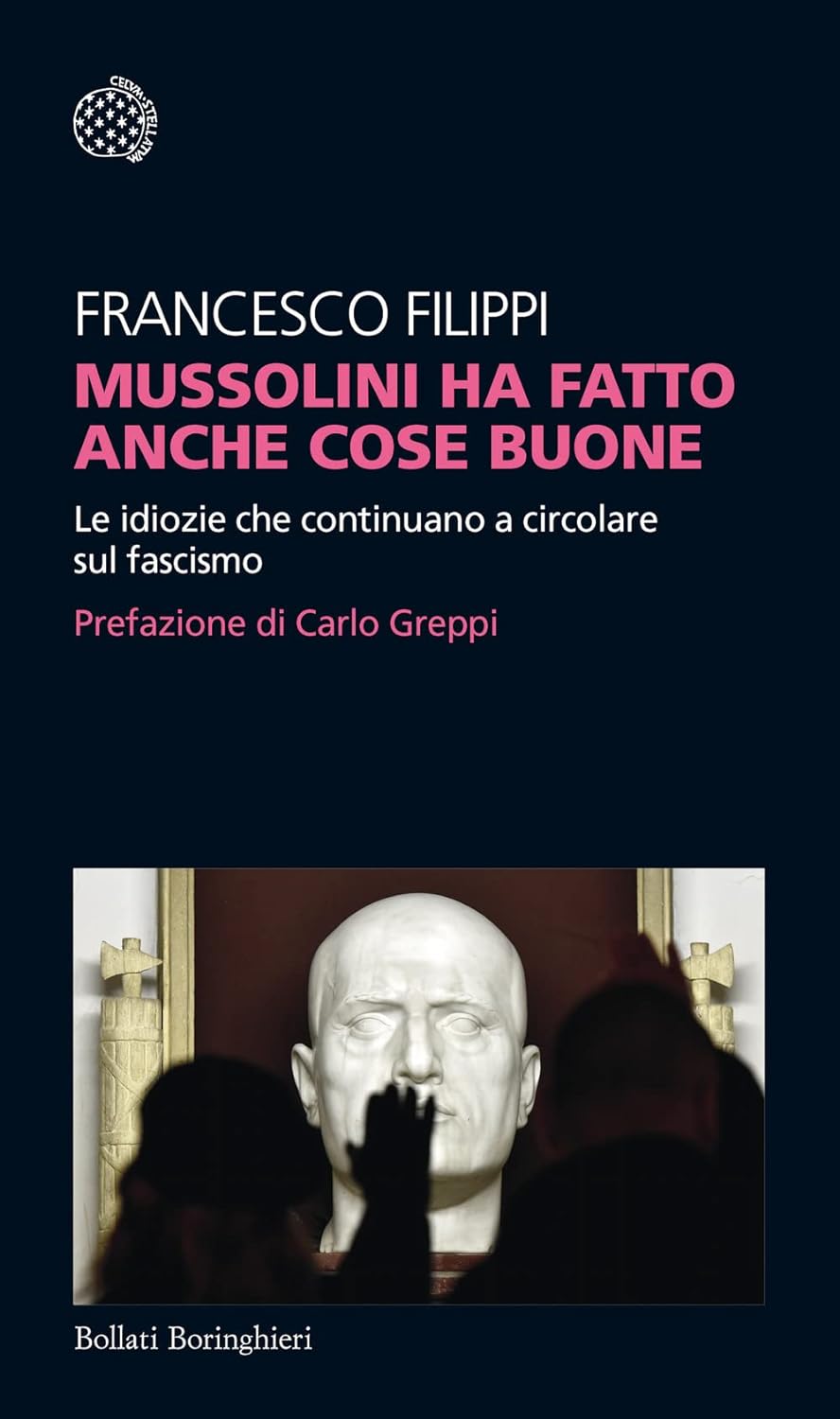






Commento all'articolo