Luoghi selvaggi: In viaggio a piedi tra isole, vette, brughiere e foreste – Robert Macfarlane
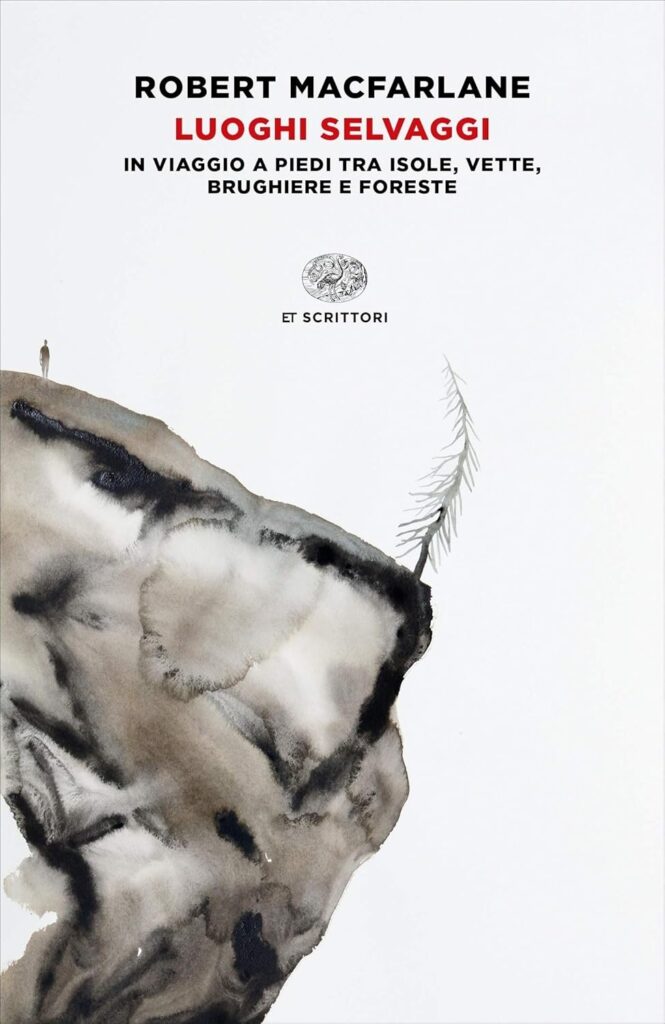
SINTESI DEL LIBRO:
Si stava alzando il vento, perciò andai nel bosco. È a sud della città, a un
chilometro e mezzo da casa: un esiguo frammento di faggeto senza nome in
cima a una collinetta. Ci arrivai a piedi, seguendo prima strade di periferia e
poi sentieri orlati di campi tra siepi di biancospino e nocciolo.
Nell’aria sopra gli alberi battibeccavano le cornacchie. Il cielo era di un
azzurro freddo e luminoso, con i bordi sfumati color del latte. A tre quarti del
cammino mi giunse nel vento il rumore del bosco; un dolce ruggito marino.
Era l’immenso e composito rumore dell’attrito – di foglia che sfrega foglia, di
ramo che struscia ramo.
Entrai nel faggeto dall’angolo sud. Dalla volta agitata iniziavano a piovere
detriti: bacche e rametti che picchiettavano sullo strato brunito di foglie. I
raggi del sole cadevano al suolo in baldorie di luce. Risalii il bosco e a metà
del margine a nord trovai il mio albero, un alto faggio con la corteccia grigia
e i rami aperti, facili da scalare.
L’avevo scalato molte volte e ogni suo segno mi era familiare. Attorno
alla base del tronco la corteccia, deformata e raggrinzita, assomiglia alla pelle
di una zampa d’elefante. A circa tre metri un ramo si piega bruscamente su di
sé; subito sopra, la lettera «acca» incisa anni fa da un coltello si è dilatata con
il crescere dell’albero; piú sopra ancora sporge il moncone guarito di un ramo
mancante.
A nove metri da terra, quasi sulla punta, dove la corteccia si fa piú liscia e
argentata, raggiunsi il posto che nel tempo avevo battezzato «l’osservatorio»:
è un ramo laterale che nasce sotto un’ansa del tronco e si biforca. Avevo
scoperto che, se mi mettevo con la schiena contro il tronco e i piedi sui due
rebbi della forca, potevo starci comodo. Se rimanevo immobile per qualche
minuto i gitanti a volte passavano sotto senza notarmi. Normalmente, la gente
non si aspetta di vedere uomini sugli alberi. Se continuavo a stare immobile
tornavano gli uccelli. Normalmente, neppure gli uccelli si aspettano di vedere
uomini sugli alberi. Merli affaccendati sullo strame di foglie; scriccioli che
frullavano rapidi di frasca in frasca, come teletrasportati; una pernice grigia,
una volta, si era avventurata timorosa allo scoperto.
Mi piazzai nell’osservatorio. Peso e movimenti avevano fatto tremare
l’albero e il vento amplificò il tremito, cosí che presto la cima del faggio si
mise a stridere avanti e indietro, descrivendo archi di cinque-dieci gradi. Non
un osservatorio, quel giorno; piú che altro un nido di corvo, una coffa in testa
d’albero su un flutto marino.
Da quell’altezza il paesaggio si spiegava sotto di me come una mappa.
Sparsi da un capo all’altro c’erano altri frammenti di terreni boschivi, di cui
sapevo qualche nome: Mag’s Hill Wood, Nine Wells Wood, Wormwood. A
ovest, tra le coste di velluto dei campi, correva una grossa arteria affollata di
macchine. Subito a nord c’era l’ospedale, con i tre tubi dell’inceneritore che
svettavano ben al di sopra del mio albero sulla collina. Un Hercules panciuto
stava planando verso l’aeroporto alla periferia della città. Sul ciglio di una
strada a est vidi un gheppio cavalcare il vento, le ali vibranti per lo sforzo, le
penne caudali aperte come una mano di carte.
Ad arrampicarmi sugli alberi avevo cominciato circa tre anni prima. O
meglio, avevo ricominciato. Nella mia vecchia scuola al posto del cortile
c’era un boschetto. Avevamo scalato e battezzato i diversi alberi (Scorpione,
Quercia Grande, Pegaso) e ci sfidavamo per il loro controllo in conflitti
territoriali regolati da norme e alleanze complicate. In giardino mio papà
aveva costruito per me e mio fratello una casa sugli alberi, che fu difesa con
successo da anni di attacchi corsari. Verso i trent’anni avevo ripreso le mie
scalate arboree. Solo per il gusto di farlo: niente corde, e neppure rischi.
Arrampicandomi, imparai a discernere tra le varie specie. Mi piacevano
l’elasticità flessuosa delle betulle bianche, gli ontani e i ciliegi giovani.
Evitavo i pini – rami fragili, corteccia callosa – e i platani. E avevo scoperto
che l’ippocastano, con il tronco in basso privo di rami e un frutto spinoso, ma
anche un enorme ombrello di fronde, era prodigo di ostacoli e di incentivi.
Mi tuffai allora nella letteratura sull’arrampicata arborea: non immensa,
certo, ma quante emozioni! Durante una tempesta californiana John Muir
aveva scalato un abete Douglas di trenta metri, gettando lo sguardo su una
foresta «la cui intera massa si era accesa in un unico ininterrotto fulgore di
bianco fuoco solare!» Italo Calvino aveva scritto il suo magico romanzo, Il
barone rampante, dove il giovane eroe, Cosimo, in uno scatto d’ira
adolescenziale, si arrampica su un albero della tenuta boschiva paterna e
giura di non mettere piú piede a terra. Mantiene l’irruente parola e finisce per
vivere e addirittura sposarsi tra le fronde, spostandosi per chilometri tra olivi,
ciliegi, olmi e lecci. C’erano poi i ragazzi del Brendon Chase di Denys
Watkins-Pitchford (alias «BB»), che piuttosto che rientrare al collegio
inselvatichiscono in una foresta e danno la scalata a un «pino scozzese» per
raggiungere un nido di falco pecchiaiolo venato di foglie di faggio. E
naturalmente c’era la squadra di Winnie the Pooh e Christopher Robin: Pooh
che si libra nell’aria su un palloncino azzurro per sgraffignare un po’ di miele
dal favo in cima alla quercia; e Christopher, pronto a far venire giú il
palloncino di Pooh con un colpo di pistola giocattolo, a impresa compiuta.
Si guadagnarono la mia ammirazione anche alcuni seri esponenti
contemporanei di questa arte silvestre, in particolare gli scienziati che
studiano le sequoie della California e dell’Oregon. La Sequoia sempervirens,
o sequoia gigante, può superare i trenta metri. L’albero adulto è un tronco per
gran parte quasi privo di rami, che si apre a un certo punto in una chioma
vasta e complessa. Le tecniche di ascesa sviluppate dai ricercatori sono
straordinarie. Usano arco e freccia per lanciare un cavo di trazione su un
saldo ramo della chioma. Poi, per mezzo del cavo, issano e fissano una fune
da arrampicata. Saliti tra le fronde, sanno servirsi delle corde in modo cosí
raffinato da riuscire a muoversi in grande libertà e sicurezza, come uomini
ragno dei nostri giorni. Lassú, in quel mondo aereo, hanno scoperto un regno
perduto: un ecosistema affascinante fino ad allora inesplorato.
Non c’era niente di unico nel mio faggio, niente di difficile nel salirlo,
nessun segreto biologico sulla sua cima, e neppure del miele. Ma era
diventato un luogo per pensare. Un posatoio. Ne ero innamorato, mentre lui –
è vero – non sapeva neanche che esistevo. L’avevo scalato molte volte; ai
primi albori, all’imbrunire, nel fulgore del mezzogiorno. L’avevo scalato in
inverno, spazzando con la mano la neve dai rami, con il legno freddo come
pietra, e veri nidi di corvo, neri, tra i rami degli alberi accanto. L’avevo
scalato all’inizio dell’estate, per scrutare dall’alto la campagna ribollente, con
il calore che rendeva l’aria gelatinosa e il sonnolento ronzio di un trattore che
giungeva al mio udito da qualche campo nei pressi. E l’avevo scalato sotto la
pioggia monsonica, con l’acqua che cadeva in bacchette cosí spesse che si
potevano vedere. Scalare l’albero era un modo per guadagnarmi un
panorama, per quanto banale; per guardare dall’alto una città che ero abituato
a guardare di fronte. Il sollievo del rilievo. Avevo dei conti in sospeso con la
città, e scalare quel faggio era soprattutto un modo per saldarli.
Chiunque abiti in una città avrà ben presente quella sensazione di esserci
stato per troppo tempo. Quella sensazione che ci danno le strade di stare in
una gola, quel senso di intasamento, quel desiderio di superfici che non siano
vetro, mattone, cemento e asfalto. Io vivo a Cambridge, in una delle regioni
piú intensivamente coltivate e densamente popolate del mondo. Strano posto
per uno che ama le montagne e la natura selvaggia. Cambridge, in termini di
tempo, deve essere lontana da ciò che convenzionalmente chiamiamo «terra
selvaggia» piú o meno quanto qualsiasi altro posto in Europa. Avverto
acutamente questa lontananza. Buone ragioni tuttavia mi trattengono: la
famiglia, il lavoro, il mio affetto per la città in sé, quel modo particolare con
cui la pietra dei vecchi edifici condensa la luce. Vivo a Cambridge, con
qualche pausa, da una decina d’anni e presumo che continuerò a farlo negli
anni futuri. E finché ci vivrò sono anche certo che sentirò l’urgenza di
recarmi nei luoghi selvaggi.
Non saprei dire adesso quando mi innamorai della selvaticità, so solo che
cosí fu e che il bisogno che ne provo resterà sempre forte in me. Da bambino,
ogni volta che leggevo wildness, fantasticavo di spazi vasti, remoti, senza
contorni. Isole solitarie al largo delle coste atlantiche. Foreste sconfinate e
azzurra luce nivea che cadeva su terreni segnati da orme di lupi. Vette
scheggiate di ghiaccio e conche glaciali coperte da laghi profondissimi. E
l’immagine di luogo selvaggio che da sempre serbavo in cuore era questa: un
posto boreale, invernale, vasto, isolato, elementare, che metteva alla prova il
viaggiatore con le sue asperità. Raggiungere un luogo selvaggio, per me,
voleva dire inoltrarsi fuori dalla storia umana.
Il faggeto non poteva bastare alla mia sete di selvaticità. Il rombo delle
strade vicine era percepibile, come il fragore e l’urlo dei treni che passavano
a ovest. I campi intorno erano trattati con fertilizzanti ed erbicidi per
massimizzare la produttività. E le siepi erano i siti prediletti degli scaricatori
abusivi. Da un giorno all’altro spuntavano mucchi di spazzatura: macerie di
mattoni, compensato gonfio d’acqua, brandelli di giornali. Una volta ho
trovato un reggiseno e un paio di mutandine di pizzo che pendevano dai
cespugli, come prede fuori misura di un’averla maggiore. Scaricatori abusivi,
pensai, piú che un accesso di passione sul bordo della strada – perché chi mai
poteva fare l’amore in una siepe di biancospino?
Nelle settimane prima della burrasca avevo provato il familiare desiderio
di muovermi, di oltrepassare la linea dove cadeva l’ombra dell’inceneritore,
l’orizzonte degli eventi del raccordo anulare. E quel giorno, lassú nella coffa,
mentre guardavo dall’alto le strade, l’ospedale e i campi, con i boschi
imprigionati nel mezzo, sentii l’acuto desiderio di lasciare Cambridge, di
raggiungere un posto remoto, dove la luce delle stelle cadesse nitida, dove il
vento mi soffiasse addosso dalle sue trentasei direzioni e dove minime o
assenti fossero le tracce della presenza umana. Estremo Nord o estremo
Ovest, dunque, perché nella mia testa era lí che la natura selvaggia
sopravviveva – sempre che ne fosse rimasta un po’ da qualche parte.
Di tanto in tanto, in Inghilterra e in Irlanda, viene emessa una
dichiarazione di morte della natura selvaggia. «Due grandi guerre hanno fatto
sorgere e lasciato in eredità un’esigenza di irregimentazione, – scriveva E. M.
Forster nel 1964; – la scienza ha prestato il suo aiuto e in un amen la natura
selvaggia di queste isole, non molto vasta neppure in passato, è stata
schiacciata, edificata, battuta in lungo e in largo. Non è rimasta una sola landa
o foresta in cui fuggire, una grotta dove rannicchiarsi, una valle deserta».
Secondo Jonathan Raban l’estinzione del mondo selvaggio risaliva a ben
prima: negli anni Sessanta dell’Ottocento l’Inghilterra era «cosí fittamente
popolata, cosí intensivamente coltivata, cosí industrializzata, cosí
urbanizzata, che non c’era un posto dove sentirsi veramente soli o vivere [...]
avventure, fatto salvo il mare». John Fowles, nel 1985, era cupamente
categorico: «La verità è che ci troviamo sulla triste soglia della scomparsa di
gran parte dell’antico paesaggio. Abbiamo perpetrato delitti tremendi e
inconcepibili sulle nostre campagne. Solo in pochi punti, lungo le coste e
sulle creste piú alte, l’arcaica ricchezza della vita naturale non è ancora in
pericolo».
Cinque anni dopo lo scrittore americano William Least-Heat Moon
descriveva l’Inghilterra come un «giardino-giocattolo ben curato dove la
natura selvaggia è sparita senza lasciare nemmeno il ricordo e dove le foreste
sono zone di rimboschimento del tutto snaturate. Gli inglesi e gli europei non
sanno piú cosa sia la natura incontaminata. Questa è la differenza tra loro e
noi»
1
. Di continuo lo stesso lamento, o lo stesso disprezzo.
Di prove oggettive a sostegno di questi necrologi ce ne sono a iosa. La
catastrofe si è abbattuta su terre e mari di Inghilterra e Irlanda soprattutto
nell’ultimo secolo. Le statistiche dei danni sono note e spesso ripetute, in
forma di litania funebre piú che di protesta. In Inghilterra tra il 1930 e il 1990
una buona metà dell’antico territorio silvestre è stata disboscata o rimpiazzata
da piantagioni di conifere. Metà dei chilometri di siepi è stata sradicata. Quasi
tutti i pascoli di pianura hanno finito per essere arati, edificati o asfaltati. Tre
quarti della brughiera sono stati convertiti in terra coltivabile o edificabile.
Nel Regno Unito e in Irlanda i preziosi affioramenti di calcare dei campi
carreggiati sono stati fatti a pezzi e venduti come pietre da giardino, millenni
di torbiere in embrione sono state prosciugate o sterrate. Decine di specie
sono scomparse e centinaia di altre sembrano prossime al punto critico.
Nel Regno Unito oltre sessantatre milioni di persone vivono oggi su
un’area di neanche 250 000 chilometri quadrati. L’idea di lontananza è stata
quasi abolita e i principali agenti di questa sparizione sono stati l’automobile
e la strada. Solo una piccola e sempre piú esigua percentuale di terreni si
trova attualmente a piú di cinque chilometri da una superficie carrozzabile. Ci
sono quasi trenta milioni di veicoli funzionanti in Gran Bretagna e 340 000
chilometri di strade. Se le raddrizzassimo e le allacciassimo in un’unica
carreggiata ininterrotta, viaggiandoci sopra arriveremmo quasi sulla Luna. Le
strade sono diventate di per sé nuove civiltà mobili: è stato stimato che nelle
ore di punta la popolazione chiusa in macchina tra Gran Bretagna e Irlanda
sia piú numerosa di quella residente a Londra.
La cartina piú comune del Regno Unito è l’atlante stradale. Prendetene
uno e osservate il reticolo di strade e autostrade che copre la superficie del
Paese. In queste mappe la rete stradale che connette il paesaggio appare cosí
fitta da far pensare che i nuovi elementi primari del territorio siano asfalto e
benzina.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :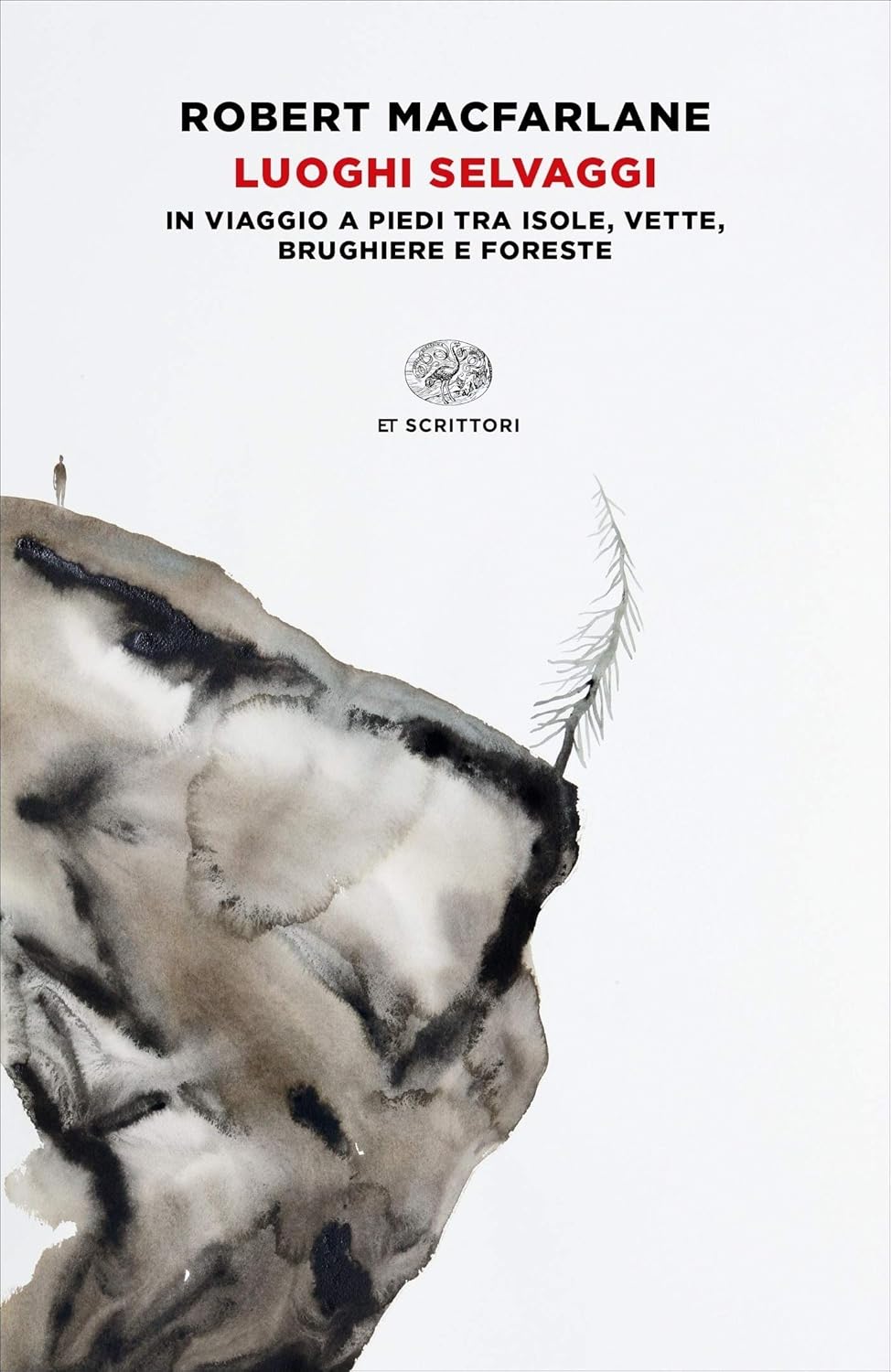






Commento all'articolo