Ignazio Silone – Luce D’Eramo
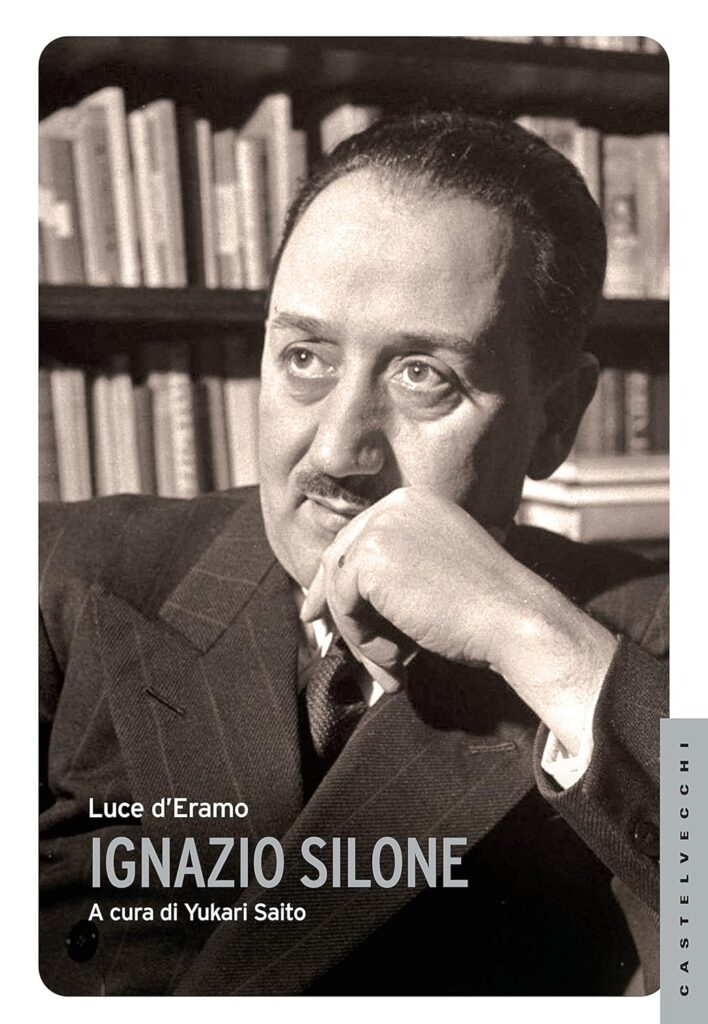
SINTESI DEL LIBRO:
In quest’incontro, spero di riuscire a chiarire alcuni punti: 1) perché ho
fatto questo studio su Silone; 2) quale metodo ho usato nel mio lavoro; 3)
cercherò di spiegare le ragioni per cui ho scelto proprio questo criterio e non
un altro; 4) infine tenterò di dimostrare la validità del mio procedimento,
illustrando la relazione che corre tra l’analisi bibliografica e l’analisi estetica
di un’opera letteraria.
Alcuni problemi ci assillano in modo particolare. Per parlarne uno scrittore
può esprimere questi problemi o in se stessi o nella forma che essi hanno
assunto presso altri autori. Siccome Silone affronta problemi che mi stanno a
cuore, mi sono sempre più interessata alla sua opera. È stato il desiderio di
rendermi conto del suo modo di svolgere certi temi e del perché li esprime
con un certo linguaggio il movente che mi ha spinta a scrivere su di lui.
Questi due elementi, tematica e linguaggio, mi sembravano alla radice
dell’allergia che per parecchi anni i critici hanno dimostrato verso di lui,
mentre, come è noto, all’estero Silone era ed è tuttora considerato un classico
dell’età moderna. Proprio il contrasto tra la mole degli studi che si
svolgevano in ogni continente sulla sua opera, e la voluta noncuranza
(quando non era disprezzo aperto) della cultura italiana nei suoi confronti, mi
ha orientata verso una ricerca della sua bibliografia critica. Sfogliando
diverse migliaia di articoli, saggi e interventi apparsi in tanti Paesi, mi si è
chiarito un concetto che vorrei sottolineare perché è molto importante per me:
che cioè la storia di un’opera è veramente la sua storia pubblica. Così una
ricerca che mi era nata per un chiarimento personale mi si è man mano
configurata come un metodo di lavoro.
Per poter individuare i fattori che determinano un itinerario espressivo, ho
tentato di applicare all’ambito esegetico un metodo che si va affermando
nella storiografia, soprattutto in Francia dove c’è una tradizione di ricerche
sulla Rivoluzione Francese che non finisce mai. Sulla base dei libri di
Mathiez e Lefebvre che sono degni di Tucidide, le vicende più discusse della
Rivoluzione Francese non solo vengono riesaminate attraverso le
testimonianze dei protagonisti e i documenti d’archivio, ma vengono anche
descritte attraverso l’analisi della stampa dell’epoca. Ed è proprio l’indagine
sulla stampa contemporanea a renderci gli umori, le sollecitazioni, tutto quel
terribile contrasto, quell’incomprensione totale della situazione da parte delle
autorità di allora, la disperata determinazione dei rivoluzionari. La lettura di
altri testi mi ha sempre più convinta che sono gli argomenti e i giudizi
negativi, con il loro tono, a misurare la portata di un fenomeno storico. Per
esempio la storia collettiva sulla Comune del 1871 a cura di Bruhat, Dautry e
Tersen conferma questa impressione proprio perché la sua parzialità, dovuta
al tono con cui vengono citate le voci discordi, più che aumentare la
grandezza della Comune, raggiunge quasi l’effetto contrario.
Lo stesso discorso vale per i fenomeni culturali, ed infatti è già stato fatto
altrove, e proprio nell’ambito della critica letteraria. A questo proposito basta
pensare agli studi che vengono condotti da qualche anno in Unione Sovietica
su Dostoevskij: i significati della sua opera vengono verificati con l’analisi di
una ricchissima bibliografia critica. Però quest’operazione, che in storia si
compie anche su fatti contemporanei, in letteratura è stata finora esercitata
soltanto su autori del passato. La prima novità del mio tentativo consiste
sull’applicare questo metodo su un autore vivente: cerco di storicizzare un
fatto culturale in atto, in altre parole mi sforzo di agire sul presente.
È notorio che, se un artista non incontra resistenze, resta il sospetto che la
sua opera non smuova niente. In questi termini capire un autore diventa anche
capire il proprio contesto culturale. Quando cioè mi chiedo per che motivo
una cultura rifiuta o accetta una certa produzione letteraria, di fatto sto
indagando sulla situazione culturale stessa. Ciò comporta una presa di
posizione e anche una polemica dove sia il caso. Una polemica che però non
è stata il movente del mio lavoro, ma una conseguenza della sua
impostazione. Una polemica che, nel caso di Silone, è nutrita dai critici stessi:
dopo anni di grosse riserve, astensioni, ostilità, il clamoroso riconoscimento
dell’opera siloniana, che dalle più remote province è salito fino alla critica
militante, spingerebbe a ironizzare su quest’ultima.
Però, prima di affrontare questo problema, vorrei sgomberare il terreno da
un equivoco che mi addolora profondamente e che riguarda la mia relazione
con il materiale esaminato. Qualcuna delle recensioni dedicate al mio libro su
Silone (per esempio quella, per altro lusinghiera, di Giulio Nascimbeni su
«Corriere della Sera»
2
) può lasciare l’impressione che io attacchi i critici che
stroncano lo scrittore ed esalti quelli che lo lodano. Niente di più inesatto. Io
non ho fatto l’improba fatica di questa scrupolosa, perfino pedante ricerca,
per una questione di tifo sportivo, come per sostenere il campione di calcio
che mi sono scelta e nel quale mi identifico. Contesto un modo di lettura che
spesso resta inalterato anche quando capovolge i suoi giudizi. Parlo
continuamente di ostilità preconcetta, di favore preconcetto verso Silone (per
esempio a p. 85 [nel presente volume a p. 111]
3
); circa il mea culpa di certi
critici (a parte eccezioni come Carlo Bo
4
, Marabini
5
, Garosci
6 e qualche
altro), dopo l’avvento del centro sinistra e l’atmosfera postconciliare scrivo
che quest’immagine di una critica «peccatrice» che poi «si pente» e si
converte al silonismo è certamente bizzarra (p. 257 [pp. 242-243]); insisto
sulla coralità con la quale tutta una corrente di critici depreca il proprio
conformismo passato (nel libro dico ironicamente: «E ugualmente in coro si
ricredettero», p. 382 [p. 344]). Tutta la parte bibliografica del libro,
soprattutto quella sulla critica italiana, tende a dimostrare che chi giudica
un’opera letteraria sul metro del proprio assunto politico, religioso, ecc. e non
in base allo studio dei testi, non ne penetra la logica interna e quindi colpisce
un falso bersaglio.
È chiamata qui in causa la manifestazione residua d’un costume mentale
elevato ancora dal fascismo e che dovrebbe aver fatto il suo tempo. Si tratta
della tendenza a occuparci soltanto dei discorsi che condividiamo, prendendo
sottogamba quelli che non rientrano nel nostro schema concettuale. In questo
modo disconosciamo la realtà culturale in cui viviamo e quindi non la
possiamo neppure modificare. La critica diventa soltanto una censura, che dà
l’imprimatur pubblicitario a un testo o lo mette all’indice, e viene meno al
suo compito che è quello di rendere ragioni dei fenomeni letterari, di capire
perché uno scrittore dice certe cose in un certo modo. Il critico così non
spiega quali sono la genesi, la tematica, il linguaggio e l’area d’influenza
dell’opera in esame, e non dà al lettore gli elementi indispensabili perché
questi possa formarsi un proprio giudizio (che può benissimo contrastare con
l’interpretazione del critico stesso che sottopone tali elementi alla sua
attenzione). Ecco perché, se non ho lesinato dati e confronti di stesure,
esprimendo di volta in volta il criterio che m’ha guidato, ho evitato di mettere
al termine un giudizio globale, una sentenza conclusiva, proprio per
sottolineare la mia concezione della critica: ripeto che il critico non sta lì per
pensare al posto del lettore e per chiudere con il suo verdetto il discorso su un
autore, ma per contribuire ad aprirlo ulteriormente. Quest’assenza di
conclusione mi è stata anche rimproverata, per esempio, da Domenico Grasso
su «La Civiltà Cattolica»
7
.
Ciò non significa che sui testi dello scrittore e sui suoi temi io non abbia in
continuazione espresso il mio pensiero, insito del resto nella stessa
prospettiva con cui esamino la bibliografia. Infatti le ripercussioni
(commenti, interpretazioni e critiche) di un’opera servono non solo a
verificarne la portata culturale e i significati – come succede per esempio
negli studi su Dostoevskij di cui parlavo prima –, ma serve anche a ripensare
l’opera stessa in termini nuovi, quei termini che possono essere offerti solo da
confronto del testo con le interpretazioni che ne sono state date e con gli
effetti che ha avuto sugli altri. Come per conoscere un uomo non basta
ascoltarlo e vederlo agire, ma occorre anche vedere gli effetti che la sua
personalità e le sue azioni producono sull’ambiente che lo circonda, così per
capire un’opera non è sufficiente leggerla con attenzione e anche
meticolosamente, ma è necessario vedere come quest’opera è stata accolta,
meditata e riproposta. E per l’identificazione dell’opera, cioè per conoscere la
sua unicità, è tanto più vantaggioso analizzare l’accoglienza che essa ha
ricevuto, quando la si paragoni con quella che è stata data dalle stesse fonti ad
altre opere di altri autori. Così l’esegesi critica e l’esame bibliografico non
sono più due discorsi separati, l’uno strettamente estetico e l’altro
esclusivamente culturale, ma l’analisi insieme compositiva stilistica e
sociologica serve a individuare la singolarità di un’opera, vale a dire a
definirla come fenomeno artistico.
E questa è la seconda novità assoluta del metodo che ho usato, che
consente di comprendere le proprietà espressive di un’opera attraverso i suoi
effetti, senza dover ricorrere alle solite parentele e ai soliti inquadramenti che
hanno perseguitato i miei studi letterari sin dall’infanzia. Del resto lo dico
esplicitamente nel mio libro. A p. 488 [p. 441] scrivo infatti che, per
presentare l’opera di un artista, spesso si fa come chi, per descrivere una
persona dicesse: «Il naso somiglia a quello di Tizio, la bocca a quella di Caio,
l’orecchio a quello di Sempronio e via dicendo». Con questo criterio si perde
di vista ciò che distingue in proprio l’opera in questione e non se ne coglie
l’intrinseca necessità espressiva.
Mi sono dilungata un po’ su queste precisazioni perché sono pochi i critici
al mio libro su Silone che hanno avvertito il carattere insolito del lavoro: oltre
a Geno Pampaloni che nella presentazione del libro a Roma
8 ne ha
acutamente esaminato i piani e le direttive, desidero ricordare Domenico
Porzio nella stessa occasione, Giuseppe Rosato sul «Mattino»
9 di Napoli,
Domenico Grasso che ho già nominato e in particolare due recensori
milanesi, Angelo Rovetta su «Studi Cattolici»
10 e Elio Maraone su
«Avvenire»
11
. Molti degli altri sembrano considerare il mio saggio un exploit
di diligenza meticolosa fino alla pignoleria, e per dimostrarlo, riferiscono tutti
che ho avuto perfino la pazienza di contare a una a una le similitudini di
Fontamara. A parte il fatto che ho contato anche quelle di Pane e vino e di Il
seme sotto la neve, e di questo nessuno pare essersi accorto perché nessuno lo
dice, vorrei rivelare che non ci vuole niente a contare le similitudini di un
romanzo: basta sottolinearle con la matita mentre si legge il libro e alla fine,
in cinque minuti d’orologio, il conto è fatto. A me serviva per verificare
l’impostazione diretta dello stile siloniano, provata appunto dalla scarsezza
d’immagini e della mancanza di perifrasi analogiche. I critici invece l’hanno
visto come manifestazione di zelo compilativo, probabilmente gratuito, che
chissà quanto lavoro m’ha chiesto!
Mi soffermo un attimo ancora sulle reazioni dei critici al mio libro perché
ho fondato anche questa conversazione sul criterio circolatorio che ho seguito
nel saggio su Silone, che (ripeto) consiste nel riassorbire i discorsi altrui in un
proprio ripensamento. Poiché devo parlare di un libro scritto da me, la cosa
più semplice da fare è, mi sembra, vedere come è stato accolto e discuterne
insieme. Ho avuto riconoscimenti inattesi da lettori sconosciuti che m’hanno
scritto per dirmi d’aver finalmente imparato a orientarsi nei «vicoli» della
critica italiana. Qualche osservazione orale tiene conto del mio metodo per
apprezzarlo (per esempio un noto dantista e studioso di letteratura del
Magistero di Roma), ma i più per disapprovarlo. Un paio di illustri docenti
romani hanno dichiarato che un simile metodo è assurdo perché, al termine
del lavoro, può venir fuori che i testi esaminati non reggono a questa lettura
di secondo grado, e quindi uno rischia d’aver spogliato l’ira di Dio di
materiale per poi scoprire che non ne valeva la pena. A parer loro si possono
studiare le bibliografie critiche soltanto di autori la cui validità artistica,
accertata con altri mezzi, è fuori discussione anche perché sancita dal tempo,
le fortune che so io di Virgilio o di Orazio attraverso i secoli, come si fa da
decenni nelle università. Ma perché le si studierebbe, dico io, se non fosse
che tante indagini su un autore precisano meglio la fisionomia della sua arte?
E allora invece di usare quest’argomento soltanto per confermare a posteriori
una valutazione che si aveva già, perché non bruciare i tempi e usarlo per
capire subito i vivi e non sempre e solo i morti?
E se anche si dovesse scoprire che un’opera letteraria non regge a questa
lettura di secondo grado, sarebbe sempre un bel risultato poter chiarire tanti
equivoci culturali, un risultato che chiarificherebbe grandemente la nostra
conoscenza del contesto in cui ci troviamo perché è chiaro che, se non
conosco la realtà in cui vivo, non posso capirne niente e non posso agirvi con
efficacia.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :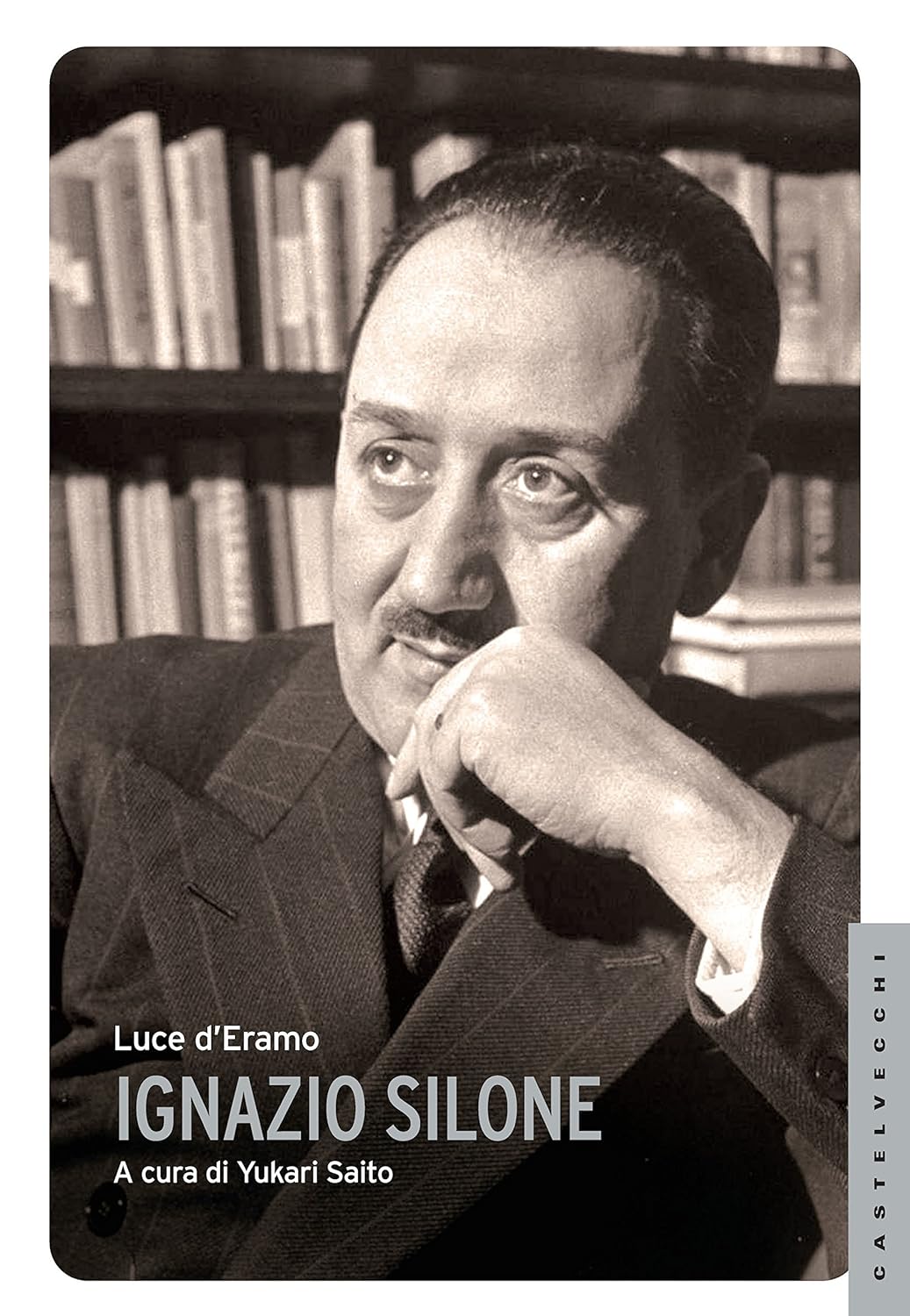






Commento all'articolo