Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale – Claudio Magris
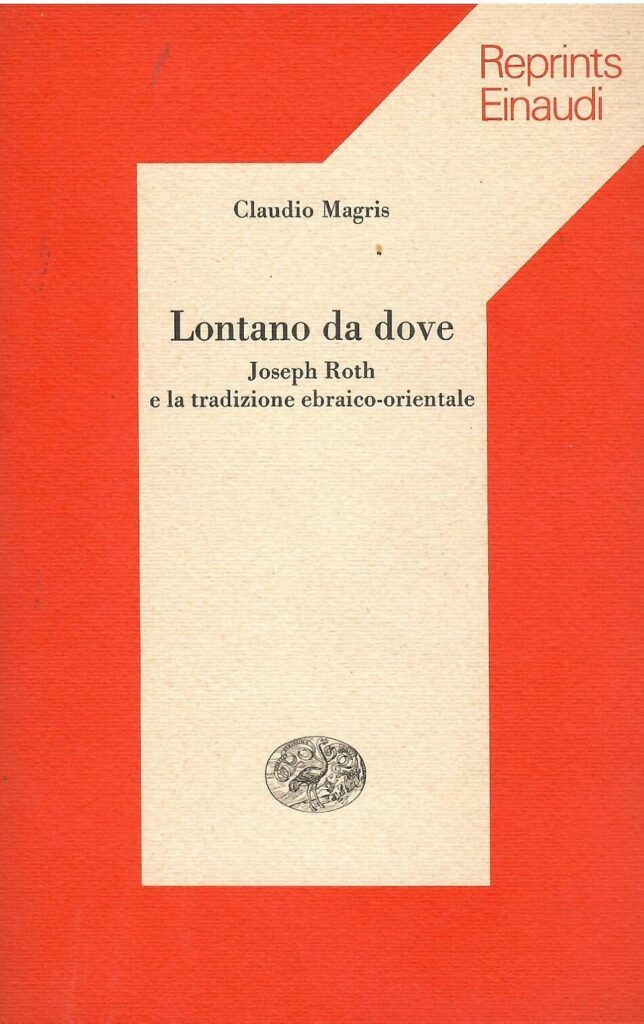
SINTESI DEL LIBRO:
Nel racconto Un testimone (1946) di David Bergelson un vecchio ebreo
sopravvissuto ai campi di sterminio narra ad una giovane donna, che si
accinge a trascriverle, le inaudite violenze subite e la strage di tutta la propria
famiglia
1
. La ragazza ed un suo amico si stupiscono del tono laconico della
sua rievocazione, «asciutta come un protocollo» e affidata a parole ed a frasi
«affatto semplici e usuali»
2
; soltanto dopo aver finito il suo impersonale
resoconto il vecchio, soffermandosi su un episodio non certo piú
sconvolgente degli altri ma semmai avvolto in un’aura di pur tragica
tenerezza, tronca il piano fluire della cronaca per abbandonarsi alla
partecipazione affettiva e scoppia in pianto
3
.
Questo pianto ritardato della novella di Bergelson, che Benjamin avrebbe
potuto scegliere in luogo del celebre episodio di Erodoto quale esempio e
prototipo dell’arte di raccontare e della sua tensione ad uno scioglimento
liberatore
4
, costituisce in certo senso l’epigrafe e il congedo della narrativa
ebraico-orientale, di quella letteratura che – esprimendosi soprattutto in
jiddisch, come del resto la stessa novella di Bergelson – si era fatta specchio
della civiltà dello shtetl, della «piccola città» e del microcosmo degli
Ostjuden. Epos o cronaca di un mondo cosí spesso sconvolto dalla
persecuzione, la narrativa ebraico-orientale aveva spesso eluso la tragedia e
sottaciuto il pianto ed il dolore, che aveva volentieri minimizzato – per lo
meno in confronto alla situazione reale – per volgersi al malinconico e
ironico sorriso, a quell’umorismo consolatore trasfigurante e pungente ch’è
stato piú volte sottolineato (recentemente anche da Salcia Landmann
5
) e che
era, in ultima analisi, il riso di chi sapeva di non poter venire veramente
sconfitto. O meglio, era l’eroico tentativo di opporre un ottimismo religioso
alla realtà storica, di afferrarsi ad una rassicurante mistificazione che diveniva
autentica quale sostegno nell’elementare lotta per l’esistenza. Il racconto nel
racconto, ossia la rievocazione del vecchio, rappresenta in questo senso
l’ultima classica novella ebraico-orientale, nella quale la pietas del narrare –
una pietas di lontana ascendenza chassidica – comporta la conquista o il
possesso di un significato trascendente gli eventi e quindi il superamento
della tragedia, l’assenza o il dominio del pianto. Quando ad esempio in una
delle piú belle pagine di un capolavoro della narrativa jiddisch quale Tewje il
lattaio di Schalem Alejchem (1896) la figlia Hodel deve dare un addio ai
genitori per seguire l’amato deportato in Siberia, Tewje convince la moglie
che la figlia deve partire per una questione d’eredità e che, poiché dovrà forse
star lontana da casa «tutto l’inverno», è opportuno fornirla di qualche
provvista, un po’ di biancheria, un paio di cuscini e di federe: «Cosí ordino e
dico che nessuno deve piangere: oggi è la festa di Hojschano-Rabo e in
questo giorno, soggiungo, le lacrime sono proibite! La Legge le vieta
espressamente»
6
. Ma Bergelson, che scrive dopo la fine, non può raccontare
piú come il suo vecchio testimone e prosegue la sua storia con la disperazione
di quest’ultimo, che si commuove non al ricordo delle proprie sofferenze e di
quelle dei suoi cari ma al ricordo, avvolto in un alone di gentilezza simbolica
e quasi leggendaria, dell’uccisione di una giovane e bellissima donna dai
capelli neri costretta dai carnefici a farsi ritrarre nuda da un compagno del
Lager, quasi illusa di scampare cosí alla camera a gas
7 come una santa alle
belve del circo in un’ingenua agiografia.
Quel pianto per il massacro nazista è anche un trenos, un epicedio per la
letteratura ebraico-orientale. Non è stata solo la carneficina hitleriana a
provocare, con le sue proporzioni, il tramonto di quell’epica: benché
quantitativamente minori, gli eccidi causati dai pogroms russi e polacchi
sarebbero stati piú che sufficienti a spezzare ogni ottimismo umanistico ed
ogni fermezza stoico-religiosa, cosí come lo sarebbero state del resto piú tardi
anche le persecuzioni staliniane delle quali era destinato a cadere vittima,
qualche anno dopo la stesura del Testimone, lo stesso Bergelson. Lo
sterminio perpetrato dal nazismo segna l’apice sanguinoso di un processo di
dissoluzione dell’Ostjudentum, del quale l’assimilazione o la fuga verso
occidente costituiscono momenti quasi altrettanto decisivi anche se
umanamente imparagonabili. La concisa e serrata compiutezza del racconto
fermo ed intatto è un ricordo di ieri non solo perché le pressioni recenti sono
state le piú violente fra quelle conosciute nel lungo cammino dell’esilio ma
perché non esiste piú la completa integrità e saldezza del mondo opposto alla
furia dell’esilio, del piccolo shtetl trasfigurato in microcosmo organico ed
armonioso in se stesso pur nella sua oggettiva miseria e quindi tale da
consentire, benché su scala minima, la protettrice presenza di valori
universali-umani, di punti di riferimento validi per tutti gli uomini di una sia
pur ristretta società. Tale cioè da poter essere mitizzato quale universo
domestico atto a consentire la formulazione di valori classici, ai quali è legata
la possibilità di un’epica che componga anche il dolore e dia un significato
alla tragedia.
In questo senso anche Joseph Roth, sebbene scomparso prima di assistere
alla messa in atto della «soluzione finale», scrive dopo la fine ed inizia il suo
itinerario poetico ed intellettuale quando la storia che gli sta a cuore si è già
svolta e conclusa, quando il suo mondo è già crollato e scomparso ed anche
gli ultimi residui sono in procinto di sparire. È stato detto che il complesso
della narrativa di Roth costituisce un ciclo epico, una vera e propria saga
8
:
numerosi personaggi appaiono, con differenti gradazioni di rilievo e di
funzione romanzesca, in diverse opere, dal capitano Taittinger – che nel
Radetzkymarsch (La marcia di Radetzky, 1932) è una comparsa collaterale e
nella Geschichte von der 1002. Nacht (La milleduesima notte, 1939) diviene
il protagonista – alla tenera Mizzi Schinagl che incarna a piú riprese, sin dalla
novella giovanile Der Vorzugsschüler (Lo scolaro modello, 1916)
9
, la
femminilità indifesa e irretita nelle strutture sociali del «mondo di ieri», sino
alla figura ambigua del contrabbandiere Kapturak presente nello Stummer
Prophet (Il profeta silenzioso, 1927-30), nel Hiob (Giobbe, 1930), nel
Radetzkymarsch e nel Falsches Gewicht (Il peso falso, 1937).
L’esemplificazione potrebbe continuare, con una ricchezza ben maggiore di
dettagli sia per quel che concerne i personaggi citati sia per quel che riguarda
altre figure o anche ambienti, motivi e situazioni. Affidandosi al principio
della ripetizione e dell’autocitazione Roth sembra voler stabilire le coordinate
di un universo organico e concluso, di una saga autosufficiente. In realtà Roth
non fa che stendere l’epilogo di questa saga e descrivere i postumi di un
processo, i residui e i frammenti che rimangono dopo la conclusione di un
ciclo epico. Ciò vale non soltanto per la prima fase della sua produzione ma
anche per quelle successive, nelle quali si è voluto scorgere un’autentica
distensione epica o addirittura, come ha affermato Lukács
10
, la costruzione
positiva di un vero romanzo storico-realistico. L’itinerario di Roth comincia
con la fine di una guerra perduta, con la dissoluzione di un impero e con la
disgregazione di una coralità umana e religiosa, quella dell’ebraismo
orientale; la sua narrativa inizia idealmente dopo quel diluvio biblico e
insieme squallidamente moderno col quale egli, nel suo tardo romanzo Die
Kapuzinergruft (La cripta dei cappuccini, 1938), ha raffigurato
simbolicamente l’esordio della grande guerra: «Cominciò a piovere. Era un
giovedí. Il giorno seguente, dunque venerdí, il proclama era già affisso a tutti
gli angoli delle strade. Era il manifesto del nostro vecchio imperatore
Francesco Giuseppe, e cominciava: “Ai miei popoli”»
11
. Certo Die
Kapuzinergruft è una delle ultime opere di Roth, un tentativo di proseguire
alquanto artificialmente la storia della famiglia Trotta già narrata e conclusa
nel Radetzkymarsch per rappresentare, con un polemico pessimismo
conservatore, l’inflazione morale e il conformistico disordine che travolgono
l’Austria – e l’Europa – del primo dopoguerra sino a sommergerla nella
«cloaca» nazista
12
, come Roth stesso definirà il Terzo Reich. L’immagine di
quell’opaca pioggia che cancella le parole si pone tuttavia,
indipendentemente dal romanzo in cui è inserita (che oltre tutto è costruito al
modo di un eclettico e rabberciato intarsio di tanti motivi precedenti), come
l’ideale punto di partenza di Roth, il cui narrare comincia dunque quando non
si possono piú raccontare storie, quando l’epica è tramontata e la vita non si
lascia piú ridurre e salvare nel filo del racconto.
È ovvio che quest’affermazione non va intesa né sul piano cronologico né
su quello immediatamente psicologico: almeno sino alle soglie dell’età
moderna, il narratore inizia sempre la sua cronaca a vicende ultimate, come il
servo di Giobbe scampato per raccontargli la morte dei figli o come il poeta
del Nibelungenlied che è spinto al cantare eroico dalla conoscenza del lutto e
della morte finale. La grande guerra, e cioè la dissoluzione dell’impero
absburgico identificata a sua volta con la disgregazione dello shtetl ebraicoorientale, non costituisce soltanto il centro della narrativa di Roth, cui egli si
rifà per descrivere lo squallore successivo o per rievocare una precedente
armonia che finisce tuttavia per rivelarsi anch’essa illusoria e chimerica
13
.
Accanto al normale trauma per la fine di un mondo, che implica abbastanza
ovviamente la legittima ricerca di un tempo perduto e l’aggressivo confronto
col tempo presente, per Roth la caduta iniziale comporta delle conseguenze
piú profonde. Nella fine alla quale egli è sopravvissuto per raccontarla egli
scorge la fine di un imperium, di una ecumene di legami e rapporti che
consentiva la comunicazione di affetti e sentimenti e la trasmissione di valori,
che permetteva quindi l’epica come gerarchia di significati, ordine di vicende
e mediazione di tale patrimonio nell’armonia del racconto. Poco importa che
a Roth stesso quest’idealizzazione del passato dovesse rivelarsi piú tardi una
fallace illusione
14
; è determinante invece che egli abbia inteso
soggettivamente lo sfacelo dell’impero come la fine di un cosmo fondato su
coordinate che garantivano lo scambio di esperienze significative e la durata
della loro validità. Distinguendosi sotto questo profilo da quasi tutti i
nostalgici absburgici e avvicinandosi semmai a Musil – col quale egli rivela,
nonostante ogni incolmabile distanza qualitativa, delle sorprendenti affinità
sul piano della critica dei valori
15 – Roth vive il crollo dell’impero come fine
della tradizione ed inizio del moderno, inteso quale atomizzazione e
secolarizzazione. Questa prospettiva informa in misura decisiva
l’interessantissima seppur paradossale visione politica di Roth, cui sarà
necessario rivolgere un’attenzione particolare anche per quel che concerne i
due romanzi specificamente «politici» Das Spinnennetz (La tela del ragno,
1923) e Der stumme Prophet i quali, benché appartenenti cronologicamente
alla prima fase della produzione rothiana, possono essere interpretati solo
come diretto contraltare e contrappunto del Radetzkymarsch.
Trasfigurando in una dimensione metastorica l’impero absburgico Roth lo
identifica, ora consapevolmente ora inconsciamente, con quell’unità integra e
compatta ch’egli individua anche nella coesione delle matrici religiose,
umane e morali dell’ebraismo orientale, anch’esso incalzato e minacciato
dalla storia. In questa prospettiva si può forse interpretare con una sfumatura
diversa la periodizzazione proposta da Curt Hohoff, che distingue
nell’evoluzione di Roth tre fasi successive: la prima, conclusasi con Rechts
und Links (Destra e sinistra) nel 1929 e contrassegnata da un’intonazione
anarchica e socialisteggiante violentemente polemica; la seconda, costituita
dal momento religioso del Hiob (1930); infine la terza, iniziata col
Radetzkymarsch e caratterizzata da un classicismo conservatore e
legittimista
16
. Tale corretta e utilissima periodizzazione potrebbe venir
ritoccata anzitutto per quanto concerne il fiabesco e lucidissimo nichilismo
finale, il quale illumina l’ultima stagione di Roth di quell’ironica e mitica
coscienza del nulla che traspare da racconti-parabole come Die Geschichte
von der 1002. Nacht, Die Legende vom heiligen Trinker (La leggenda del
santo bevitore, 1939) e Der Leviathan (Il Leviatano, 1940); qualche altra
precisazione potrebbe rintracciare già nei primi romanzi contestativi quegli
elementi di polemica tradizionalista e antisecolarista che sono alla base della
successiva posizione conservatrice. Proprio Der neue Tag (Il nuovo giorno,
1919-1927), la raccolta dei piú accesi articoli anticlericali antimilitaristi e
antiborghesi scritti da Roth nell’immediato dopoguerra ed editi ora da
Ingeborg Sültemeyer
17
, lascia intravvedere tale passaggio, che esige
un’analisi particolare. La periodizzazione di Hohoff resta nondimeno
sostanzialmente valida e sottolinea opportunamente il carattere protestatario
dei primi romanzi rothiani; tale carattere protestatario e la sua posteriore
conciliazione non sarebbero tuttavia comprensibili se non si tenesse presente
la peculiare simbiosi operata da Roth fra Austriazität e Ostjudentum, fra
imperium e shtetl.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :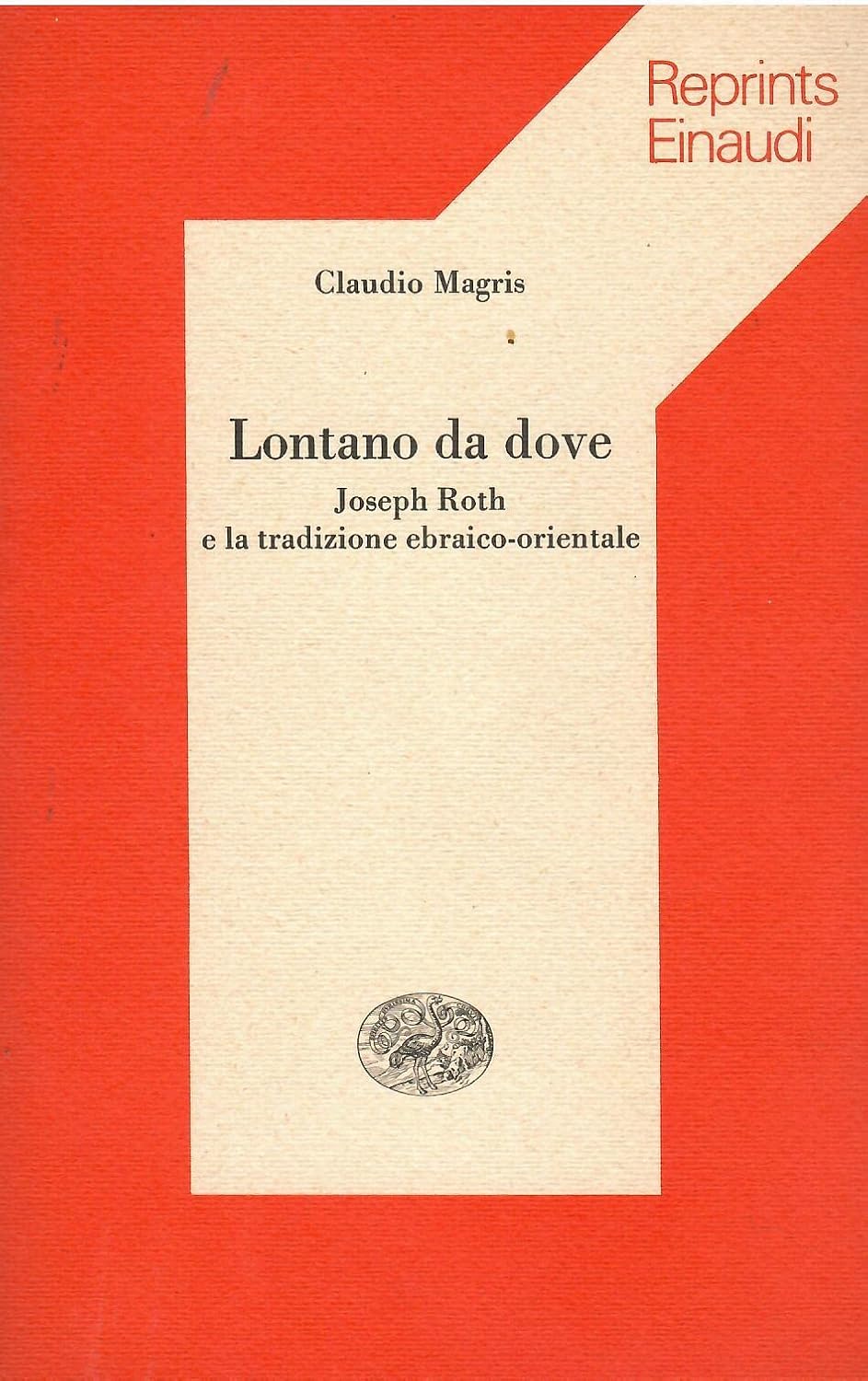






Commento all'articolo