L’Italia dei Comuni e delle Signorie – Ludovico Gatto
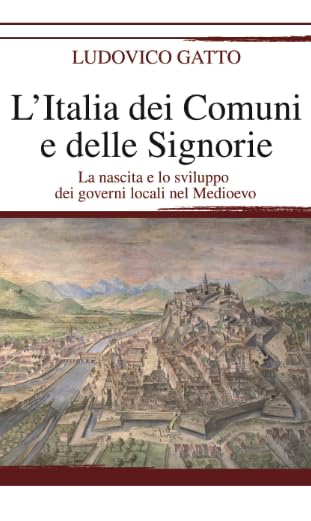
SINTESI DEL LIBRO:
Pur se la storiografia degli ultimi decenni ci ha abituati a porre in modo
diverso sia il problema dei cosiddetti Comuni cittadini, ovvero della
formazione dei poteri centrali fra XI e XII secolo, sia quello dello sviluppo
delle Signorie e dei Principati, fra gli anni 1250 e il 1294, due elementi fra
gli altri spiccano nelle più recenti elaborazioni critiche: il fondamento
generale del fenomeno è costituito dall’organismo cittadino che, specialmente
nella penisola italiana, sopravvisse a invasioni, a guerre e dominazioni e che,
alle origini del secondo millennio, conobbe una promettente ripresa dal punto
di vista urbanistico e sociale, economico e culturale.
Il secondo aspetto è costituito dalla natura politica del fenomeno stesso e
dalla latitanza di poteri di carattere centrale – Impero e Papato – cui vanno
gradualmente sostituendosi singoli personaggi – i Signori – attorno ai quali si
organizzeranno i governi di tipo prevalentemente oligarchico.
Inoltre, i luoghi abitati durante il periodo tardoantico e altomedievale
continuarono quasi sempre a godere di peculiari diritti e privilegi, estesi entro
le zone circondate dalle loro mura e altresì a quelle a loro immediate
subiectae.
I centri urbani, dunque, vennero in qualche misura sottratti alla competenza
dello Stato, dell’imperatore o del pontefice, e si disposero a chiedere
autonomie o libertates sempre più ampie e precise, vuoi ai conti, ossia ai
rappresentanti del sovrano, vuoi ai vescovi, ovvero ai rappresentanti dei
pontefici.
Il binomio «vescovo-conte» finì poi con il diventare un elemento del tutto
originale della storia italiana dei secoli successivi all’Impero Carolingio
rapidamente dissoltosi, per dar luogo a combinazioni politiche e a
concentrazioni diverse.
I luoghi di convivenza civile pertanto ebbero sempre una loro caratteristica
che li contraddistinse dalla campagna, dalle dominazioni feudali e da
qualsiasi altra forma di potere.
Questo è dunque il fondamento della società comunale e poi di quella
signorile alla prima profondamente connessa.
Dalla città e dalla loro storia quindi è partita di solito l’indagine degli storici
che negli ultimi due secoli, in modo diverso, furono spesso attenti al sorgere
del Comune poi delle Signorie e degli Stati regionali.
E noi, a nostra volta, rivolgeremo in questo senso la nostra indagine verso
un elemento distintivo di una vicenda che ha fortemente caratterizzato la vita
dell’età di mezzo, soprattutto quella italiana ma, in certo modo, anche quella
legata ai popoli e alle terre d’Oltralpe.
2. La nascita del Comune: un problema storiografico
Il Comune è solitamente considerato un fenomeno nuovo e originale
rispetto al sistema precedente. Al potere essenzialmente verticistico esercitato
in maniera del tutto personale nell’età feudale si sarebbe pertanto
contrapposta una concezione comunitaria, fondata su leggi e statuti, su patti
giurati e accettati da tutti; in altri termini una concezione, a suo modo
democratica, espressione precipua di tutta la storia dell’Occidente cristiano,
sino all’età delle democrazie moderne, e del diritto di una comunità locale ad
autogestirsi.
In questo ambito però esso rappresenta nell’età di mezzo, sotto l’aspetto
statale e giuridico, un fatto largamente singolare, al quale si dovrebbe dare
una spiegazione che ne giustifichi le divergenze rispetto a quella che venne
considerata l’esperienza organizzativo-politica di base, volta a caratterizzare
quell’intera età.
Nell’approfondimento di tale spiegazione sono così nate varie teorie, tesi e
interpretazioni relative alle origini, al significato e all’esperienza dell’età
comunale nell’Occidente e specialmente in Italia.
Su tali interpretazioni hanno senza alcun dubbio pesato gli ideali, gli
interessi, gli orientamenti di studio e di ricerca, quando non addirittura le
direttrici ideologiche, in auge in determinati ambienti e momenti.
Ciò precisato si può delimitare la storiografia comunale in tre direzioni
principali: nel periodo romantico-risorgimentale l’esperienza del Comune
viene «letta» come espressione del profondo senso di libertà, della volontà e
della capacità di darsi un’organizzazione per combattere le intromissioni
esterne.
Gli storici del nostro Risorgimento insomma hanno fatto del suddetto
periodo il simbolo della riscossa per il conseguimento delle libertà civili
contro l’oppressione straniera o meglio austriaca. In Federico Barbarossa,
pertanto, si vide una sorta di predecessore di Francesco Giuseppe d’Austria.
Gli studiosi tedeschi vi hanno scorto invece, nella sua piena maturità,
l’innata tendenza germanica alla creazione di comunità autonomamente
gestite, nonché l’indomabile bisogno di libertà di quelle genti.
Nel periodo tra la fine del XIX e i primordi del XX secolo, si fecero avanti
infine, anche in merito all’età comunale, le linee di tendenza di ricerche
socio-economiche e materialistiche.
Ecco, in breve, le idee di tre fra i più notevoli e caratterizzanti studiosi:
Ferdinando Gabotto raccoglieva nel 1902-1903 i risultati delle sue ricerche in
un saggio dal titolo Le origini signorili dei Comuni. Secondo Gabotto, il
Comune sarebbe nato da un consorzio di nobili feudali, legati
dall’appartenenza ad un determinato ceppo familiare, il cui capostipite
trasmetteva i diritti feudali ai discendenti che, con il trascorrere degli anni,
accresciutisi di numero, costituirono un gruppo troppo folto per gestire
direttamente un beneficio – un feudo o una città fortificata – o un ufficio di
carattere amministrativo trasmesso loro in eredità.
Sorse pertanto il principio della rappresentatività, dell’autorità e della
responsabilità della diretta amministrazione del beneficio o dell’ufficio
offerto a un ristretto gruppo coadiuvato dal Consiglio generale permanente
composto da tutti i Consortes.
L’ufficio del procurator formò allora un’indivisibile unità trasmessa ai
discendenti che dettero origine alla famiglia procuratoria, nucleo
insostituibile e primario del Comune cittadino.
A tale impostazione reagirà invece Gioacchino Volpe, pervenuto a diverse
conclusioni con i suoi studi sulla Toscana medievale e sulla Lunigiana. Egli
espose le sue ipotesi nella magistrale ricerca Questioni fondamentali
sull’origine e lo svolgimento dei Comuni italiani nel Medioevo.
A Volpe, il gruppo che dette luogo al Comune sembrò più complesso. Esso
rappresenta pertanto un ceto intermedio fra nobiltà feudale e nobiltà cittadina,
formato da proprietari terrieri cittadini e usciti dalla piccola nobiltà feudale,
inoltre dai mercanti arricchiti e dagli artigiani e quindi è un fenomeno
disomogeneo e differenziato.
Secondo il parere di Volpe il Comune nasce da un patto giurato, volontario.
Quindi, in origine, esso è un’associazione privata che si affianca, senza la
pretesa di sostituirli, a vescovi e a conti.
Originale invece l’impostazione del belga Henri Pirenne che rinvenne la più
caratteristica matrice comunale nella borghesia mercantile costituente in ogni
città l’elemento più ricco, più attivo, maggiormente desideroso di
cambiamenti, come viene asserito nel lavoro La città del Medioevo.
Il ceto mercantile abita il borgo o il porto, una denominazione che in età
altomedievale indica soprattutto un punto di riferimento di abitazioni e
agglomerati cittadini e non necessariamente uno sbocco sul mare o su un
corso d’acqua interno. Ai mercanti presto si aggiungono i liberi artigiani e i
servi. Qui, a partire dall’XI secolo si farà nascere l’industria laniera allorché
comincerà a organizzarsi la popolazione del suburbio o del borgo nuovo, i
luoghi ove si concentrano i magazzini contenenti le merci.
Questi cittadini hanno di solito interessi contrastanti con quelli dei signori
feudali che dominano il vecchio borgo, quindi assumono caratteri
organizzativi diversi, più autonomi e trasformano progressivamente le
vecchie magistrature scabinali in magistrature indipendenti i cui membri,
trovati fra i burgenses, resero loro una giustizia adeguata ai loro desideri.
Tale modello rispondente alla società franco-borgognona e fiamminga, fu
poi dal Pirenne ampiamente applicato altrove, per spiegare l’origine del
Comune in Occidente.
Nicola Ottokar invece sottolineò opportunamente la discrasia esistente fra
le città italiane e quelle d’Oltralpe vuoi dal punto di vista socio-economico –
la città considerata quasi esclusivamente quale sede dei mercanti – vuoi da
quello politico-territoriale: il territorio di competenza comunale in Italia va
ben oltre i confini cittadini, laddove, al di là delle Alpi, raggiunge in linea di
massima i tre chilometri oltre le mura, ovvero la zona banni leuca da cui
nascerà il termine banlieu.
Come appare chiaro sia Pirenne e Ottokar, sia Volpe e Gabotto inserirono il
discorso comunale in quello della storia cittadina. Tuttavia, la storia
comunale in ogni sua espressione ha preso orientamenti particolari. Così ci si
dedicò in prevalenza a studi relativi alle strutture della società comunale nel
variegato ginepraio delle sue componenti, dei suoi gruppi e dei loro reciproci
rapporti. Proprio tal tipo di ricerche però indusse a rivedere criticamente
impostazioni e ipotesi per molto tempo considerate vincenti. Partendo dalle
tesi del Volpe e di Gaetano Salvemini, Emilio Cristiani ripensa e corregge il
tiro delle conclusioni di Volpe responsabili di aver forse eccessivamente
accentuato il ricambio sociale dell’aristocrazia cittadina, operato dalla gente
nova venuta dal contado.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo