L’ingegnere in blu – Alberto Arbasino
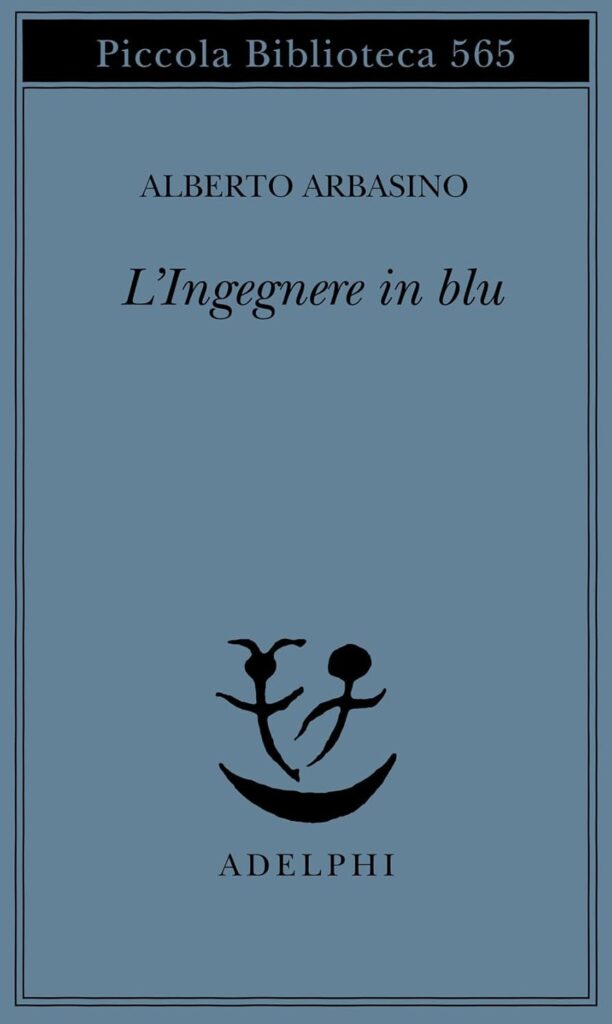
SINTESI DEL LIBRO:
Carlo Emilio Gadda aveva già più di sessant’anni, scriveva da più
di trenta, e non aveva ancora pubblicato in volume il Pasticciaccio,
ormai praticamente dimenticato o ignorato, forse, quando i ventenni
degli anni Cinquanta scoprirono la sua posizione ‘centrale’ nella
nostra letteratura contemporanea. E sull’entusiasmo per la stupenda
Adalgisa, per le mirabili Novelle dal Ducato in fiamme, lo
dichiararono massimo autore italiano del mezzo secolo, con
immenso dispetto di tutti gli altri.
Già. I letterati del Trenta e del Quaranta persistevano nel
considerarlo un outsider, un «eccentrico ... arrivato tardi alla
letteratura», un «umorista» molto «faticoso» e «cincischiato»: come
se il caso Svevo non insegnasse mai nulla. Taluni raffinati gourmets
(Contini, Devoto) assaporavano con delizia la sua prosa furente e
squisita: ma privatamente, nelle più ritrose trappe o oubliettes
dell’iniziazione stilistica. Tuttavia, per decenni, il grande Ingegnere
apparve costantemente confuso ‘alla pari’ fra decine di nomi
irrilevanti o lamentevoli, nei tristi famosi repertori d’articoli critici della
generazione anziana che ravvisava i più veri e raccomandati sviluppi
della patria letteratura non già negli scarti geniali rispetto a
un’Arcadia comune, bensì nella graduale continuità della minestrina
collettiva. «Ironia oziosa», «Scherzo a vuoto», «Aggrovigliata
tessitura», «Prose ricche, troppo ricche», sentenziavano pigolando e
caccolando i più celebrati Arcadi e Accademici; e poi: «Non ha
leggerezza di movimenti», «Non sa fondere bene le parti», «Non
vede le varie arti fondersi in un’una, le vede disgregarsi», «È un
Barilli a cui manca tutto quello che è di Barilli!».
Tipicamente, negli Almanacchi Bompiani degli anni Trenta, La
Madonna dei Filosofi e Il castello di Udine vengono inseriti (a cura di
A. Bocelli) nelle rubriche «Ci fanno ridere» o «Due modi di far
ridere», con Campanile e Zavattini. «In Gadda, l’umorismo nasce da
un contrasto tra spirito ligio alle regole, esatto, e un’insofferenza di
codeste regole, un bisogno di infrangerle, di evadere, di vivere
liberamente, estrosamente... Un’espressione quanto mai bizzarra,
mista di parole e frasi scientifiche, classiche e coniate ex tempore...
Dà una buona riprova del suo singolare umorismo fatto di logica
esattezza, di chiarezza scientifica, e di ribellione fra estrosa e
nostalgica ad ogni razionalità e scientifismo»...
Il Tesoretto, «Almanacco dello “Specchio” 1942-XX, Mondadori, L.
25» (su cui si cresceva infanti), non lo rammenta neanche, nel suo
indice dei nomi, tra Fumagalli Giuseppina, Funi Achille, Galli Luigi,
Gargiulo Alfredo. In compenso («en revanche» avrebbe detto lui),
Gargiulo Alfredo, recensendolo nella sua Letteratura Italiana del
Novecento fra Nino Savarese, Umberto Fracchia, Ain Zara Magno,
Giovanni Del Pizzo e Giuseppe Mormino, riconosce: «Non sempre
egli scherza». Però, però... «Fortuna quindi che tutto si risolva in un
vano gioco. In breve, i toni plausibili non abbondano. Non meraviglia
che una disposizione quale è quella del Gadda, così indifferente e
generica, si rifiuti a tradursi in realizzazioni d’arte sufficientemente
motivate nei nessi e negli sviluppi. Quale interesse sintetico animò il
Gadda, nello scrivere La Madonna dei Filosofi? Nessuno; e il
racconto risulta infatti svagato e slegato in una misura appena
verosimile». E quando va bene: «Un ritratto di contadino, ricorda, ma
con indipendenza, lo Jahier».
Ci troviamo infatti fra critiche elaborate per «L’Italia letteraria» e la
«Nuova Antologia», poi raccolte in volume da Le Monnier e talvolta
dedicate alla propria cara moglie, in una Firenze di vicoli fra Rosai e
Signorini e Pratolini, senza relazioni con gli Acton o Berenson o
Sitwell o Trefusis in ville e castelli, coi Negroni o Martini da Doney e
Giacosa e Leland’s, la letteratura internazionale alla Libreria Seeber,
gli allestimenti di Casorati e Sironi e De Chirico al Maggio Musicale,
gli elixir e profumi e pots-pourris di S. Maria Novella, i concerti
cosmopoliti come a Salisburgo, le ‘magie’ di Max Reinhardt a
Boboli... E tutti gli ermetici in fila, alle Giubbe Rosse... Né si era
ancora sprofondati all’inflazione del dopoguerra, che costrinse «un
Gadda!» a farsi pigionante nella pensione economica della ‘sora’
Gargiulo, nella Roma di Avanti c’è posto! e Umberto D.
Ma la trovata mirabolante sembra appartenere a De Robertis,
negli Scrittori del Novecento: «Libri avventurosi, diari nudi e
distaccati, paragrafi di saporitissima scrittura, rappresentazioni
frescamente epiche, confessioni coraggiose e crudeli non c’erano
mancati che sopravanzassero il livello mediocre delle false
cronache, o della letteratura male spesa, o della rettorica eroica: bei
nomi tutti, Mussolini, Soffici, Baldini, Comisso, Stuparich,
Stanghellini...: ma questi cinque capitoli di Gadda?». Hic Rhodus!
Su! Su! Allez hop! Qui si dà il culo, o si muore! E invece, la morale
del mirabolante brano è questa: «Solo la guerra, e la mortale fatica,
sanno sprigionarlo da sé; altrimenti egli non sa guardarsi
dall’indulgere ai mille richiami e, così indulgendo, un poco perdersi».
Un poco perdersi! «La fermentante forza della guerra, la vera
musa di Gadda, la salvatrice!». Eppure, in quella mesta pratica
letteraria di paginette «ben scritte» e di giardinetti ordinatini, di
velleità rientrate e di reverenze funzionali, di animucce belle e di
candeline spente, alle Giubbe Rosse, la derisoria violenza della sua
scrittura esplodeva esasperata ed esplicita, davanti alle feluche e
alle pantofole, contestando insieme il linguaggio e la parodia, e le
osservanze per i realismi e i crocianesimi, tra il ron-ron rondesconeoclassico-fascistello e il pio-pio pretino-crepuscolare-ermetico, in
schegge di incandescente (espressionistica, pirotecnica)
espressività... Proprio come per Rabelais o Céline e Joyce che gli
sarebbero poi stati accostati, «a braccio» e «a orecchio», i suoi
messaggi fanno a pezzi ogni codice: spiritate e irritate, le sue
invenzioni verbali dileggiano significati e significanti; devastano ogni
funzione o finalità comunicativa; rappresentano innanzitutto se
stesse, e i propri fantasmi, in un foisonnement inaudito e implacabile
di spettacolari idioletti... Senza ‘metafore’ di tutt’altro, o stanchi ‘fils
rouges’ o facili ‘flâneries’ per voi piccini...
Ma da questi spezzoni affettivamente inventariati e tesoreggiati –
vocaboli dialettali e stranieri, termini scientifici e triviali, vezzi eruditi,
definizioni tecniche, deformazioni macaroniche, neologismi
saporitissimi, stilemi personalissimi, omofonie-calembour, grotteschi
ossimori, onomatopee sgangherate, tautologie barocche e brianzole,
inimitabili invettive ipocondriache... – una critica più giovane e
sofisticata (Citati, Gramigna, Guglielmi...) sarebbe risalita attraverso
un’appassionata analisi stilcritica ed extra-ideologica alla vertiginosa
complessità dei macchinosi interessi intellettuali dell’Ingegnere: la
Storia e il Positivismo, Einstein e Leibniz, Spinoza e Michelet, e le
matematiche e una filologia ‘selvaggia’ e una psicanalisi ‘meccanica’
e un’oscura fenomenologia del povero Inconscio «umiliato e
offeso»... E una concrezione palpitante e dolente della nostra
fisiologia culturale: Parini e Dossi, Manzoni e Marinetti, i Verri e
D’Annunzio, Porta e Rajberti e il Romanticismo e il Positivismo e la
Scapigliatura poco amata e il traumatico impatto con due realtà
atroci quali la Grande Guerra e Roma... Così, nel magma delirante
dove anche molti recensori «di mezzo» scorgevano tutt’al più
coacervi o congerie di tipo neurotico o materico, un nuovo saggista
sapienziale come Gian Carlo Roscioni arriva piuttosto a individuare
nel groviglio e nel pasticcio un’oscura tecnica conoscitiva e
un’arcana fisiologia dell’Universo.
Appunto. La complessa ricchezza linguistica e tematica dell’opera
gaddiana, così visceralmente composta e tramata, e
sardanapalesca, e pantagruelica, continua a sollecitare una pluralità
di letture, a diversi livelli, lungo differenti parametri, secondo i più
svariati presupposti e pregiudizi: a costo di razionalizzare fin troppo
lucidamente attraverso nitidi procedimenti di schede e referti quel
suo atrabiliare viluppo di fantasticate irrisioni e di furie
«compossibili»... Addirittura, i mirabili «disegni milanesi»
dall’Adalgisa alla Cognizione del dolore possono presentarsi ai nuovi
lettori d’oggi come una disperata morfologia crepuscolareespressionistica della decadenza della borghesia illuministica e poi
romantica e poi nazionalistica e industriale (e sempre ‘patriottica’) in
una Lombardia che dopo il Duce e Craxi delega la propria immagine
e rappresentanza non più a Corso Venezia o a Foro Bonaparte o al
Cappuccio, ma ai ragionieri e geometri del Longone e Segrino già
abominati dal Nostro.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :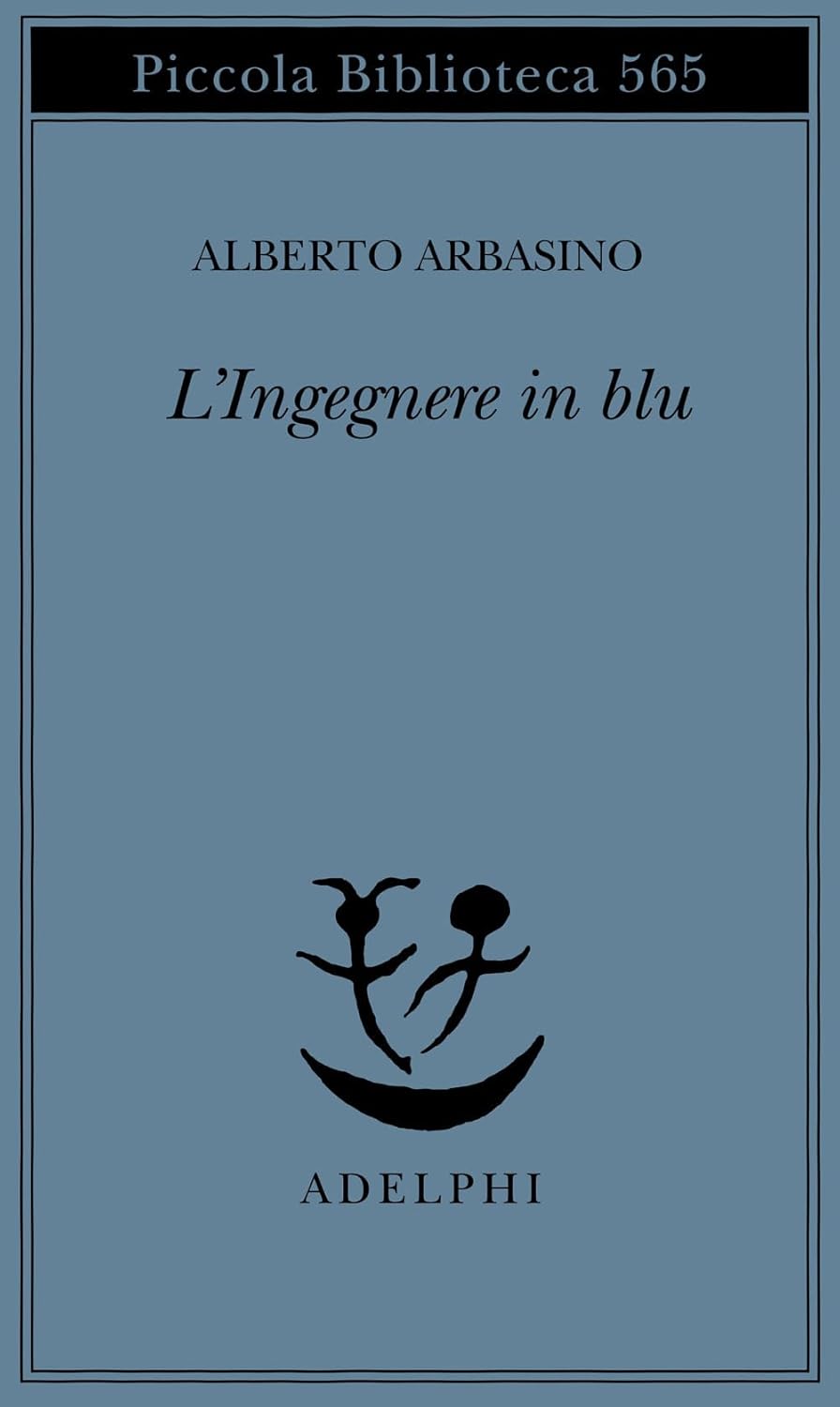



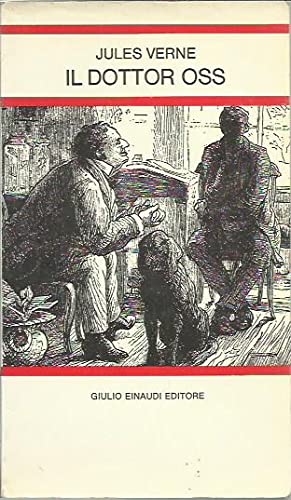
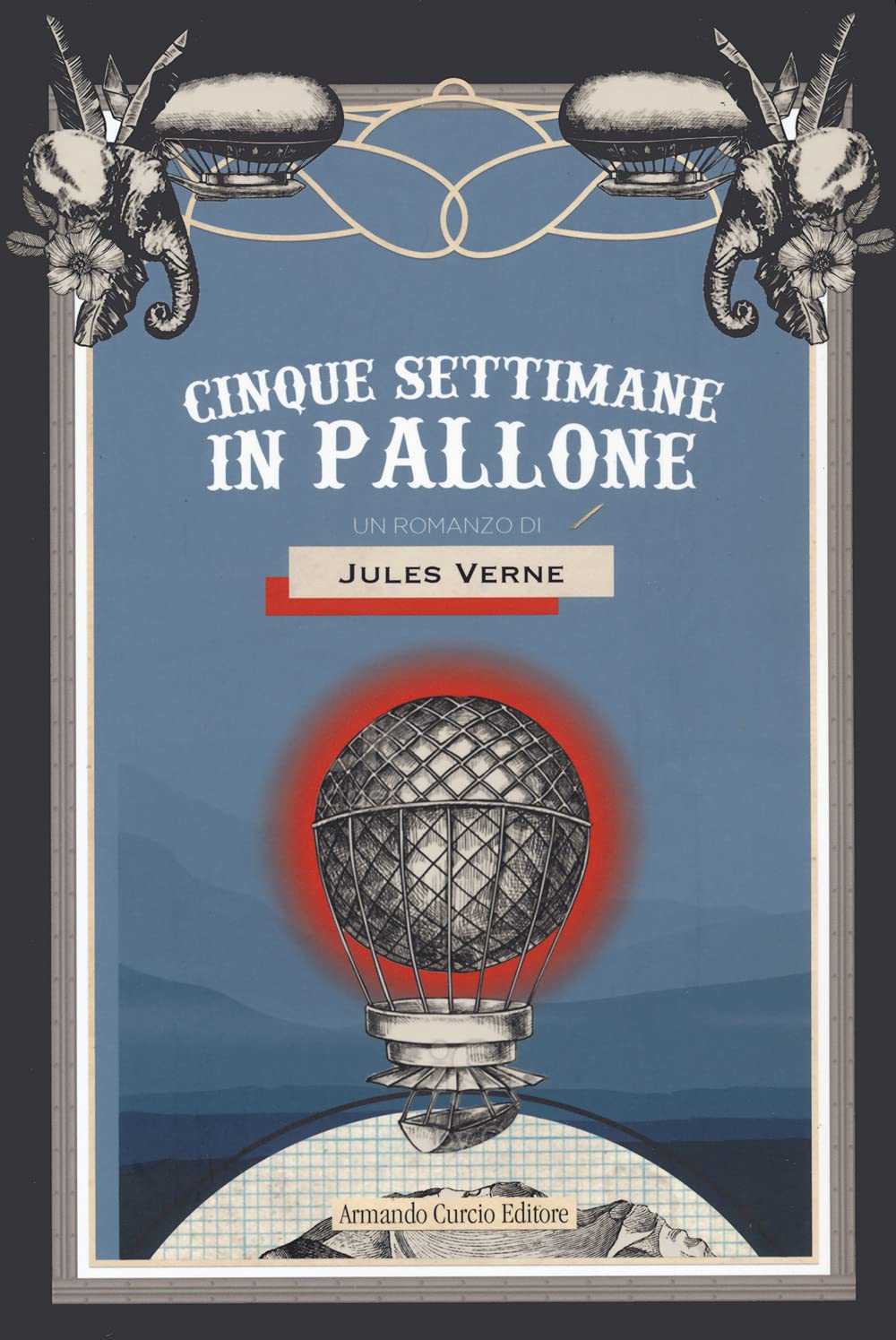
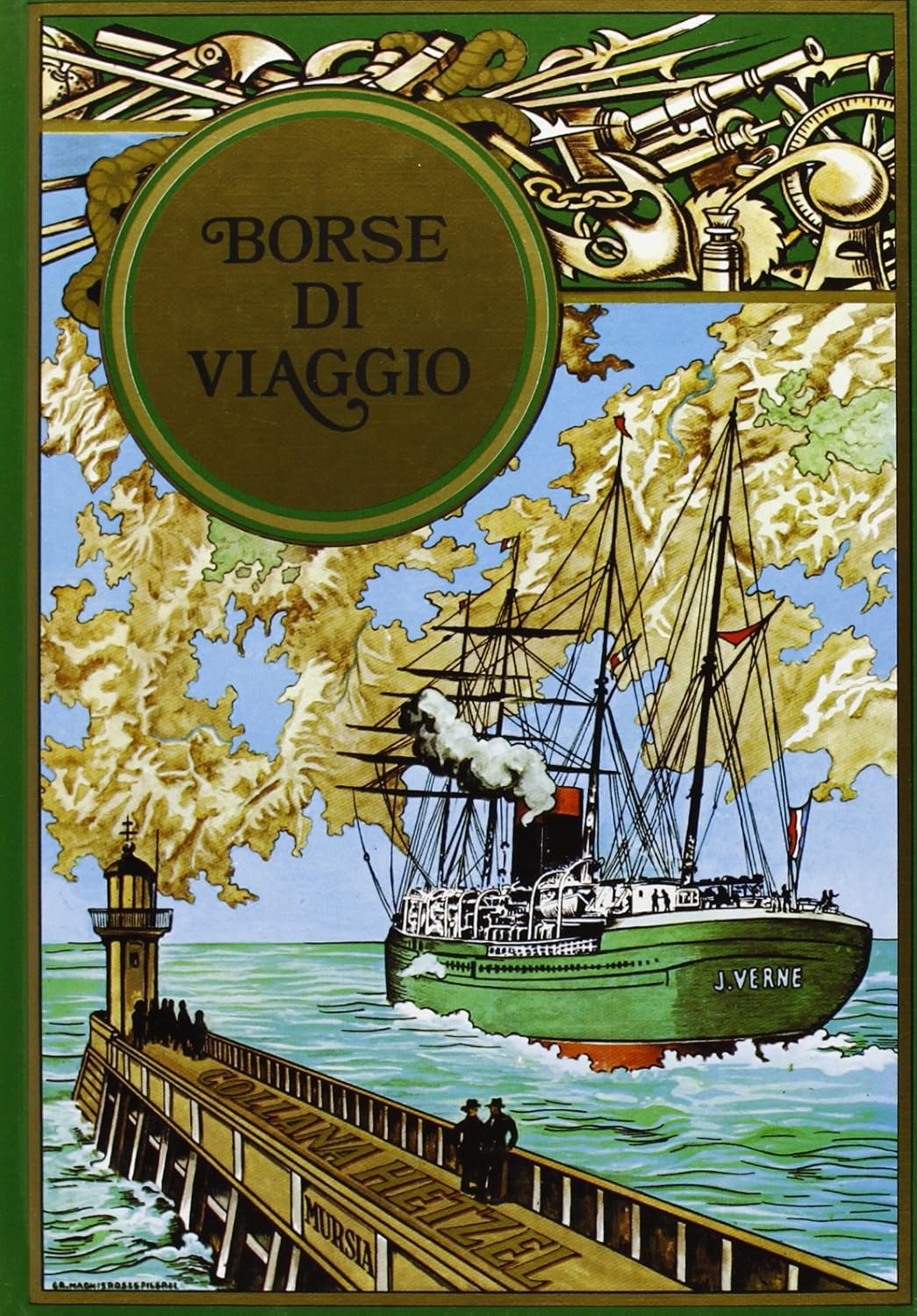
Commento all'articolo