L’esilio impossibile: Stefan Zweig alla fine del mondo – George Prochnik
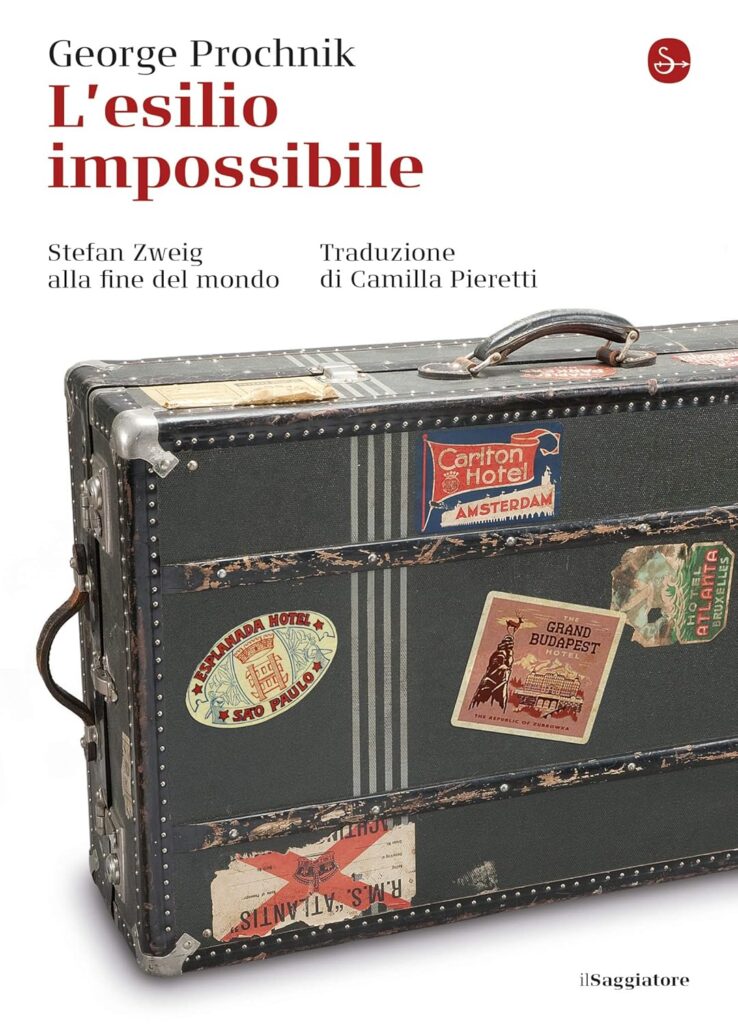
SINTESI DEL LIBRO:
Il 4 giugno 1941, al calar delle tenebre, una ragguardevole folla di
profughi europei di ogni estrazione sociale si presentò al Wyndham
Hotel, nel centro di Manhattan, per un evento senza precedenti:
Stefan Zweig dava un cocktail party. Era il primo ricevimento di
grosse dimensioni che organizzava da quando aveva lasciato la sua
casa e la prima moglie Friderike a Salisburgo, sette anni prima. Anzi,
in realtà non avrebbe mai potuto organizzare un evento simile
neppure in Austria, dato che al Wyndham aprì le porte agli émigrés
invitando chiunque conoscesse. Per l’occasione, Klaus Mann arrivò
fin dalla casa di Brooklyn Heights che condivideva, tra gli altri, con
W.H. Auden e Gypsy Rose Lee. Hermann Broch, la cui salute
cagionevole non ne spegneva il desiderio di vedere gli amici, molto
probabilmente sarà arrivato da Princeton in treno. Il romanziere
tedesco Hermann Kesten e Jules Romains, presidente del Pen
International, non avranno voluto esimersi dal partecipare. Friderike
Zweig, la cui vita era ancora profondamente intrecciata con quella di
Stefan, fu certamente invitata.
Vedere questo gruppo di uomini e donne – molti dei quali ora
vivevano al limite dell’indigenza e avevano sofferto disgrazie ben
peggiori di quelle toccate a Zweig prima di arrivare in America –
diretto al lussuoso albergo avrà suscitato un certo stupore nei
dintorni di Park Avenue, appena a est del Wyndham. Come annotato
qualche tempo dopo il ricevimento da un sociologo émigré: «Un
profugo è una novità, dieci profughi sono una noia, cento profughi
sono una minaccia».
Tornato a Manhattan a fine gennaio dopo un ciclo di conferenze in
Sudamerica, Zweig aveva fatto del suo meglio per evitare la fitta
schiera di conoscenti finiti come lui nella città. Per tutto l’inverno
aveva condotto quella che definiva un’esistenza da eremita. La sua
vita sociale si era limitata ad Alfred, il maggiore dei suoi fratelli, che
aveva guidato l’azienda tessile di famiglia in Europa e, prima
dell’ascesa di Hitler, era riuscito a trasferire abbastanza fondi da
stabilirsi nell’Upper East Side; a Ben Huebsch, il suo fedele editore
della Viking Press; all’adorata nipote di Lotte, Eva, che a soli undici
anni era stata mandata negli Stati Uniti per sfuggire ai
bombardamenti e di cui gli Zweig erano tutori; e a Friderike. Con
l’arrivo della primavera, però, le barriere che aveva tentato di erigere
per prendere le distanze dalla comunità di émigrés avevano iniziato
a sgretolarsi, mandandolo sull’orlo di una crisi di nervi.
Il tema più frequente, nelle lettere scritte a New York, è il senso di
soffocamento causatogli dalle esigenze degli altri profughi. «Dover
vedere cinque o sei persone ogni giorno mi esaurisce» lamentava.
«Il telefono inizia a suonare all’alba e non smette fin nel cuore della
notte… Ormai conosco tra le 200 e le 300 persone a New York e
tutte loro si offenderebbero se mi rifiutassi di riceverle.» Cosa ancor
peggiore, si preoccupava Zweig, al contrario di Thomas Mann lui
non aveva acquisito la benché minima capacità di economizzare il
proprio tempo. «Mentre lui riesce a liberarsi di qualunque visitatore
nel giro di un’ora, i miei non si fermano mai meno di tre.»
A quanto pare, dunque, a nutrire perplessità su quel ricevimento
non era soltanto il vicinato. Molti invitati, consci della deriva solitaria
adottata da Zweig, si saranno chiesti cosa ci facessero lì. Che il loro
anfitrione avesse qualche importante annuncio da fare? Che avesse
finalmente deciso di dire la sua sulla difficile situazione degli ebrei in
Europa esortando un intervento militare, come i suoi compagni di
sventura si auguravano facesse ormai da tempo? Uno dopo l’altro,
gli ospiti si riversarono nel piccolo atrio dell’albergo e da lì in
ascensore per poi bussare alla porta di Zweig, andando ad
aggiungersi alla densa moltitudine che saturava le due stanze di
quella suite dall’aria straordinariamente modesta. Dalle finestre
ammirarono quelle che una volta Zweig aveva definito i «miliardi di
stelle artificiali» di Manhattan, disposte a adornare grattacieli che
parevano «blocchi di roccia dalle estremità puntute».
Chiacchierarono. Bevvero schnapps. Mangiarono salatini. Si
guardarono intorno, in attesa di qualcosa in più.
Chi lo conosceva meno potrebbe essere rimasto deluso nel
riscontrare una così scarsa evidenza della tanto millantata ricchezza
di Zweig nelle sue stanze d’albergo di New York. Gli amici a lui più
vicini, però, sapevano che aveva già svenduto tutto, comprese la
sua collezione di centinaia di preziosi manoscritti originali, di cui
aveva conservato solo un ridotto portfolio, e quasi tutta la sua
biblioteca da diecimila volumi. Quel poco che aveva portato con sé
in tutti i suoi viaggi, però, era estremamente significativo: gran parte
di ciò che rimaneva dei suoi tesori era costituita da spartiti musicali,
inclusi diversi pezzi di Mozart, Kurz ist der Schmerz (Breve è il
dolore) di Beethoven, un’opera di Händel e una di Schubert. Aveva
collezionato quasi solo brani della metà degli anni trenta e, quando
nel 1937 disse a uno dei destinatari delle sue lettere che le vere basi
del suo essere risiedevano nell’arte, era alla musica che pensava, in
qualità di mezzo migliore per superare le sofferenze che dividevano
l’umanità, forgiando la solidarietà dello spirito.
Questo tipo di convinzione si rifaceva alla credenza,
profondamente radicata in tutti i viennesi, che la peculiare grazia
della città derivasse dalla sua capacità di combinare sensuali
tradizioni popolari con elevate aspirazioni estetiche. I devoti
sognatori della capitale credevano che Vienna avesse trovato il
modo di modellare lo spirito, convertendolo in materia e unificando
così diversi settori della società. In un suo saggio su Zweig, Klaus
Mann spiega che nella Vienna dell’epoca «i baroni e i cocchieri di
fiacre si capivano alla perfezione: usavano lo stesso vocabolario e
spesso condividevano le stesse idee». In occasione del loro primo
incontro, nel 1930, Zweig illustrò al poeta operaio Walter Bauer la
sua convinzione secondo cui la vita dello spirito fosse radicata nelle
masse incapaci di esprimersi, che costituivano le profondità da cui
sarebbe giunta l’illuminazione. La medesima convinzione potrebbe
spiegare perché abbia conservato con maggiore cura i manoscritti
della sua collezione che erano più scarabocchiati, consunti e
macchiati, a testimonianza degli sforzi compiuti dall’autore per
estrapolare il sublime dal corporeo nel suo momento più tormentato.
A Vienna, il calamaio dell’inchiostro divino era stato rovesciato.
Ovunque nell’aria gli angeli avevano lasciato le loro impronte, in
particolare all’interno dell’ampio teatro dell’Opera, dove Zweig, come
ricorda nella sua autobiografia, si introduceva di nascosto nel
«palcoscenico cui lo spettatore s’accostava con l’emozione di Virgilio
quando ascese le sacre sfere del Paradiso».
Tra gli amici di Zweig c’era chi era convinto che il suo amore per la
musica avrebbe potuto salvarlo, se vi si fosse dedicato più
attivamente. Madame Gisella Selden-Goth, una musicologa con cui
intrattenne una vivace corrispondenza per l’intera durata del suo
esilio, ha dichiarato che, se a Petrópolis Zweig avesse avuto a
disposizione «un’orchestra di musica da camera che suonasse a
casa sua, o la possibilità di ascoltare, di tanto in tanto, un concerto
tenuto da uno dei direttori d’orchestra che conosceva così bene»,
sarebbe riuscito a sopportare la sua angosciosa visione del futuro
dell’umanità e del proprio destino. L’immagine di un’orchestrina da
camera terapeutica, ammassata nel piccolo villino tra le montagne di
Zweig, sull’orlo della densa foresta brasiliana nel 1942 è tanto
improbabile quanto commovente. Di certo Zweig faceva di tutto per
«preservare il mondo della musica puro e libero dalla cacofonia della
politica», come scrisse a un altro amico. Fu anche per questo che
scelse di continuare a lavorare con Richard Strauss anche dopo che
questi fu nominato presidente della Reichsmusikkammer da
Goebbels.
Tuttavia, lo sforzo necessario per mantenere un impossibile
distinguo tra l’arte e gli eventi che dominavano le prime pagine dei
giornali lo condannò a dolorosi contorcimenti. Nel partecipare per
l’ultima volta al festival di Salisburgo, nel 1935, quando era già
partito in esilio volontario dall’Austria, non poté fare a meno di
descrivere la cittadina che si era dimostrata tanto permeabile al
nazionalsocialismo con generosità e amore, celebrandone la
capacità di risolvere «melodiosamente, nella pietra come
nell’atmosfera, ciò che nella realtà di norma si trova brutalmente agli
opposti». Nelle parole di Zweig, Salisburgo aveva appreso il segreto
di questa armonizzazione delle dissonanze grazie alla musica. E «in
quelle rare giornate in cui il cielo si fonde con il panorama», mentre
gli artisti più celebri dell’epoca suonavano «opere sublimi come il
Fidelio, Il flauto magico o Orfeo e Euridice nel cuore di un mondo in
frantumi, in quest’epoca ormai in frantumi, ci si sente attratti verso le
sfere supreme e si sperimenta lo stato di grazia che si produce
solamente quando natura e arte, arte e natura, si scambiano un
bacioSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
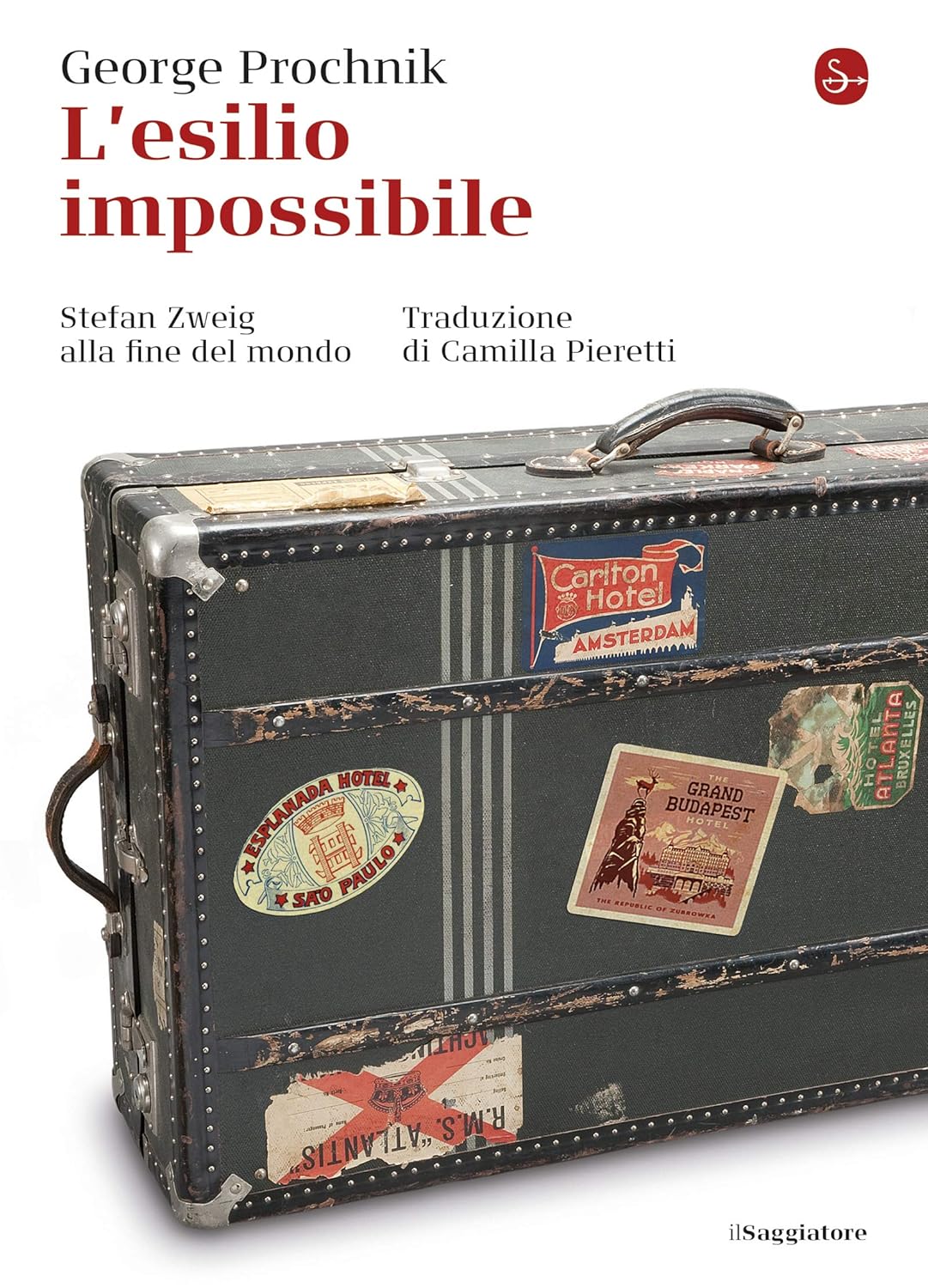






Commento all'articolo