Leonardo. Il genio dell’imperfezione- Vittorio Sgarbi
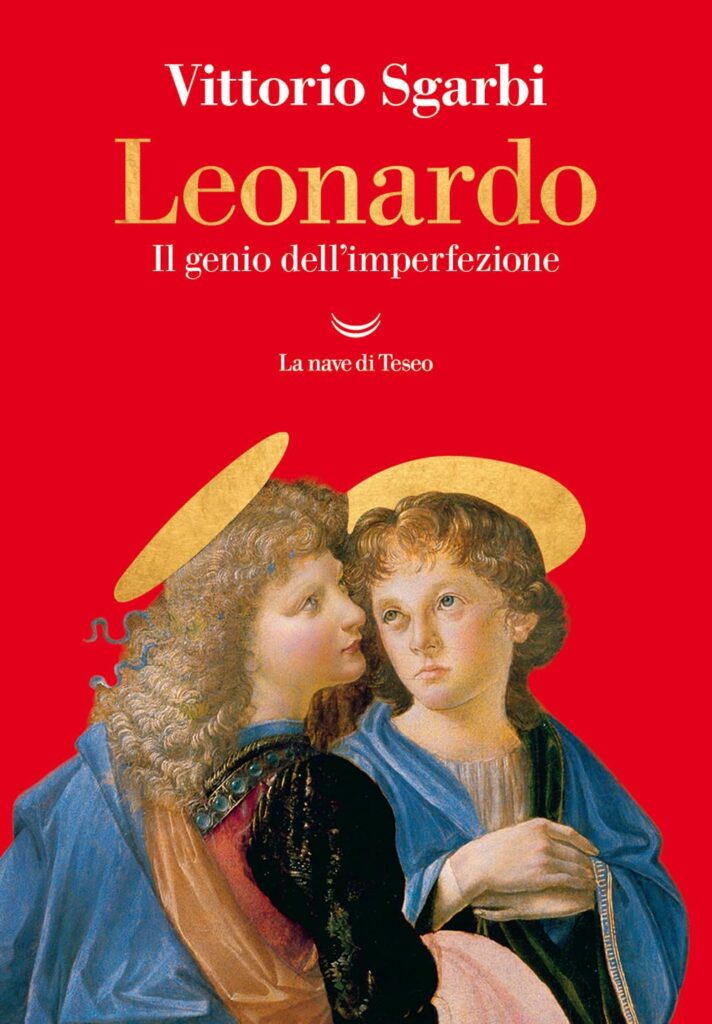
SINTESI DEL LIBRO:
Vasari ci dice di Leonardo tuo quanto è utile per capirne il caraere, il
temperamento, l’umore, e ci racconta anche la sua continua ansia di fare
altro. Scrive Vasari: “volse la natura tanto favorirlo, che dovunque e’
rivolse il pensiero, il cervello e l’animo, mostrò tanta divinità nelle cose
sue”, ecco, la parola “divinità”.
Fin qui ho scrio che la competizione di Leonardo è con Dio, e la
“divinità” delle sue creazioni è quello che appare immediatamente agli
occhi di Vasari – “che nel dare la perfezzione, di prontezza, vivacità,
bontade, vaghezza e grazia, nessun altro mai gli fu pari”. È un’ammissione
importante per Vasari, allievo di Michelangelo, ostile a Leonardo, che
Vasari considerava il più grande degli artisti. Michelangelo, per quanto
grande, aveva il limite della sua perfezione. Leonardo invece aveva una
visione così ampia e così aperta che “nessun altro mai gli fu pari”. “Trovasi
che Lionardo per l’intelligenzia de l’arte cominciò molte cose, e nessuna
mai ne finì.” Leonardo non voleva portare a termine, realizzare un
pensiero, riprodurre una realtà in modo meccanico, con una mimesi
perfea – “parendoli che la mano aggiugnere non potesse alla perfezzione
de l’arte ne le cose che egli si imaginava”; la perfezione era nella sua
mente, la mano poteva trascrivere l’essenziale di quello che lui aveva
sentito e intuito, non tuo, non era importante riprodurre “tuo”.
“Con ciò sia che si formava nella idea alcune difficultà tanto
maravigliose, che con le mani, ancora che elle fussero eccellentissime, non
si sarebbono espresse mai.” Le mani non erano sufficienti a raccontare il
suo sogno, la sua visione, la sua ansia d’infinito. Tuo questo è già chiaro
nella perfea definizione di Vasari, che aveva colto la vera aitudine di
Leonardo, così diversa da quella di ogni altro artista, accanito nel cercare
la perfezione. ando il primo sistematore della grande piura del
Rinascimento, Bernard Berenson, alla fine dell’Oocento iniziò ad
affrontare Leonardo, anche lui, come Vasari, colse una diversità evidente:
“Leonardo è l’unico di cui si possa dire, e in senso assolutamente leerale:
nulla toccò che non tramutasse in bellezza eterna.” Anche Berenson ci
pone la questione di Dio: “alunque cosa tocchi Leonardo diventa
bellezza eterna, che si trai della sezione di un cranio, della struura di
una foglia, dell’anatomia di muscoli, col suo istinto della linea e del
chiaroscuro egli li trasfigurò per sempre in valori che creano la vita.”
Leonardo da Vinci, Testa di fanciulla (dea La Scapigliata), part., Galleria
nazionale, Parma
I disegni di Leonardo concorrono con la vita, sono vivi. Leonardo crea
vita, non riproduce la realtà. E Sebastiano Serlio, il grande studioso di
architeura, conclude con una definizione che rispecchia quanto ho fin qui
scrio: “Nel vero la teorica sta nell’intelleo, ma la pratica consiste nelle
mani.” Intelleo per i pensieri, pratica nelle mani – “e perciò lo
intendentissimo Leonardo Vinci non si contentava mai di cosa ch’ei
facesse, e pochissime opere condusse à perfeione: e diceva sovente la
causa esser questa: che la sua mano non poteva giungere all’intelleo”.
C’è una perfea concordia nell’interpretazione di Leonardo. Nel
ricostruire la sua vita, Vasari ci racconta alcuni passaggi fondamentali.
“Adunque mirabile e celeste fu Lionardo, figlio di Ser Piero da Vinci, che
veramente bonissimo padre e parente gli fu, nell’aiutarlo in giovanezza. E
massime nella erudizione e principii delle leere, nelle quali egli arebbe
fao profio grande, se egli non fusse stato tanto vario et instabile.”
Leonardo poteva essere un grande scriore, un grande leerato, ma era
“vario e instabile”. Appena cominciava a fare qualcosa, subito si annoiava
e pensava di fare altro – “percioché egli si mise a imparare molte cose e,
cominciate, poi l’abbandonava”. Torna costantemente questa idea
dell’incompiuto, dell’imperfeo – “Ecco nell’abbaco egli in pochi mesi
ch’e’ v’aese, fece tanto acquisto, che movendo di continuo dubbi e
difficultà al maestro che gl’insegnava,” – è tipico di Leonardo il dubbio,
creare difficoltà, generare incertezza in chi gli insegna – “bene spesso lo
confondeva”. Il maestro si confondeva davanti a un allievo tanto critico.
“Dee alquanto d’opera alla musica” – e qui emerge il suo mestiere
primario: il “cantautore”. Leonardo sa che la musica è la prima espressione
della creatività dell’uomo. La scriura, l’alfabeto hanno
seimilacinquecento anni, la piura dodici-quindicimila, la musica invece è
il primo modo con cui, araverso la voce, l’uomo esprime un’emozione, un
sentimento. Il dipinto rimane sulla pietra, nel mondo primitivo, la musica
e la danza si esauriscono nell’hic et nunc, accadono nel momento in cui le
vediamo, poi spariscono, non rimangono. Sono due arti straordinarie,
effimere, come l’uomo.
Leonardo da Vinci e allievi, La Vergine delle Rocce (seconda versione), part.,
National Gallery, Londra
La danza nasce per accompagnare gli umori del cielo, i lampi, i tuoni, le
tempeste; l’uomo si agita, si muove, reagisce e trasforma in rito le sue
emozioni che diventano arte nell’espressione dei corpi e della voce. La
musica e la danza sono espressioni primitive della nostra dimensione
creativa, in esse c’è un rapporto tra dimensione fisica e pensiero. Dunque:
“tosto si risolvé a imparare a sonare la lira, come quello che da la natura
aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria, onde sopra quella cantò
divinamente allo improviso.” Ancora oggi in Toscana sopravvive la
tradizione degli improvvisatori di filastrocche, che non recitano versi a
memoria ma raccontano all’impronta, magari descrivendo la felicità di un
incontro. Leonardo, ci dice Vasari, era questo: un cantautore perfeo.
“Nondimeno benché egli a sì varie cose aendesse, non lasciò mai il
disegnare et il fare di rilievo, come cose che gli andavano a fantasia più
d’alcun’altra.” Disegnare è la sua arte principale, perché il disegno è la
trascrizione di un pensiero o di una cosa, è intuizione; è il modo più
immediato e direo per avere memoria di quanto si è visto. Allora il suo
genitore adoivo, Ser Piero da Vinci, cerca di capire quale fosse la strada
maestra per una personalità così stratificata e a chi affidarlo perché
potesse affinare queste doti: “E non solo esercitò una professione, ma tue
quelle ove il disegno si interveniva. Et avendo uno intelleo tanto divino”
– ancora una volta si parla di dimensione divina per Leonardo – “e
maraviglioso, che essendo bonissimo giometra, non solo operò nella
scultura e nell’architeura, ma la professione sua volse che fusse la
piura.” Vasari ci indica anche un’altra dote di Leonardo, molto
importante per seguire la sua vita: “Mostrò la natura nelle azzioni di
Lionardo tanto ingegno, che ne’ suo’ ragionamenti faceva con ragioni
naturali tacere i doi.” Leonardo era sempre capace di creare difficoltà a
chi gli insegnava qualcosa, dalla matematica alla grammatica – “Fu pronto
et arguto, e con una perfea arte di persuasione mostrava la difficultà del
suo ingegno,” – in questo caso difficoltà vuol dire complicazione,
complessità del suo ingegno – “che nelle cose de’ numeri facea muovere i
monti, tirava i pesi, e fra le altre parole mostrava volere” – e qui sta un
aspeo molto indicativo della personalità di Leonardo: è talmente capace
di sedurre con la parola, talmente persuasivo da convincere le persone di
cose impossibili. È evidente che un edificio che ha delle fondamenta non
può disporre di ruote per muoversi. Leonardo invece convince il
malcapitato interlocutore che si possono meere le ruote soo il bel San
Giovanni che è il tempio dove si incontravano Dante e Beatrice – “alzare il
tempio di San Giovanni di Fiorenza e soomeervi le scalee, senza
ruinarlo, e con sì forti ragioni lo persuadeva che pareva possibile,
quantunque ciascuno, poi che si era partito, conoscesse per se medesimo
la impossibilità di cotanta impresa”. indi era capace di convincere
dell’impossibile salvo che, “quando se ne andava”, l’interlocutore si
rendeva conto dell’assoluta impossibilità di quanto aveva creduto possibile
grazie alle parole di Leonardo. “Era tanto piacevole nella conversazione
che tirava a sé gli animi delle genti; e non avendo egli, si può dir, nulla e
poco lavorando.” Leonardo non voleva essere obbligato a lavorare, voleva
dedicarsi a speculazioni intelleuali. “Del continuo tenne servitori e
cavalli, de’ quali si dileò molto, e particularmente di tui gli altri animali,
i quali con grandissimo amore e pazienzia sopportava e governava.” E qui
emerge ancora una volta la modernità di Leonardo: “E mostrollo che
spesso passando da i luoghi dove si vendevano uccelli, di sua mano
cavandoli di gabbia e pagatogli a chi li vendeva il prezzo che n’era chiesto,
li lasciava in aria a volo, restituendoli la perduta libertà.” Ecco, quando
vedeva un uccellino nella gabbia, Leonardo lo liberava. Solo un talento
fuori di regola poteva comportarsi in questo modo, comprare un uccellino
e dargli la libertà invece di portarlo a casa per il piacere futile di qualche
bambino. esto è Leonardo nella singolare ricostruzione che ne dà il
Vasari. E ora entriamo nella storia delle opere.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
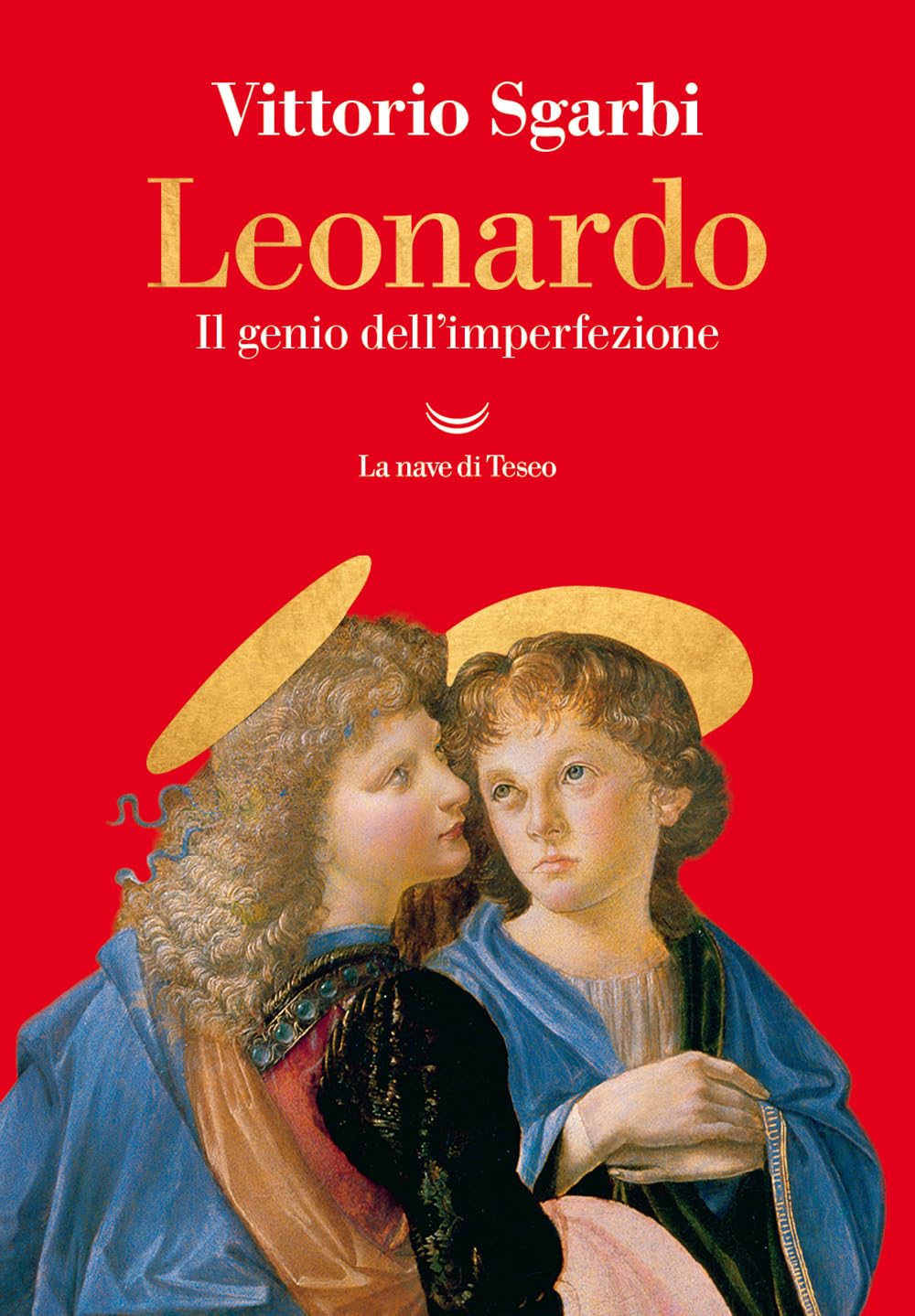






Commento all'articolo