L’esoterismo di Dante – René Guénon
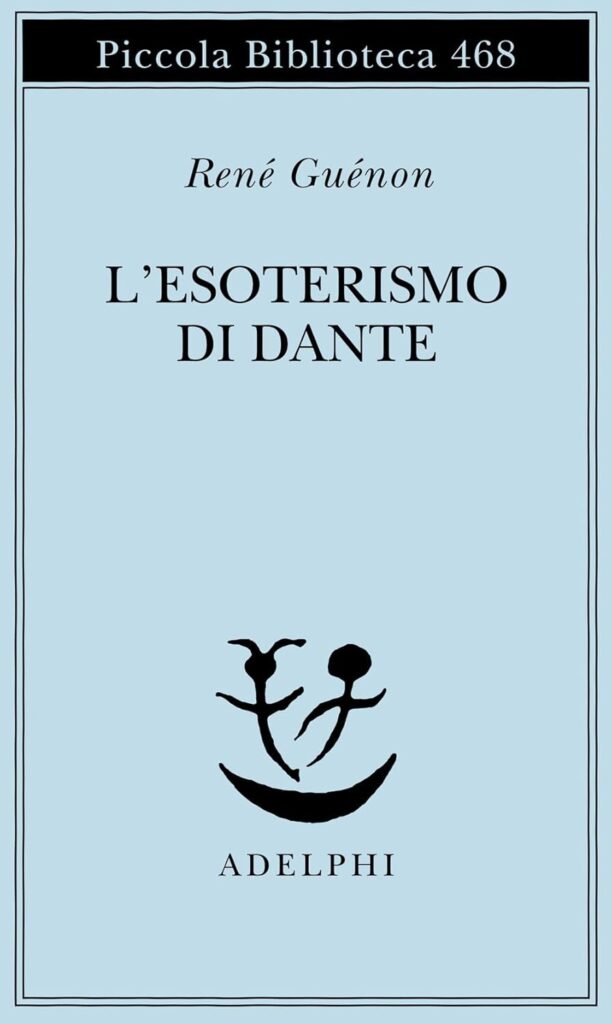
SINTESI DEL LIBRO:
Con queste parole [Inferno, IX, 61-63], Dante indica in modo molto
esplicito che nella sua opera vi è un senso nascosto, propriamente
dottrinale, di cui il senso esteriore e apparente è soltanto un velo, e
che deve essere ricercato da coloro i quali sono capaci di penetrarlo.
Altrove, il poeta va più lontano ancora, poiché dichiara che tutte le
scritture, e non soltanto quelle sacre: «si possono intendere e
debbonsi sponere massimamente per quattro sensi» [Convito, t. II,
cap. 1°]. È evidente, d’altronde, che questi diversi significati non
possono in nessun caso distruggersi od opporsi, ma debbono invece
completarsi ed armonizzarsi come le parti di uno stesso tutto, come
gli elementi costitutivi di una sintesi unica.
Così, che la Divina Commedia, nel suo insieme, possa interpretarsi
in più sensi, è una cosa che non può essere messa in dubbio,
poiché abbiamo a tal riguardo proprio la testimonianza del suo
autore, sicuramente meglio qualificato di ogni altro per informarci
delle sue intenzioni. La difficoltà comincia solamente quando si tratta
di determinare questi diversi significati, soprattutto i più elevati o i più
profondi, e anche a tal riguardo cominciano naturalmente le
divergenze di vedute fra i commentatori. Questi si trovano
generalmente d’accordo nel riconoscere, sotto il senso letterale del
racconto poetico, un senso filosofico, o piuttosto filosofico-teologico,
ed anche un senso politico e sociale; ma, con il senso letterale
stesso, non si arriva così che a tre sensi, e Dante ci avverte di
cercarne quattro; quale é dunque il quarto? Per noi, non può essere
che un senso propriamente iniziatico, metafisico nella sua essenza,
ed al quale si riattaccano molteplici dati, i quali senza essere tutti
d’ordine puramente metafisico, presentano un carattere ugualmente
esoterico. È precisamente in ragione di questo carattere che un tal
senso profondo è completamente sfuggito alla maggior parte dei
commentatori; e tuttavia, se viene ignorato o misconosciuto, gli altri
sensi stessi non possono essere afferrati che parzialmente, poiché
esso è come il loro principio, nel quale la loro molteplicità si coordina
e si unifica.
Coloro stessi che hanno intravisto questo lato esoterico dell’opera di
Dante si sono molto ingannati quanto alla sua vera natura, dato che,
il più delle volte, non avevano la reale comprensione di queste cose,
e dato che la loro interpretazione risentiva di pregiudizi che era loro
impossibile evitare. Così Rossetti e Aroux, che furono fra i primi a
segnalare l’esistenza di questo esoterismo, credettero poter
concludere all’«eresia» di Dante, senza rendersi conto che così
mischiavano delle considerazioni riferentisi a dominii del tutto
differenti; la verità è che, pur sapendo certe cose, ve ne sono molte
altre che essi ignoravano e noi cercheremo di indicarle, senza avere
affatto la pretesa di dare un’esposizione completa di un soggetto che
sembra veramente inesauribile.
La questione per Aroux si è posta in questi termini: Dante fu cattolico
o albigese? Per altri, essa sembra piuttosto porsi nel modo
seguente: fu cristiano o pagano [Cf. Arturo Reghini, L’Allegoria
esoterica di Dante, nel «Nuovo Patto», settembre-novembre 1921,
pp. 541-548]? Da parte nostra, non pensiamo che questo sia il punto
di vista da cui porsi, poiché il vero esoterismo è una cosa del tutto
differente dalla religione esteriore, e, se ha qualche rapporto con
questa, non può essere che in quanto trova nelle forme religiose un
modo d’espressione simbolico; d’altronde, importa poco che queste
forme siano quelle di tale o di tal’altra religione, poiché ciò di cui si
tratta è l’unità dottrinale essenziale la quale si dissimula dietro la loro
apparente diversità. Tale è la ragione per cui gli iniziati antichi
partecipavano indistintamente a tutti i culti esteriori, secondo i
costumi stabiliti nei diversi paesi dove si trovavano; ed è anche
perché Dante vedeva questa unità fondamentale, e non per l’effetto
di un «sincretismo» superficiale, che ha usato indifferentemente,
secondo i casi, un linguaggio preso sia dal cristianesimo e sia
dall’antichità greco-romana. La metafisica pura non è né pagana né
cristiana, è universale; i misteri antichi non erano paganesimo, ma vi
si sovrapponevano [Dobbiamo anche dire che preferiremmo un altro
termine a quello di «paganesimo», imposto da un lungo uso, ma che
all’origine fu soltanto un termine di disprezzo applicato alla religione
greco-romana quando questa, all’ultimo grado della sua decadenza,
si trovò ridotta allo stato di semplice «superstizione» popolare]; e
parimenti, nel medio-evo, vi furono organizzazioni il cui carattere era
iniziatico e non religioso, ma che avevano la loro base nel
cattolicesimo. Se Dante appartenne a qualcuna di queste
organizzazioni, il che ci sembra incontestabile, non è dunque questa
una ragione per dichiararlo «eretico»; coloro che pensano in tal
modo hanno del medio evo una idea falsa o incompleta; non ne
vedono per così dire che l’esteriore, poiché, per tutto il resto, non vi
è più nulla nel mondo moderno che possa servir loro da termine di
paragone.
Se tale fu il carattere reale di tutte le organizzazioni iniziatiche, non
vi furono che due casi per i quali l’accusa di «eresia» potette essere
portata contro alcune di esse o contro qualcuno dei loro membri, e
ciò per nascondere altre accuse molto meglio fondate o per lo meno
più vere, ma che non potevano essere formulate apertamente. Il
primo di questi due casi è quello per cui alcuni iniziati hanno potuto
abbandonarsi a divulgazioni inopportune, a rischio di gettare disturbo
negli spiriti non preparati alla conoscenza delle verità superiori, ed
anche di provocare disordini dal punto di vista sociale; gli autori di
simili divulgazioni avevano il torto di creare essi stessi una
confusione fra i due ordini esoterico e exoterico, confusione che,
insomma, giustificava sufficientemente il rimprovero di «eresia»; e
questo caso si è presentato diverse volte nell’Islam [Facciamo
specialmente allusione al celebre esempio di El-Hallaj, messo a
morte a Baghdad nell’anno 309 dell’Egira (921 dell’era cristiana), e
la cui memoria è venerata da coloro stessi che stimano che fu
condannato giustamente per le sue imprudenti divulgazioni], dove
tuttavia le scuole esoteriche non incontrano normalmente alcuna
ostilità da parte delle autorità religiose e giuridiche rappresentanti
l’exoterismo. In riguardo al secondo caso, è quello per cui la stessa
accusa fu semplicemente presa a pretesto da un potere politico per
rovinare degli avversari che esso stimava tanto più temibili quanto
più erano difficili a raggiungere con i mezzi ordinarii; la distruzione
dell’ordine del Tempio ne è l’esempio più celebre, e questo
avvenimento ha precisamente un rapporto diretto col soggetto del
presente studioSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
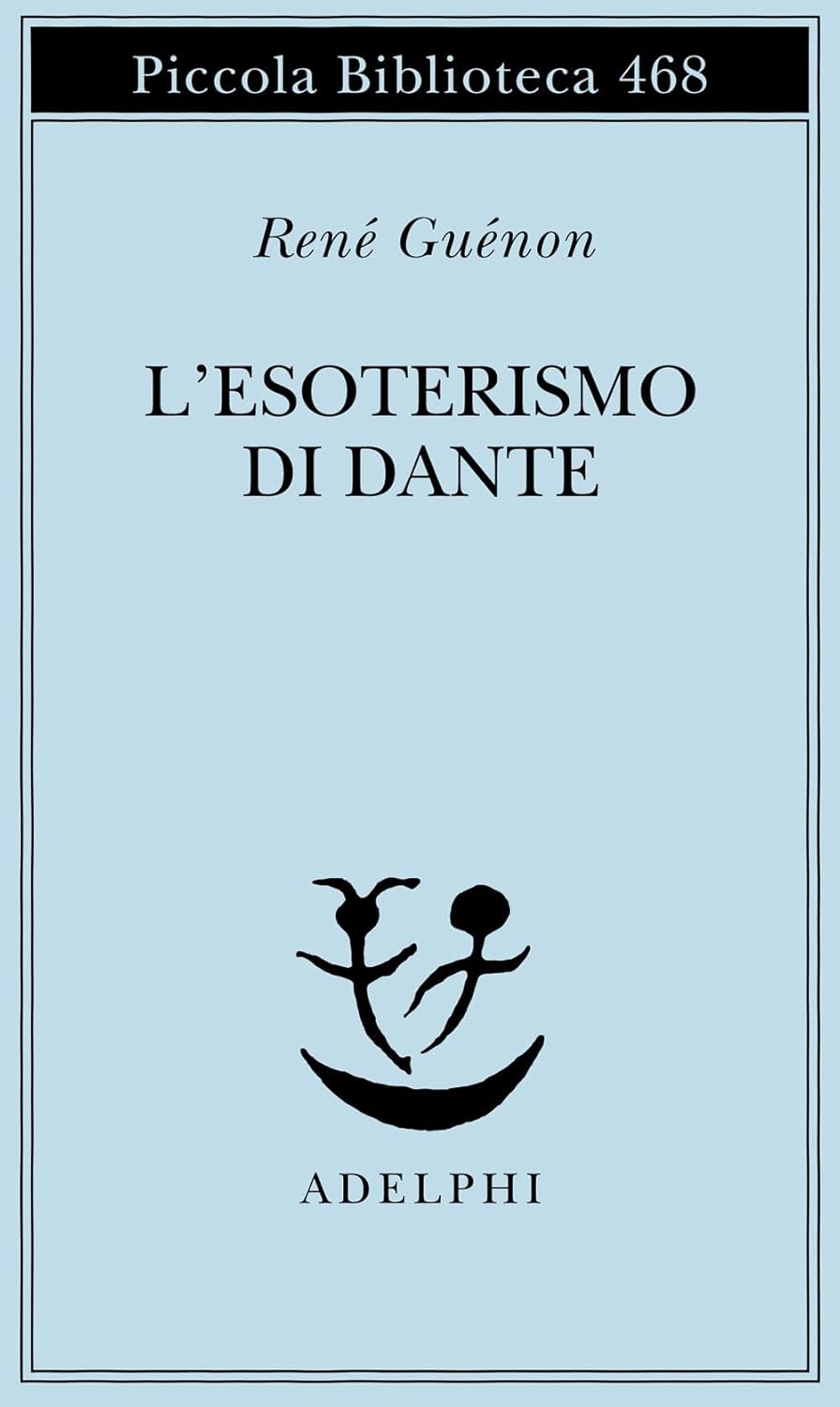






Commento all'articolo