L’arte moderna 1770-1970-L’arte oltre il Duemila – Giulio C. Argan
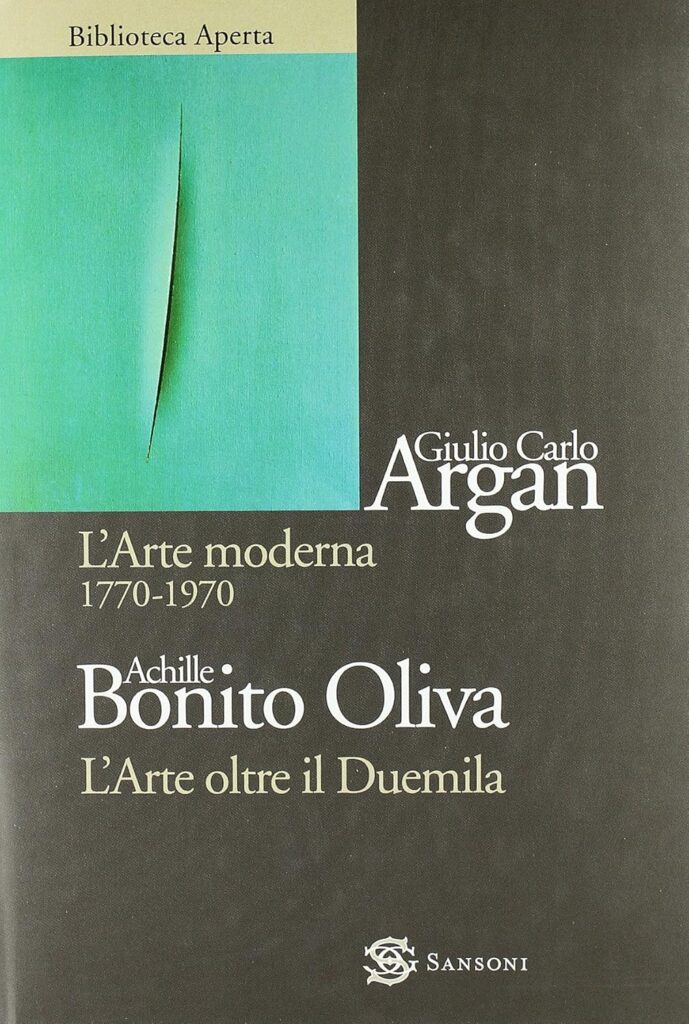
SINTESI DEL LIBRO:
Trattando dell'arte che si è sviluppata in Europa e, più tardi, nell'America del
Nord nel corso del XIX e XX secolo ricorreranno spesso i termini "classico" e
"romantico". La cultura artistica moderna appare infatti imperniata sulla relazione
dialettica, se non di antitesi, tra questi due concetti. Essi implicano il riferimento a
due grandi fasi della storia dell'arte: il "classico" è legato all'arte del mondo
antico, greco-romano, ed a quella che veniva considerata la sua rinascita nella
cultura umanistica del XV e XVI secolo; il "romantico" all'arte cristiana del
Medioevo e più precisamente al Romanico e al Gotico. Si è proposta anche, dal
Worringer, una distinzione per aree geografiche: classico il mondo mediterraneo,
dove il rapporto degli uomini con la natura è chiaro e positivo, romantico il mondo
nordico, in cui la natura è una forza misteriosa, spesso ostile. Sono due diverse
concezioni del mondo e della vita, connesse a due diverse mitologie, che
tendono a confrontarsi e a integrarsi quanto più si delinea nelle coscienze, con le
ideologie della Rivoluzione francese e le conquiste napoleoniche, l'idea di una
possibile unità culturale, forse anche politica, europea. Tanto il classico che il
romantico sono stati teorizzati tra la metà del secolo XVIII e la metà del
successivo: il classico principalmente dal Winckelmann e dal Mengs, il romantico
dai fautori della rinascita del Gotico e dai pensatori e letterati tedeschi (i due
Schlegel, Wackenroder, Tieck, per cui l'arte è rivelazione del sacro ed ha
necessariamente una sostanza religiosa). Teorizzare periodi storici significa
trasporli dall'ordine dei fatti a quello delle idee o dei modelli: è infatti a partire
dalla metà del XVIII secolo che ai trattati o alle precettistiche del Rinascimento e
del Barocco si sostituisce, a un più elevato livello teoretico, una filosofia dell'arte
(estetica). Se c'è un concetto dell'arte assoluta, e questo concetto non si formula
come norma da mettere in pratica ma come un modo di essere dello spirito
umano, non si può che tendere a quel fine ideale, pur sapendo che non si potrà
raggiungerlo poiché raggiungendolo finirebbe la tensione e quindi l'arte stessa.
Col formarsi dell'estetica o filosofia dell'arte l'attività dell'artista non viene più
considerata come un mezzo di conoscenza del reale, di trascendenza religiosa o
di esortazione morale. Con il pensiero classico di un'arte come mimesi (che
3
implicava i due piani del modello e dell'imitazione) entra in crisi l'idea dell'arte
come dualismo di teoria e prassi, intellettualismo e tecnicismo: l'attività artistica
diventa un'esperienza primaria e non più dedotta, che non ha fini al di là del
proprio farsi. Alla struttura binaria della mimesis succede la struttura monistica
della poiesis, cioè del fare artistico, e quindi l'opposizione tra la certezza teorica
del classico e l'intenzionalità romantica (poetica).
Nel momento stesso in cui si afferma l'autonomia dell'arte si pone il problema del
suo coordinamento con le altre attività, cioè del suo posto e della sua funzione
nel quadro culturale e sociale dell'epoca. Affermando l'autonomia ed assumendo
l'intera responsabilità del proprio agire l'artista non si astrae dalla realtà storica,
anzi dichiara esplicitamente di essere e voler essere del proprio tempo e spesso
affronta, come artista, tematiche e problematiche attuali.
La cesura nella tradizione si determina con la cultura dell'Illuminismo. La natura
non è più l'ordine rivelato e immutabile della creazione, ma l'ambiente
dell'esistenza umana; non è più il modello universale, ma uno stimolo a cui
ciascuno reagisce in modo diverso; non è più la fonte di tutto il sapere, ma
l'oggetto della ricerca conoscitiva. È chiaro che il soggetto tende a modificare la
realtà oggettiva, sia nelle cose concrete (specialmente l'architettura, l'arredo
ecc.) sia nel modo con cui se ne prende nozione e coscienza: quello che era il
valore a priori e assoluto della natura come creazione ne varietur e modello di
ogni umana invenzione viene sostituito dall'ideologia come immagine che la
mente si fa di come vorrebbe che fosse. Il fatto che il movente ideologico, che
tanto spesso si tramuta in esplicitamente politico, prenda il posto del principio
metafisico della natura-rivelazione così nell'arte neo-classica come nella
romantica, dimostra che esse, nonostante l'apparente divergenza, rientrano nel
medesimo ciclo di pensiero. La differenza consiste soprattutto nel tipo di
atteggiamento (prevalentemente razionale o prevalentemente passionale) che
l'artista assume nei confronti della storia e della realtà naturale e sociale.
Il periodo che va all'incirca dalla metà del '700 alla metà del'800 viene
generalmente suddiviso così: 1) una prima fase preromantica con la poetica
inglese del sublime e dell'orrore e con la parallela poetica tedesca dello Sturm
und Drang; 2) una fase neo-classica coincidente grosso modo con la rivoluzione
4
francese e con l'impero napoleonico; 3) una reazione romantica coincidente con
l'insofferenza borghese delle ottuse restaurazioni monarchiche, con i moti per le
indipendenze nazionali, le prime rivendicazioni operaie tra il 1820 c. e il 1850 c.
Questa periodizzazione non regge per vari motivi: 1) già verso la metà del
Settecento il termine "romantico" viene impiegato come equivalente di
"pittoresco" e riferito al giardinaggio, cioè ad un'arte che non imita né
rappresenta ma, conformemente alle tesi illuministiche, opera direttamente sulla
natura, modificandola, correggendola, adattandola ai sentimenti umani e alle
opportunità della vita sociale, e cioè ponendola come ambiente della vita; 2) la
poetica del "sublime" e quella dello Sturm und Drang, di poco posteriori alla
poetica del "pittoresco", non vi si oppongono ma semplicemente riflettono un
diverso atteggiamento del soggetto verso la realtà: per il "pittoresco" la natura è
un ambiente vario, accogliente, propizio che favorisce negli individui lo sviluppo
di sentimenti sociali; per il "sublime" è un ambiente misterioso ed ostile, che
sviluppa nella persona il senso della propria solitudine (ma anche della propria
individualità) e della disperata tragicità dell'esistere; 3) le poetiche del "sublime",
che vengono definite proto-romantiche, assumono come modelli le forme
classiche (caso di Blake e Füssli) e costituiscono dunque una delle componenti
portanti del Neoclassicismo; in quanto però l'arte classica è data come l'archetipo
dell'arte, gli artisti non la ripetono scolasticamente, ma aspirano alla sua
perfezione con una tensione nettamente romantica. Si può dunque affermare che
il Neoclassicismo storico non è che una fase del processo formativo della
concezione romantica: quella, cioè, per cui l'arte non nasce dalla natura ma
dall'arte stessa e non soltanto implica un pensiero dell'arte, ma è un pensare per
immagini non meno legittimo del pensiero per puri concetti.
Così intesa, è arte romantica quella che implica una presa di posizione rispetto
alla storia dell'arte. Fino a tutto il Seicento c'era stata una tradizione "classica"
assai vivace, che non perdeva, anzi aumentava la sua forza quanto più
un'immaginazione accesa (come quella del Bernini) la riplasmava in forme
originali. Con l'anti-storicismo proprio dell'Illuminismo quella tradizione si blocca,
l'arte greca e romana si identificano con il concetto stesso dell'arte, possono
essere contemplate come supremi esempi di civiltà, ma non continuano nel
5
presente e non aiutano a risolverne i problemi. Quella felicità creativa perduta
può essere evocata ed emulata (Canova, Thorvaldsen) o rivissuta come in sogno
(Blake), rianimata con la immaginazione (Ingres). Può essere anche
violentemente ricusata (Courbet). Solo più tardi, con gli Impressionisti, però
uscirà definitivamente dall'orizzonte dell'arte.
L'ideale neo-classico non è immobile. Certo non può dirsi neo-classica tra la fine
del Settecento e l'Ottocento, la pittura di Goya; ma la sua violenza anti-classica
nasce anche dalla rabbia di vedere contrastato da una società retriva e bigotta
l'ideale razionale, e come non dipingere mostri se il sonno della ragione li genera
e ne riempie il mondo? Con la cultura francese della Rivoluzione il modello
classico acquista un senso etico-ideologico, identificandosi con la soluzione
ideale del conflitto tra libertà e dovere; e, ponendosi come valore assoluto e
universale, trascende ed annienta le tradizioni e le "scuole" nazionali. Questo
universalismo sopra-storico culmina e si diffonde in tutta l'Europa con l'impero
napoleonico.
La crisi che si determina con la sua fine apre, anche nella cultura artistica, una
problematica nuova: ricusata l'antistorica restaurazione monarchica, le nazioni
debbono trovare in sé, nella propria storia e nel sentimento dei popoli, le ragioni
di una propria autonomia ed in una radice ideale comune, il cristianesimo,
l'argomento di una civile coesistenza. Nasce così, nell'ambito globale del
romanticismo, che comprendeva la scaduta ideologia neo-classica, il
romanticismo storico, che le si contrappone come alternativa dialettica
opponendo alla sconfitta razionalità la profonda, irrinunciabile, intrinseca
religiosità dell'arte.
Tra i motivi di quella che potremmo chiamare la fine del ciclo classico e l'inizio
del ciclo romantico o moderno (anzi contemporaneo perché giunge fino a noi) è
preminente la trasformazione delle tecnologie e dell'organizzazione della
produzione economica, con tutte le conseguenze che comporta nell'ordine
sociale e politico. Era inevitabile che la nascita della tecnologia industriale,
mettendo in crisi l'artigianato e le sue tecniche raffinate e individuali, provocasse
per conseguenza la trasformazione delle strutture e della finalità dell'arte, che
della produzione artigianale aveva costituito il culmine e il modello. Il trapasso
6
dalla tecnologia dell'artigianato, che utilizzava le materie e ripeteva i processi
della natura, alla tecnologia industriale, che si fonda sulla scienza ed agisce sulla
natura trasformando (e spesso degradando) l'ambiente, è una delle cause
principali della crisi dell'arte. Esclusi dal sistema tecnico-economico della
produzione, di cui pure erano stati i protagonisti, gli artisti diventano intellettuali in
stato di perenne tensione con la stessa classe dirigente di cui fanno parte come
dissidenti. L'artista bohémien è un borghese che ripudia la borghesia, di cui
disprezza il conformismo, l'affarismo, la mediocrità culturale. I rapidi sviluppi del
sistema industriale, sia sul piano tecnologico sia sul piano economico-sociale,
spiegano il continuo e quasi affannoso mutare degli orientamenti artistici che non
vogliono rimanere indietro, delle poetiche o tendenze che si contendono il
successo, e sono pervase da un'ansia di riformismo e modernismo.
Pittoresco e sublime
Dire che una cosa è bella è un giudizio; la cosa non è bella in sé, ma nel giudizio
che la definisce tale. Il bello non è più oggettivo, ma soggettivo: il "bello
romantico" è appunto il bello soggettivo, caratteristico, mutevole, contrapposto al
"bello classico" oggettivo, universale, immutabile. Il pensiero dell'Illuminismo non
pone la natura come una forma o figura creata una volta per sempre e sempre
uguale a se stessa, che si può soltanto rappresentare o imitare. La natura che gli
uomini percepiscono con i sensi, apprendono con l'intelletto, mutano con l'agire
(è dal pensiero illuministico che nasce la tecnologia moderna, che non ubbidisce
alla natura ma la trasforma) è una realtà interiorizzata che ha nella mente tutti i
suoi possibili sviluppi, anche nell'ordine morale. Distinguendo un "bello
pittoresco" ed un "bello sublime" (termini che avevano già un significato nei
discorsi sull'arte), Kant distingue in realtà due giudizi che dipendono da due
diversi atteggiamenti dell'uomo nei confronti della realtà: su di essi e sulla loro
relazione fonda infatti la sua "critica del giudizio".
Il "pittoresco" è una qualità che si ripercuote sulla natura dal "gusto" dei pittori, e
specialmente dei pittori del periodo barocco. A teorizzarlo è stato un pittore e
trattatista, ALEXANDER COZENS, (1717 c.-1786) preoccupato di dare alla
pittura inglese del Settecento, prevalentemente ritrattistica, una scuola di
7
paesaggisti. I capisaldi sono: 1) la natura è una sorgente di stimoli a cui
corrispondono sensazioni che l'artista chiarisce e comunica; 2) le sensazioni
visive si danno come macchie più chiare, più scure, variamente colorate e non in
uno schema geometrico come quello della prospettiva classica; 3) il dato
sensorio è naturalmente comune a tutti, ma l'artista lo elabora con la propria
tecnica mentale e manuale e dirige così l'esperienza che la gente fa del mondo,
insegnando a coordinare le sensazioni e le emozioni, e adempiendo anche con
la pittura di paesaggio alla funzione educativa che l'Illuminismo settecentesco
assegnava agli artisti; 4) l'insegnamento non consiste nel decifrare dalle macchie
imprecise la nozione dell'oggetto a cui corrispondono, ciò che distruggerebbe la
sensazione primaria ma nel chiarire il significato e il valore della sensazione, così
com'è, ai fini di un'esperienza non nozionale o particolaristica del reale; 5) il
valore che gli artisti cercano è la varietà: la varietà delle sembianze dà un senso
alla natura come la varietà dei casi umani alla vita; 6) non si cerca più
l'universale del bello, ma il particolare del caratteristico; 7) il caratteristico non si
coglie con la contemplazione, ma con l'arguzia (wit) o la prontezza di mente che
permette di associare o "combinare" idee-immagini anche molto diverse e
lontane. Naturalmente le macchie variano secondo il punto di vista, la luce, la
distanza. Ciò che la "mente attiva" afferra è dunque un contesto di macchie
diverse ma in relazione tra loro: la varietà non impedisce che le molteplici
componenti della veduta concorrano a comunicare un sentimento di gioia o di
calma o di mestizia.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
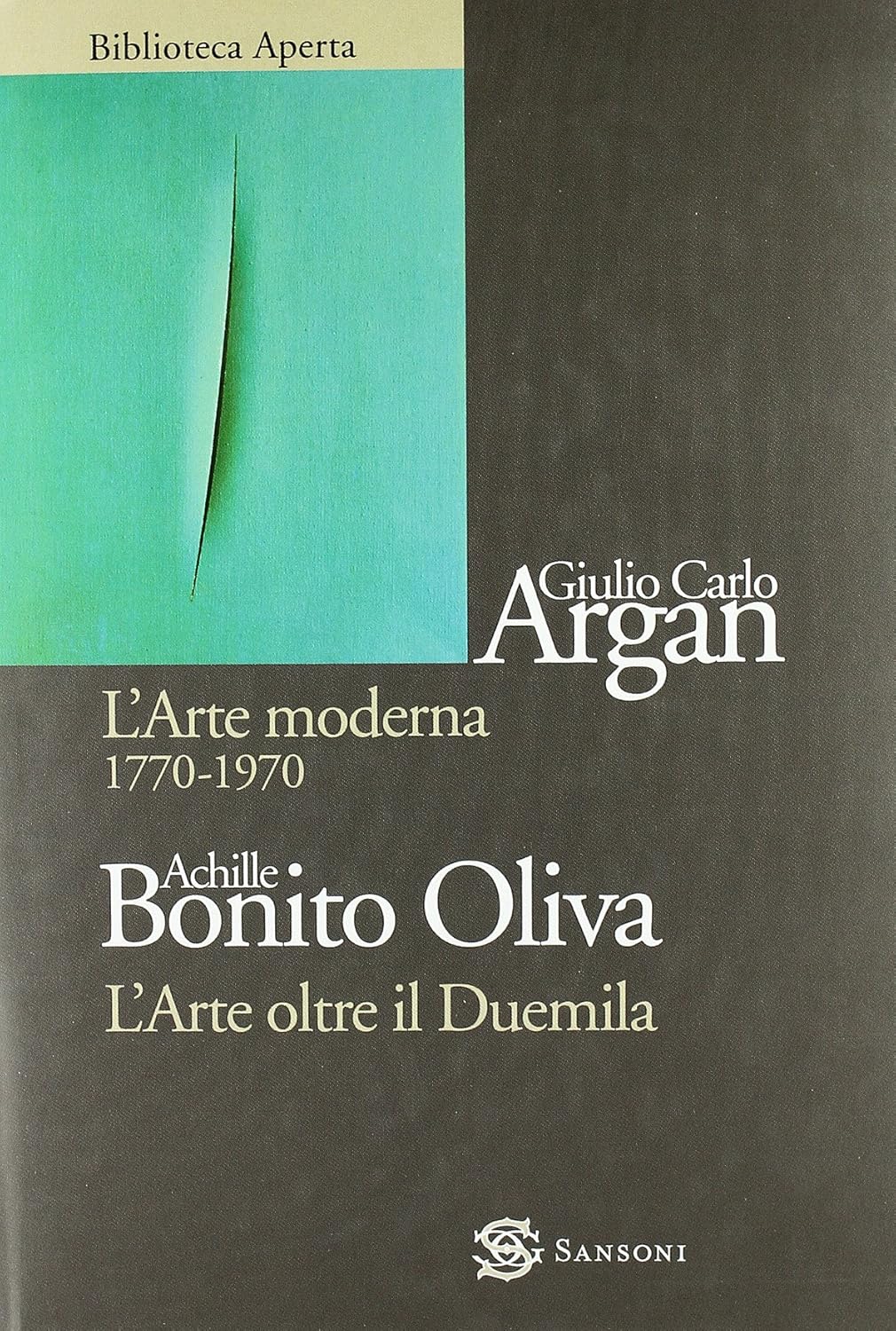






Commento all'articolo