L’altra verità Diario di una diversa – Alda Merini

SINTESI DEL LIBRO:
Quando venni ricoverata per la prima volta in manicomio ero poco piů di una
bambina, avevo sě due figlie e qualche esperienza alle spalle, ma il mio
animo era rimasto semplice, pulito, sempre in attesa che qualche cosa di bello
si configurasse al mio orizzonte; del resto ero poeta e trascorrevo il mio
tempo tra le cure delle mie figliole e il dare ripetizione a qualche alunno, e
molti ne avevo che venivano a scuola e rallegravano la mia casa con la loro
presenza e le loro grida gioiose. Insomma ero una sposa e una madre felice,
anche se talvolta davo segni di stanchezza e mi si intorpidiva la mente. Provai
a parlare di queste cose a mio marito, ma lui non fece cenno di comprenderle
e cosě il mio esaurimento si aggravň, e morendo mia madre, alla quale io
tenevo sommamente, le cose andarono di male in peggio tanto che un giorno,
esasperata dall’immenso lavoro e dalla continua povertŕ e poi, chissŕ, in preda
ai fumi del male, diedi in escandescenze e mio marito non trovň di meglio
che chiamare un’ambulanza, non prevedendo certo che mi avrebbero portata
in manicomio. Ma allora le leggi erano precise e stava di fatto che ancora nel
1965 la donna era soggetta all’uomo e che l’uomo poteva prendere delle
decisioni per ciň che riguardava il suo avvenire.
Fui quindi internata a mia insaputa, e io nemmeno sapevo dell’esistenza degli
ospedali psichiatrici perché non li avevo mai veduti, ma quando mi ci trovai
nel mezzo credo che impazzii sul momento stesso in quanto mi resi conto di
essere entrata in un labirinto dal quale avrei fatto molta fatica ad uscire.
Improvvisamente, come nelle favole, tutti i parenti scomparvero.
La sera vennero abbassate le sbarre di protezione e si produsse un caos
infernale. Dai miei visceri partě un urlo lancinante, una invocazione
spasmodica diretta ai miei figli e mi misi a urlare e a calciare con tutta la
forza che avevo dentro, con il risultato che fui legata e martellata di iniezioni
calmanti. Ma, non era forse la mia una ribellione umana? non chiedevo io di
entrare nel mondo che mi apparteneva? perché quella ribellione fu scambiata
per un atto di insubordinazione?
Un po’ per l’effetto delle medicine e un po’ per il grave shock che avevo
subito, rimasi in istato di coma per tre giorni e avvertivo solo qualche voce,
ma la paura era scomparsa e mi sentivo rassegnata alla morte.
Dopo qualche giorno mio marito venne a prendermi, ma io non volli seguirlo.
Avevo imparato a riconoscere in lui un nemico e poi ero cosě debole e
confusa che a casa non avrei potuto far nulla. E quella dissero che era stata
una mia seconda scelta, scelta che pagai con dieci anni di coercitiva
punizione.
Il manicomio era saturo di fortissimi odori. Molta gente orinava e defecava
per terra. Dappertutto era il finimondo. Gente che si strappava i capelli, gente
che si lacerava le vesti o cantava sconce canzoni. Noi sole, io e la 2.,
sedevamo su di una pancaccia bassa, con le mani in grembo, gli occhi fissi e
rassegnati e in cuore una folle paura di diventare come quelle lŕ.
La Z. era una bonacciona. L’avevano messa lě dentro perché era stata ragazza
madre e volevano disfarsene, ma non aveva nulla di folle, era quieta, e a volte
persino serena. Solo quando pensava al suo piccolo si metteva a piangere e
piangeva in silenzio certa che nessuno l’avrebbe compresa. Ma io la
comprendevo bene. Sapevo che l’essere madre in un posto come quello
diventa una cosa atroce. Perciň cercavo di distrarla.
Un giorno in giardino incontrai un prete. Ero sola e gli chiesi in che concetto
Dio tenesse i poveri pazzi.
“Mah” rispose quello, “che volete, figliola. I pazzi non sono responsabili.”
“Mah”, proseguii io, “se Dio ha dato il libero arbitrio perché scegliessimo il
bene ed il male, perché ce l’ha tolto con la pazzia?”
Il prete rimase confuso e se ne andň borbottando, ma a me quel concetto mi
rodeva dentro: perché un folle non puň piů essere padrone della sua volontŕ?
Mi chetavo solo quando pensavo a quanto fossi ignorante su questa materia.
Recentemente ho trovato in una libreria il libro dell’Adalgisa Conti, fatta
ricoverare in circostanze analoghe alle mie, dove sta scritto un passo che qui
voglio riportare e che mi pare molto indicativo ai fini dei delitti perpetrati nei
manicomi.
Vi si legge:
D’altronde l’internamento rappresenta giŕ di per sé una violenza enorme per
la donna che, identificandosi come persona nel ruolo coperto in famiglia,
sottratta a questo perde ogni punto di riferimento e ogni possibilitŕ di essere e
di riconoscersi come individuo. Il ruolo di Casalinga-moglie-madre č il solo
ruolo possibile per la donna ipotizzato come naturale, come l’essenza stessa
del vivere femminile.
E necessario quindi perché la donna possa ricoprire questo ruolo il rapporto
con quell’uomo che scegliendola le ha consentito di realizzarsi.
Se non si rivela capace di rispondere alle sue aspettative, la vittima non č lei,
che č anzi colpevole di inadeguatezza, ma il marito che ha socialmente
riconosciuto il diritto di rifiutarla o di sostituirla. Esso condanna la donna alla
perdita di ogni suo spazio privato e ad una vita collettiva, a violazioni
continue di quella riservatezza e di quel pudore cui come “matta” non ha piů
alcun diritto e che pur tuttavia le vengono continuamente indicati come
elementi indispensabili della sua normalitŕ.
La vita del manicomio faciliterŕ la degradazione del suo corpo, divenuto
strumento di una esistenza puramente vegetativa e oggetto offerto alla
manipolazione e allo sfruttamento che la istituzione ne farŕ, impegnandolo in
attivitŕ servili e degradanti.
Questo passo del libro dell’Adalgisa mi pare molto eloquente tanto piů che io
stessa una volta che venni sorpresa a masturbarmi fui severamente punita, in
quanto le degenti non dovevano e non potevano avere istanze sessuali.
Cosě, per cinque lunghi anni mi adattai a quel ménage veramente pazzesco.
Ci svegliavano di buon’ora alle cinque del mattino e ci allineavano su delle
pancacce in uno stanzone orrendo che preludeva alla stanza degli
elettroshock: cosě ben presente potevamo avere la punizione che ci sarebbe
toccata non appena avessimo sgarrato.
Per tutto il giorno non ci facevano fare nulla, non ci davano né sigarette né
cibo al di fuori del pranzo e della cena; e vietato era anche il parlare.
D’altra parte, trattandosi tutte di forme schizofreniche e paranoidee, ben poco
ci sarebbe stato da dire con le altre malate. Ma io inspiegabilmente rimanevo
lucida e attenta; io avevo voglia di qualche cosa di buono, di ancora
sensibilmente umano, avevo voglia di innamorarmi: ma di chi?
I padiglioni erano ben divisi. Gli uomini stavano da una parte e le donne
dall’altra, ma un giorno nel nostro padiglione entrň Pierre, un malato con un
gran mazzo di rose bianche per l’infermiera, mandate dal capo, ed io mi
innamorai subito di quell’ometto schivo e semplice che faceva il pittore, lě,
dentro il manicomio. Cominciň cosě il nostro idillio ottocentesco fatto di
sorrisi da dietro i vetri, di frasi approssimative, di piccoli, piccolissimi
incontri ma senza alcun desiderio di amplesso amoroso. Dice Freud che
l’uomo normale nel suo atto sessuale si sente continuamente “spiato” come se
si ripetesse l’incesto della sua infanzia: e noi eravamo regrediti fino al
complesso edipico per cui una stretta di mano equivaleva ad una aberrazione
mentale. Purtuttavia io Pierre l’amavo e a lungo andare l’amore generň il suo
frutto, il sano desiderio del possesso fisico.
Le notti, per noi malati, erano particolarmente dolorose. Grida, invettive,
sussulti strani, miagolii, come se si fosse in un connubio di streghe. I farmaci
che ci propinavano erano o troppo tenui o sbagliati, per cui pochissime di noi
riuscivano a dormire. D’altra parte, di giorno non facevamo nulla e, se la sera
si era tentati di rimanere alzati un po’, subito venivamo redarguiti aspramente
e mandati a letto con le “fascette”. Che cosa erano le fascette? Nient’altro che
delle corde di grossa canapa, dentro le quali ci infilavano i piedi e le mani
perché non potessimo scendere dai lettucci. Urlare sě, potevamo; nessuno ce
lo impediva, tanto che qualche volta un malato a furia di urlare finiva col
ricadere esangue sul proprio letto. Ricordo di una paziente che rimase
immersa nelle proprie feci urlando a squarciagola per giorni e giorni finché
non venne slegata e rimandata in libertŕ. La poveretta, ovviamente, non
sopportava quel genere di umiliazione.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





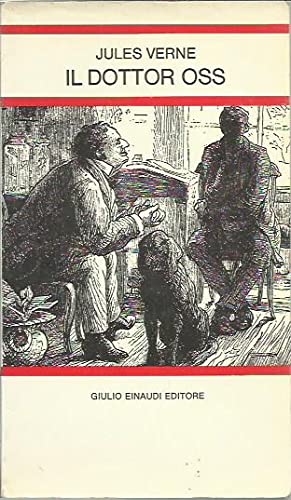
Commento all'articolo