L’antipatico Bettino Craxi e la grande coalizione – Claudio Martelli
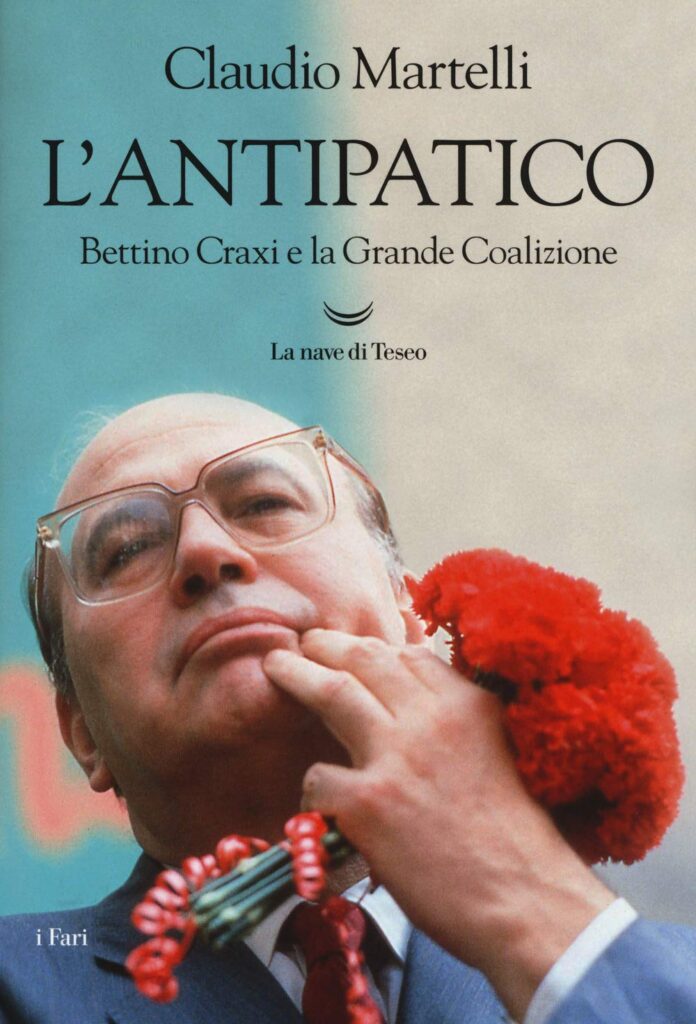
SINTESI DEL LIBRO:
Di solito, i primi maestri sono i genitori e non vedo perché Beino
dovrebbe fare eccezione. Comincio da Maria Ferrari, la madre lodigiana –
quindi milanese “ariosa” o di campagna –, piglio rude, spavaldo, da
popolana che non si fa intimorire, semmai intimidisce. Non è solo fantasia
immaginare che l’esempio di Maria – una donna che nessuno poteva
comandare perché era orgogliosa e sincera come solo il popolo sa essere,
come sa essere anche il più spietato carnefice – sia stato per il piccolo
Beino il dono più grande che la mamma potesse fargli: quello di essere,
per parte di madre, un figlio del popolo. Prima che da altre esperienze è da
lei che deve avere appreso che il modo migliore di scacciare la paura è far
paura agli altri. Il dono più prezioso ma anche quello che c’entra, più di
qualcosa, con la nomea di antipatico.
Il padre Viorio, giovane avvocato siciliano trasferitosi a Milano, al
socialismo si avvicinò prima nella clandestinità antifascista e poi nella
guerra civile. E già questo, considerati i tempi e l’aria intonata del palazzo
di giustizia, mi pare un aestato di eccellente salute civile. Di sicuro,
insieme a un affeo potente, anche lui come la madre qualcosa della
propria indole deve averlo trasmesso al figlio maggiore. Una lezione di
coraggio anzituo. Come poteva essere diversamente se vide il padre,
sfollato da Milano in Brianza, accompagnare in Svizzera alcuni ebrei
perseguitati? Come poteva essere altrimenti se il ragazzeo Craxi conobbe
in casa tipi come Sandro Pertini, Lelio Basso e Pietro Nenni, che col padre
confabulavano di loe clandestine e di rappresaglie? Di sicuro, qualcosa
gli sarà arrivato su come la politica vorrebbe esser buona e su come debba
diventare tremendamente caiva. Forse avrà prima confuso e poi distinto
amici e nemici nelle bande di adolescenti che scorrazzavano per le strade
di Lambrate. Avrà considerato la differenza tra l’essere nemici da ragazzi e
quel che significa e comporta per gli adulti.
Ascoltando papà Viorio nelle stagioni della terza età, si scopriva un
buon conoscitore della storia e della politica italiana, un ragionatore reso
sceico e disincantato dalle peripezie socialiste. Io lo sentii appassionato
del suo Beino come solo un padre siciliano sa essere, e decisamente meno
convinto delle prove di altri capi socialisti. “Son poca cosa o infidi,” diceva,
e per rendere meglio l’idea sfregando i pollici sulle falangi superiori delle
dita, rincarava la dose: “Son poca cosa o niente.”
Chi oltre al padre svezzò Beino politicamente? Da quel che mi ha deo,
da quel che ho appreso da chi l’ha conosciuto prima di me, posso
distinguere chiaramente almeno due mentori, due amici più grandi di età,
entrambi socialisti, diversi tra loro, ma con alcune affinità profonde.
Virgilio Dagnino era stato allievo di Carlo Rosselli, diventando
ragionatore, antifascista, socialista liberale. Tanto bastò perché dopo
l’aentato a Viorio Emanuele III sperimentasse il carcere precauzionale
riservato ai sospei antifascisti. Andare in prigione e trovarsi in
compagnia di detenuti come Giorgio Amendola, Ugo La Malfa, Lelio
Basso, Umberto Segre, più che un antidoto fu un trao ai dadi.
Anni dopo, in quel 1947 in cui i socialisti si trovarono di fronte alla
questione delle questioni, al dilemma ineludibile – il mondo libero o il
mondo comunista, l’America o l’URSS, Truman o Stalin –, ciascuno dei
mentori presenti e futuri di Craxi compì la propria scelta. Il padre Viorio
si schierò con Basso e con Nenni e fu candidato, non eleo, del Fronte
Popolare. Dagnino scelse invece Saragat e per lui scrisse il Manifesto del
partito socialdemocratico nato dalla scissione di Palazzo Barberini. Ma già
l’anno dopo, insieme con Leonida Repaci, il grande saggista osò criticare
Saragat per certi eccessi anticomunisti che avevano isolato il PSDI e fu
subito estromesso dalla direzione de “L’Umanità”, il giornale del partito.
Chi era edoo dell’autoritarismo di Saragat non si stupì che già nel ’48
Dagnino rientrasse nel PSI. Socialista liberale, scriore e banchiere,
economista, manager e giornalista Dagnino fu, tra gli anni Sessanta e
Seanta, lo spin doctor di Beino. Era un uomo dai vasti interessi
intelleuali che negli anni Trenta pubblicò Tecnocrazia e nei Sessanta
Obsolescenza delle ideologie, di affascinante modernità. Le idee di Dagnino
colpirono molto Craxi e spiegano il loro sodalizio umano e intelleuale.
Prima di Dagnino, e altreanto moderno, l’altro mentore del giovane
Beino fu Guido Mazzali, mantovano di Suzzara, figlio di contadini,
autodidaa che pur vivendo tante dure esperienze – garzone, operaio,
tipografo, impiegato di banca – si formò da solo una notevole cultura
economica e filosofica. Poco più che adolescente, il futuro pioniere della
pubblicità italiana cominciò a frequentare la Federazione Giovanile
Socialista di Mantova e a vent’anni ne divenne segretario, distinguendosi,
sulla scia di un giovane deputato del vicino Polesine, Giacomo Maeoi,
per l’opposizione intransigente al nazionalismo e all’ingresso dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale. Nel dopoguerra, di fronte all’imperversare
dello squadrismo fascista agrario, per proteggerlo Giacinto Menoi
Serrati, leader della maggioranza massimalista del PSI, lo chiamò a lavorare
all’“Avanti!” come aveva fao anche con Nenni. Mazzali collaborò anche
con la “Rivoluzione liberale” di Pietro Gobei, arao dall’afflato etico
della rivista come Gramsci, che una dozzina d’anni dopo, in carcere, ne
rielaborò l’anelito romantico nell’idea di una riforma morale e intelleuale
degli italiani.
In piena dominazione fascista, nel 1926, Mazzali pubblica Espiazione
socialista, il suo libro più importante. La storia che racconta ripercorre le
tappe dell’edificazione e poi della tragedia socialista, che imputa non solo
alla guerra e alla sua eredità di violenza, ma anche alla mancanza di
“tensione etica di molti dirigenti”. Guardando all’antico esempio della
riforma protestante, Mazzali vi trovava sollecitazioni e stimoli a rinnovare
le basi culturali del socialismo italiano. Forse era consapevole – o forse no
– di incamminarsi sulla stessa strada bauta dalle socialdemocrazie
nordeuropee, che alla ricerca di un fondamento del socialismo lo avevano
colto assai più che nelle pretese scientifiche di Marx nell’etica protestante,
nelle sue correnti pietistiche e sociali, nei suoi pastori più sensibili, aivi e
solidali.
Nell’impossibilità di fare politica durante il Ventennio, ispirandosi al
razionalismo dominante nel panorama culturale del tempo, Mazzali studia
i problemi del lavoro, diviene consulente di imprese, istituti, associazioni
come il GAR - Gruppo Amici Razionalizzazione di Virgilio Dagnino, di cui
è amico e collaboratore, partecipando al varo e poi alla direzione di una
rivista di assoluta avanguardia, “L’Ufficio Moderno”, antesignana di una
prospeiva autonoma, né confindustriale né sindacale, del lavoro
intelleuale nell’organizzazione aziendale. Affascinato dalla pubblicità,
Guido Mazzali collabora con un’importante agenzia di Chicago e nella
campagna mondiale per reclamizzare la birra inventa il suo slogan più
famoso – “Chi beve birra campa cent’anni” – che resterà, inossidabile,
immortale. Liberato dall’internamento cui l’ha condannato il fascismo, dal
’43 partecipa alla Resistenza stampando e diffondendo l’“Avanti!”
clandestino. Sandro Pertini lo ricorda così: “Nel tardo pomeriggio del 25
aprile, un signore, tuo trafelato e dall’aria distinta, circolava impavido
per Milano insorta, con una biciclea malandata e una borsa piena di carte
che altro non erano che materiale da pubblicare su un giornale. esto
signore era Guido Mazzali… La pubblicazione di questi fogli si deve alla
tenacia, all’abnegazione, all’intelligenza di Guido Mazzali. Il giornale lo
faceva lui e lui ne curava la stampa e la diffusione. Si pensi che nella sola
Milano siamo riusciti a stampare fino a 30.000 copie per numero.”
Nel dopoguerra diventa segretario provinciale e poi regionale del PSI e
assessore al Comune. Eleo deputato nel ’48, entra nella direzione
nazionale del Partito e ne sarà membro fino alla morte. A fianco di Pietro
Nenni combaerà la baaglia autonomista, per il dialogo con i caolici
con i quali lavorerà per un duplice parallelo superamento: del centrismo
da parte della DC, del frontismo da parte del PSI.
È Guido Mazzali che accompagna la crescita del giovanoo più
promeente della Milano socialista e lo introduce al rapporto politico e
umano con Pietro Nenni.
Tra Nenni e Craxi corrono quarantatré anni di differenza, quasi mezzo
secolo. Nenni ha alle spalle – anzi, sulle spalle – due guerre mondiali, la
tragedia socialista, diciassee anni di esilio, arresti, deportazioni. Aveva
affrontato le proprie disgrazie con grande forza d’animo, ma la perdita di
Vivà – la figlia Vioria –, partigiana nella Resistenza francese, arrestata
dalla Gestapo e deportata nel lager di Auschwitz sarà lancinante, una
ferita che non si rimarginerà mai. Nel ’48, al tempo del frontismo, Nenni si
illude di guidare l’unità con i comunisti stalinisti. “el genere di unità,”
aveva profetizzato Turati vent’anni prima, “in cui i comunisti stanno sopra
e i socialisti stanno soo.”
Dopo il ’56, ma qualche dubbio lo coltivava da prima, Craxi rilegge la
storia socialista più recente in un’altra luce. La scelta frontista di Nenni ha
fao deragliare il PSI dal socialismo europeo (in particolare dal Labour di
Clement Alee e Aneurin Bevan, che fino all’ultimo scongiurarono Nenni
di non commeere il tragico errore) e lo ha sprofondato nel campo
staliniano, fornendo a Saragat e agli scissionisti socialdemocratici molte,
troppe ragioni che dovevano essere difese. Ci vorranno anni per rimediare
a quell’errore catastrofico e alle sue conseguenze mortificanti prima che il
PSI torni a rivedere la luce e la verità della propria inconciliabile diversità
dal comunismo. Nonostante le avvisaglie di un ripensamento si
manifestino già con la riscoperta della questione caolica e il tentativo di
Rodolfo Morandi di fare del PSI un partito organizzato sul modello similleninista per non soccombere ai veri leninisti del PCI, per una revisione
ideale e strategica bisognerà aendere ancora.
E finalmente arriva il ’56, l’anno che a sinistra cambierà tuo, l’anno
del rapporto Chruščëv sui crimini di Stalin, l’anno dei carri armati a
Budapest, l’anno in cui il comunismo cesserà per sempre di essere una
speranza di futura, universale liberazione per rivelarsi come il passato di
una tragica illusione e di tue le violenze e le menzogne che l’hanno
tenuta in vita.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
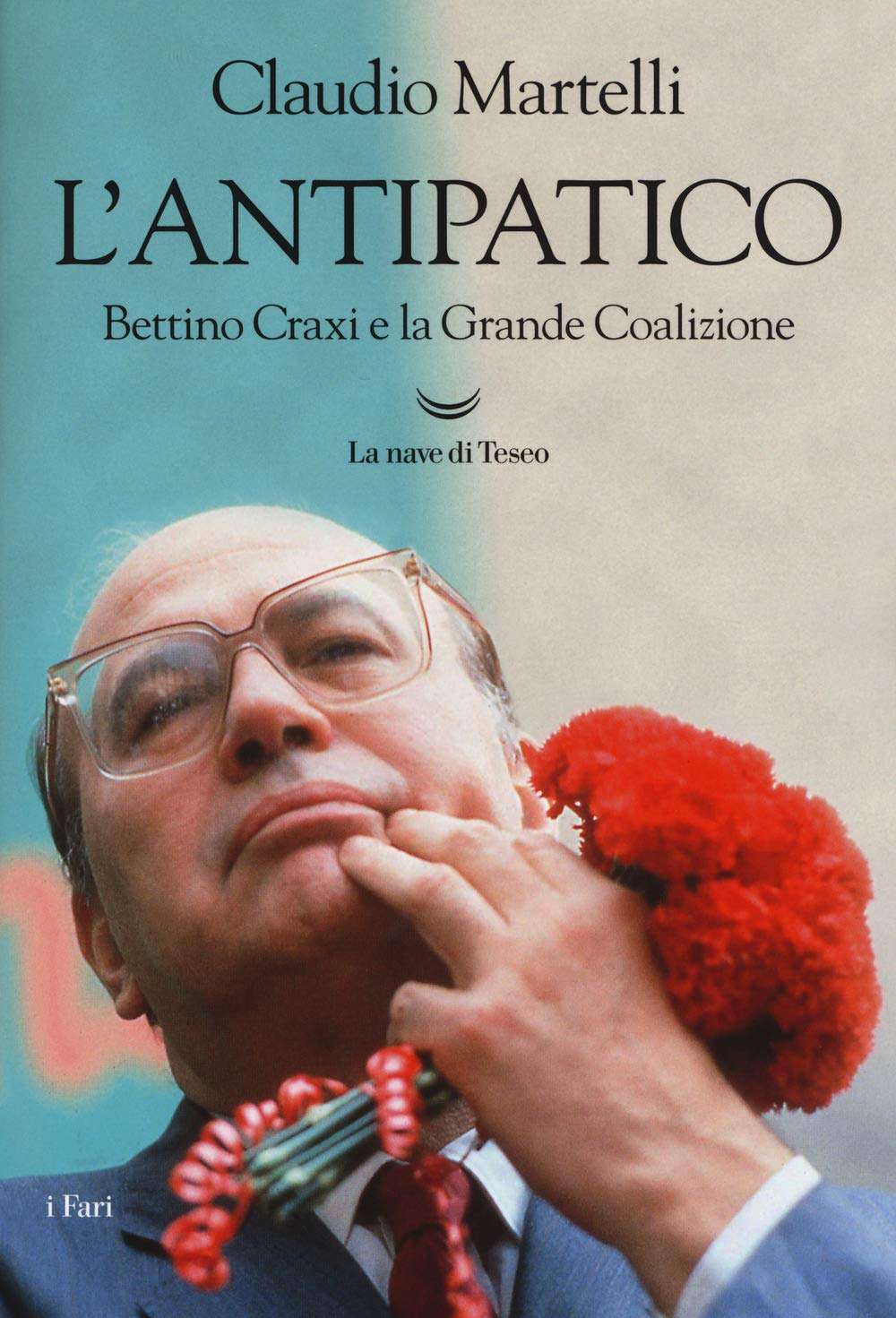






Commento all'articolo