Il mondo nella rete Quali i diritti, quali i vincoli – Stefano Rodotà

SINTESI DEL LIBRO:
Quando oggi guardiamo alla realtà della rete, ci avvediamo di un lungo
cammino percorso, che ha consentito di liberarsi da ingenuità,
semplificazioni, forzature. Guardiamo insieme. È evidente che
sull’orizzonte originario di Internet si staglia, nitido, il mito fondativo della
democrazia: l’agorà di Atene. Infatti, si è pensato che nel villaggio globale,
nell’immensa sua piazza virtuale, sarebbe stato possibile ricostruire le
condizioni della democrazia diretta. Non solo: Internet sarebbe venuta in
soccorso della morente democrazia rappresentativa e l’avrebbe traghettata sui
lidi più sicuri di una democrazia «immediata», ovvero verso un sistema
politico caratterizzato da una consultazione permanente dei cittadini.
Una «dining room» o «push-button democracy», una democrazia nella
quale l’abitazione di ciascuno sarebbe stata trasformata in cabina elettorale,
avrebbe trovato la sua forma nella possibilità di consultazioni costruite
intorno alla risposta con un sì o un no a domande poste da altri, comunque
dall’alto (con ciò contraddicendo – va detto – la logica della rete, la cui
caratteristica saliente doveva essere proprio di emanciparsi dalla struttura
gerarchica tipica delle passate forme di comunicazione).
Non erano soltanto fantasie di studiosi, frettolose proiezioni nel futuro di
quel che la rivoluzione elettronica prospettava come possibile. Verso la metà
degli anni Novanta, modellando il sistema politico secondo le suggestioni di
Alvin Toffler, il politico statunitense Newt Gingrich proponeva il passaggio a
un «Congresso virtuale» che avrebbe dovuto sostituire il Senato e la Camera
dei rappresentanti, affidando a tutti i cittadini il diritto di decidere sulle leggi
attraverso il voto elettronico. Ma contemporaneamente quelli erano pure gli
anni in cui si era consolidata una letteratura dedicata all’«assalto alla privacy»,
alla sua «morte», come segno del rischio concreto che le nuove tecnologie
facevano correre a un diritto emblematico della condizione della persona. A
una espansione dei diritti nella sfera pubblica veniva così contrapposta una
loro riduzione nella sfera privata. Orwell in Athens era il felice titolo di un
libro che voleva cogliere una tensione permanente in tutti i sistemi
democratici tra diffusione del potere e controlli sui cittadini, che la
dimensione individuata dalle innovazioni tecnologiche disvela ed enfatizza in
maniera particolarmente evidente. Si accentua così non la consapevolezza
della natura bifronte della tecnologia, ma la schizofrenia tecnologica. Vale a
dire, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione viene affidato il
compito di costruire dal basso una nuova democrazia dei cittadini; alle
tecniche della sorveglianza viene affidato il compito di costruire dal basso il
controllo capillare sui cittadini.
Proprio il passaggio dal Web 1.0 al Web 2.0, quello delle reti sociali, ha
attribuito una dimensione nuova al rapporto tra democrazia e diritti. Si sono
arricchite le possibilità di azione organizzata, non solo e non tanto dal punto
di vista quantitativo, quanto piuttosto per la qualità dei soggetti che sono
ormai in grado di articolare in modo nuovo le relazioni sociali e, insieme, di
dar vita a forme variegate di azione politica individuale e collettiva. Ciò sia
riproducendo il modello delle manifestazioni pubbliche di massa, riservato in
passato solo a grandi soggetti (partiti, sindacati, Chiesa), sia innovando
profondamente proprio la presenza delle persone sulla scena pubblica.
Usando sempre più intensamente la tecnologia, la vita esce dallo schermo e
invade, in modo nuovo, l’intero mondo, ridefinisce la sfera pubblica e quella
privata, e progressivamente disegna una redistribuzione dei poteri.
Ma questa è una vicenda cominciata prima che le reti sociali mutassero il
panorama. Si può dire che la novità divenne visibile per tutti il 30 novembre
1999, a Seattle, in occasione della grande manifestazione contro il Wto,
l’Organizzazione mondiale del commercio.
Quella manifestazione non sarebbe stata possibile senza la rete, che mise in
contatto gli attivisti e identificò le modalità dell’azione. Ma assunse significato
e forza quando uscì dalla piazza virtuale e si materializzò in quella reale, nelle
strade di Seattle, dove i manifestanti bloccavano i delegati e impedivano loro
di raggiungere il Convention Center, luogo della riunione. E quel fatto
divenne patrimonio comune quando le immagini vennero diffuse in tutti gli
angoli del mondo da un mezzo «maturo», che veniva dal passato, la
televisione generalista.
Una vicenda per molti versi analoga può essere ritrovata nelle primavere
arabe, nei fatti egiziani in particolare. Gli stessi bloggers, hanno messo in
evidenza il rischio di una sopravvalutazione del ruolo della rete, sottolineando
come la rivolta fosse cominciata con le manifestazioni di lavoratori (che certo
non avevano la disponibilità di Twitter), e che il movimento era continuato
anche dopo che Mubarak aveva bloccato le comunicazioniSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
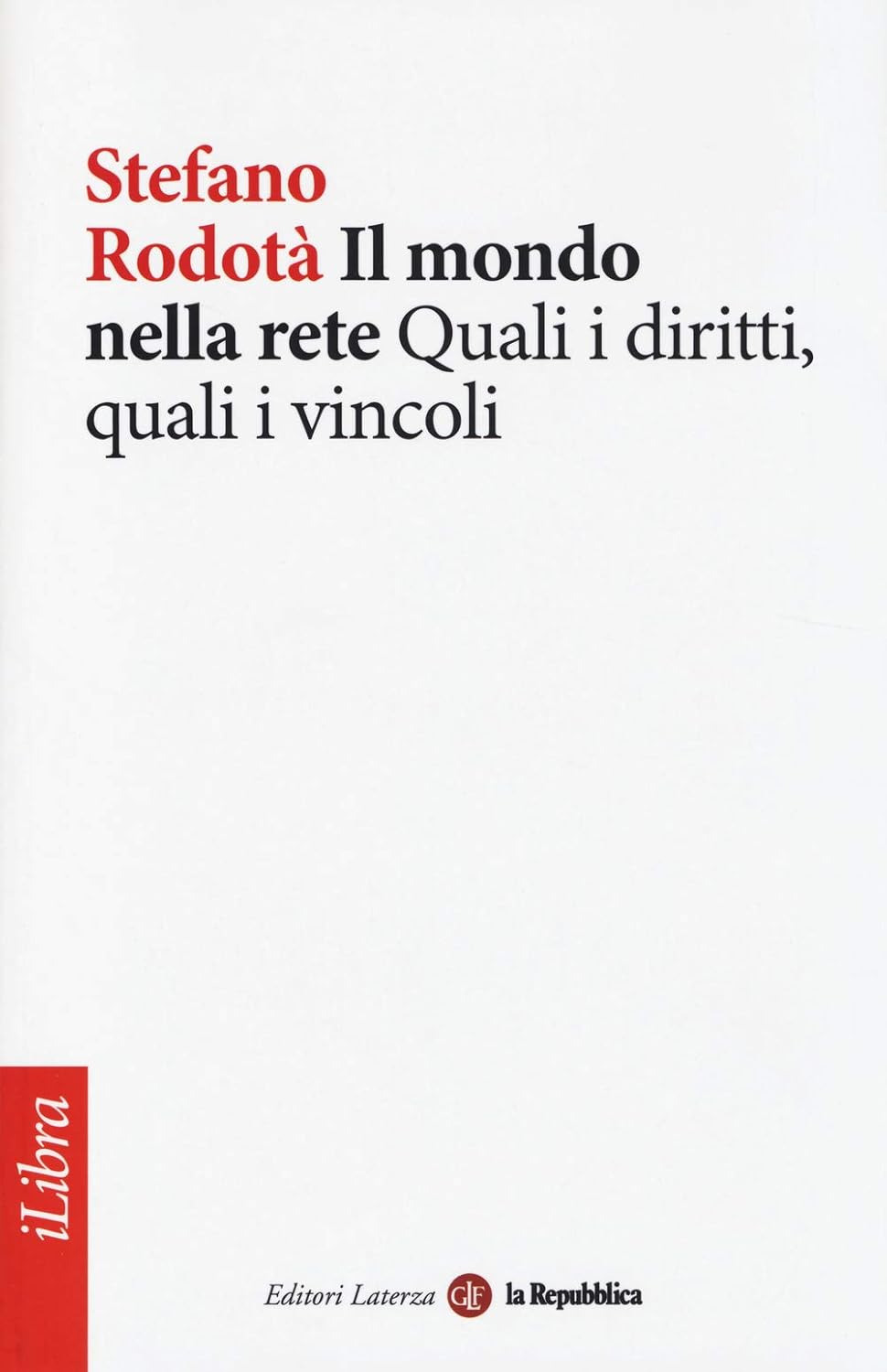






Commento all'articolo