La vendetta del serpente – Adele Vieri Castellano
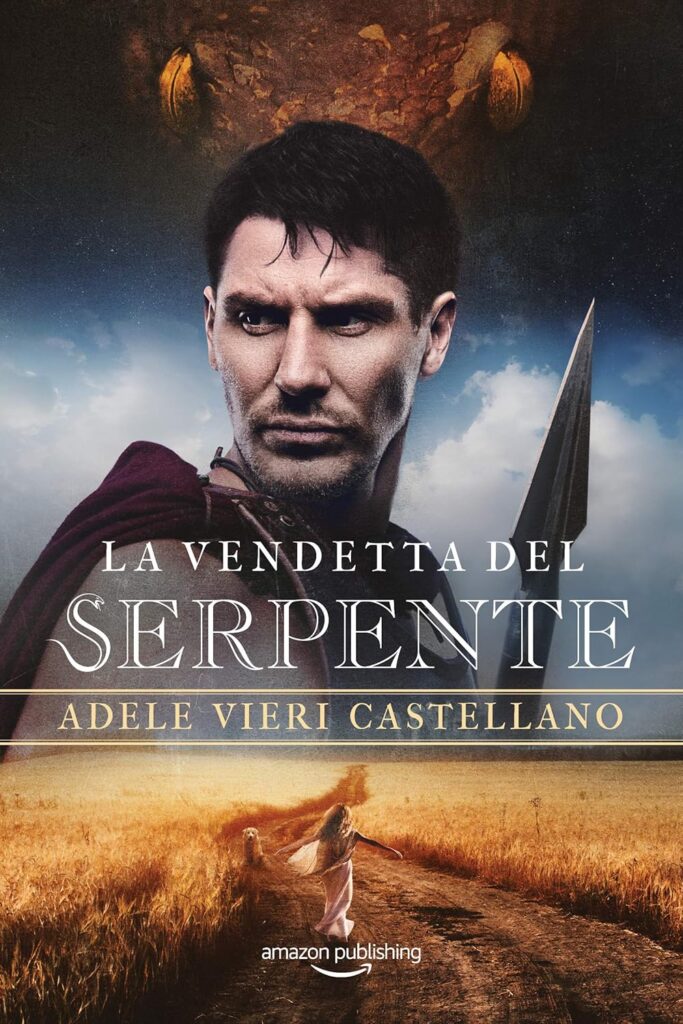
SINTESI DEL LIBRO:
Britannia, territorio dei Catuvellani, 797 a.U.c. (44 d.C.)
Era arrivata la bella stagione e, al posto della neve, era apparsa una
fredda e paludosa distesa deserta, dove spuntavano stenti fiorellini e un po’
d’erba filacciosa. Un’infinita distesa a perdita d’occhio che, come l’acqua blu
scuro che aveva attraversato con la flotta di trireme, ondeggiava al vento
quasi fosse viva.
Non c’era nient’altro. Erba e uomini.
No, non uomini: selvaggi, bestie.
Gneo Cornelio Fusco osservò i suoi legionari dall’altura e contenne con
abilità il roano che scartò all’avvicinarsi dell’altro cavallo.
«I domini dell’imperatore Claudio» pronunciò la voce di Tito Staberio,
il tribuno laticlavio più anziano della Legio XIIII Gemina.
Fusco sollevò un sopracciglio senza smettere di fissare l’orizzonte
ondulato e verde.
«Un regno che si estende da oriente a occidente, compreso quel suo
grande lago privato che chiama Mare Nostrum» commentò con tono
sprezzante. «Pochi uomini possono vantarsi di esercitare un potere terreno
altrettanto grande, eppure, nonostante la vastità dell’Impero e le sue non
poche capacità di studioso e governante, è una specie di zimbello.»
Una folata di vento portò fino a loro l’odore umido delle paludi che si
estendevano a qualche miglio dall’accampamento. Fusco proseguì, ancora
più sostenuto.
«Zoppo, balbuziente e senza alcuna vittoria da ascrivere al proprio
nome.»
Tito Staberio rimase in silenzio. Chissà se conosceva la sua storia,
pensò Fusco, ma ormai non gliene importava nulla, aveva visto troppi uomini
sventrati come maiali dai druidi per lamentarsi ancora della sua sorte.
Aveva commesso un errore, sottovalutato un uomo e il suo potere e ora
ne pagava lo scotto sulla propria pelle. Staberio era una nullità, non gli
importava se un giorno avesse riferito ciò che gli era appena uscito dalla
bocca.
Claudio, imperatore di Roma.
Sentendosi accapponare la pelle, Fusco batté le palpebre e strinse le
redini. Fremeva di collera repressa e in quel momento non avrebbe potuto
sfogarla. Si concentrò dunque sulle colline d’erba e sulle paludi e vi riversò la
propria frustrazione traboccante odio; pompò veleno nelle vene, fino a
quando una traccia di derisione e vittoria vi fecero capolino distendendogli i
tratti del viso e le sopracciglia aggrottate.
Impassibile, in silenzio, colse l’interiore soddisfazione nell’immaginare
la morte dei propri nemici e sentì che le dita si rilassavano, che la mascella
smetteva di tormentare i denti e l’odio perfetto, intenso, meditato, si spandeva
in lui come balsamo su una ferita.
L’anno prima lo zoppo aveva fatto approdare sull’isola quattro legioni
guidate da Aulo Plauzio.
Lui era stato al comando della XIIII Gemina in Germania Superiore ma,
durante il distaccamento in Britannia e per questioni di servizio, il comando
era stato affidato a Tito Flavio Sabino.
Cacat! Questioni di servizio un corno.
Sabino altri non era che il fratello maggiore di quell’arrivista della gens
Flavia, un giovane lecca palle ignorante tanto quanto superbo, di nome Tito
Flavio Vespasiano.
Questioni di servizio, puah!
Vespasiano era il pupillo del segretario di Claudio, Narciso, uno dei
liberti di cui l’imperatore amava circondarsi e che, in pratica, avevano in
mano le sorti dell’Impero mentre lo zoppo si trastullava con i suoi volumi e la
sua cultura.
Non si sarebbe stupito di scoprire che Vespasiano offriva a Narciso ben
più della sua amicizia, però le spie che aveva sguinzagliato a Roma non
avevano ancora confermato i suoi sospetti.
Non aveva importanza, almeno per il momento.
Ovviamente Vespasiano aveva preteso per il fratello un comando degno
del suo grado, ed ecco che era entrato in gioco lui, Gneo Cornelio Fusco.
L’oltraggiato.
Per questo se ne stava lì a cavallo, a rimirare l’accampamento in attesa
di una scaramuccia, dell’assalto all’ennesimo villaggio popolato da primitivi
bifolchi pieni di pulci, piccoli straccioni urlanti e femmine più disgustose e
luride delle lupe della Suburra.
Ben presto le tribù bellicose che avevano osato sfidare Roma erano state
sconfitte e Vespasiano adesso marciava tronfio sul fango isolano reclamando
gloria per sé e il fratello.
Fusco si guardò intorno.
Tito Staberio era ancora lì, quindi non si permise di sputare a terra tutto
il suo disgusto, anche se ormai era diventato il suo sfogo principale in attesa
di tempi migliori.
Aveva sputato con molta energia e livore anche assistendo allo sbarco in
pompa magna del Divino Cesare in groppa all’elefante da guerra, le zanne
ricoperte di lame scintillanti, drappi rossi e oro a nascondere la pelle grigia e
rugosa.
Là, in alto, a dominare tutti, il braccio alzato, la toga candida,
l’ovazione dei legionari e la lunga fila dei prigionieri incatenati, tenuti lontani
affinché non ne sentisse il puzzo tremendo.
La visita in Britannia dello zoppo era durata poco più di una quindicina
di giorni, poi era tornato a Roma e il Senato gli aveva decretato il trionfo per
l’eroica impresa.
Che potesse sfracellarsi ai piedi della rupe Tarpea, non si era nemmeno
degnato di concedergli udienza, nonostante le sue ripetute richieste.
Mentula!
Un meschino emulo di Annibale Barca, ecco chi era il padrone di
Roma, l’uomo che aveva osato punirlo per una sciocchezza quando invece
meritava di essere premiato.
Ora il suo compito era trucidare selvaggi trincerati nelle loro fortezze
rotonde simili a dune d’erba, cintate da pietre o tronchi, grotteschi quando li
sfidavano agitando le spade lunghe, ingombranti. Nel lasso di tempo in cui
una di queste veniva sollevata i suoi legionari avrebbero potuto squarciare
con il gladio un ventre o tagliare a fettine un fegato.
L’unica soddisfazione era la vista dei loro corpi sanguinanti dopo la
battaglia perché, per la prima volta, incontravano la perfetta e impersonale
efficienza della macchina da guerra romana e non avevano scampo.
Alzò gli occhi. Il tempo si sarebbe guastato.
Il vento soffiò su di loro l’alito caldo e umido che ormai Fusco aveva
imparato a temere: dapprima splendeva il sole, che faceva scintillare e fumare
le alture erbose, subito dopo calava una coltre grigia di nuvoloni neri che si
addensava sopra le loro teste rendendo l’aria così bagnata da far arrugginire
persino i chiodi delle caligae.
«Che cosa c’è, Staberio? Le mie parole sul Divino Cesare ti hanno fatto
seccare la lingua?» disse per spezzare quel fiume di rancore che gli scorreva
nel corpo.
Il tribuno lo fissò con il viso duro e serio. Fusco ne studiò il mento largo
e squadrato, il naso prominente, gli occhi scuri e intelligenti che in quel
momento parevano privi d’espressione.
«No, Cornelio. Nulla di ciò che hai detto potrebbe mai stupirmi.»
Non si aspettava una risposta diversa, così incitò il cavallo con una
stretta delle gambe.
«Bene, allora andiamo ad ammazzare un po’ di miserabili.»
Quando Fusco tornò ai suoi quartieri, una tenda quadrata di spesse pelli
conciate, era sudicio come un macellaio. Sorpresa una spia che si aggirava
intorno al castra, aveva eseguito la condanna seduta stante e il sangue della
gola tagliata gli era schizzato su avambracci e lorica.
Piccole, insignificanti soddisfazioni.
Servio gli si precipitò incontro, un drappo di lino tra le mani.
«Porta via quella roba» ringhiò lui con un cenno brusco. «Ho bisogno
d’acqua per lavarmi, dov’è il bacile?»
L’intendente gli fece strada trotterellando sulle gambe d’airone fino
all’interno della tenda illuminato da un braciere.
Fusco rimase fermo mentre il giovane slacciava le cinghie che
assicuravano al torace la corazza di cuoio. Si sentì nudo con la sola tunica di
lana che lo proteggeva dagli sbalzi di temperatura.
Servio si diede da fare anche con i bracciali d’argento che gli
proteggevano i polsi durante i combattimenti. Non che si fosse mai trovato ad
affrontare faccia a faccia quei selvaggi, ma era così avvezzo a indossarli che
ormai li usava come una sorta di ornamento.
A braccia nude avanzò fino al bacile colmo d’acqua calda e vi immerse
le mani. Il sangue, già secco, cominciò a dissolversi in sinuosi filetti.
Con una manciata di polvere di cenere e soda Servio gli strofinò gomiti,
avambracci e dita, una per una. Il movimento lo aiutò a rilassarsi, chiuse per
un attimo gli occhi.
Quando li riaprì abbassò lo sguardo sul suo volto riflesso, forma
indistinta sulla tremula superficie dell’acqua: il baluginare della pelle pallida,
la macchia scura dei capelli sulla nuca, gli occhi a malapena distinguibili ma,
ben visibile, la cicatrice che gli sfregiava la guancia sinistra.
La causa di tutto.
Gli risuonarono ancora nitide nelle orecchie le grida di giubilo dei
legionari nel castra di Mogontiacum, tre anni prima. Sembravano impazziti,
incitavano e urlavano lodi e imprecazioni all’indirizzo del loro ufficiale,
Marco Quinto Rufo. Ovunque si alzavano voci, commenti, qualcuno aveva
osato persino scommettere sui due uomini che si rotolavano nella polvere
incuranti, in una sfida tra civiltà e barbarie. Quel comportamento indegno
aveva disonorato Rufo e la sua carica di ufficiale, abbassandolo allo stesso
livello del barbaro Raganhar di Gerlach, feccia germana, principe chatto
tenuto in ostaggio prima di essere portato a Roma.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






Commento all'articolo