La vana fuga degli dei – James Hillman
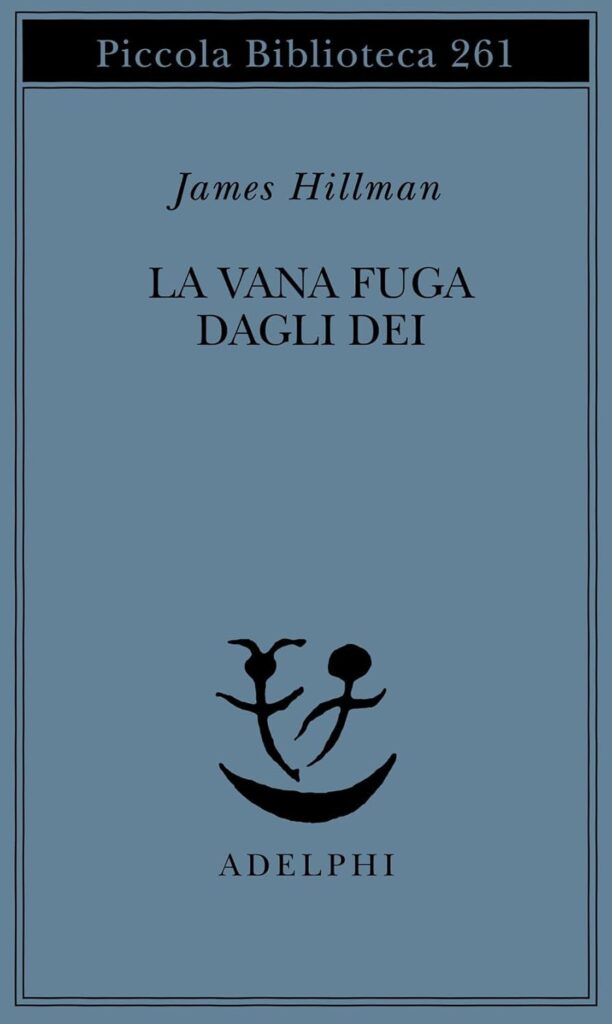
SINTESI DEL LIBRO:
Comincerò citando due autoritŕ in materia di religione, in modo da
collocare il mio tema, la paranoia, entro il piů ampio contesto di
questa “Tagung” dedicata al Nascosto, e da chiarire fin dall’inizio che
la mia conferenza andrŕ a situarsi nel punto in cui psicologia e
religione, la religione intesa come rapporto con la divinitŕ e come
rapporto con la collettivitŕ, sfumano l’una nell’altra, nel punto,
dunque, dove la psicologia č indotta a prendere in considerazione la
teologia e la politica.
La prima citazione č di uno psicologo, William James:
“Se si dovesse caratterizzare la vita religiosa nel senso piů ampio e
generale, si potrebbe dire che essa consiste nel credere che esiste
un ordine invisibile e che il nostro bene supremo č l’adattamento
armonico ad esso. In questa convinzione e in questo adattamento
consiste l’atteggiamento religioso dell’anima” (1).
La seconda citazione č tratta dalla voce “Rivelazione” dell’autorevole
dizionario di teologia di Kittel:
“Tutte le religioni riguardano in un modo o nell’altro il manifestarsi
della divinitŕ. E questo consiste nella rimozione di ciň che la
nasconde. Non puň darsi accesso diretto alla divinitŕ … la divinitŕ č
nascosta. Lo sa anche l’uomo primitivo. D’altro canto, con un Dio
che restasse permanentemente nascosto non potrebbe esservi
alcun rapporto, né tanto meno dimestichezza. Nel senso piů ampio,
dunque, tutte le religioni dipendono dalla rivelazione … fa parte della
natura della divinitŕ rendersi manifesta. Ciň che conta č la proprietŕ
del metodo…” (2).
“Ciň che conta č la proprietŕ del metodo”. L’essenziale non č la
rivelazione come tale, bensě una rivelazione metodologicamente
corretta ovvero, con le parole di William James, “l’adattamento
armonico” all’ordine invisibile.
Le varie definizioni di rivelazione corretta fanno parte della teologia,
mentre i casi di rivelazione sbagliata, falsa o delirante rientrano nella
psicologia anormale e in particolare in una categoria di questa, la
paranoia (termine che userň qui a comprendere gli stati paranoidi,
paranoici, paranoidei, eccetera). Piů specificamente, č nella
paranoia, in questo stile di comportamento e in questo tipo di
personalitŕ, che noi troviamo sinceri tentativi di adattamento
all’ordine invisibile, vite vissute nell’intento di armonizzarsi con la
veritŕ rivelata, alle quali, in conformitŕ con le nostre due autorevoli
dichiarazioni iniziali, va accordata la definizione di vite vissute
religiosamente. Eppure la paranoia č una forma di pazzia molto
profonda, centrale, sovente tragica e cronica. Anche se inizialmente
concentreremo l’attenzione sul metodo di rivelazione improprio, o
paranoide, il nostro intento mira piů lontano; l’ipotesi da cui partiamo,
infatti, č che, indagando sul metodo sbagliato, il delirio, si possa
scoprire qualcosa di nuovo sul metodo giusto, la rivelazione. Noi
speriamo, anzi, di scoprire qualcosa che ci permetta di capire,
inoltre, come mai questo linguaggio di giusto-sbagliato sembri
essere cosě cruciale in entrambi i contesti, della paranoia e della
rivelazione.
- La psichiatria e la paranoia.
Paranoia: squilibrio mentale, follia, “délire”, pazzia. “Para” + “Noia”:
pensiero a lato, attivitŕ mentale alienata, difettosa, “déroutée”,
“entgleist”, de-viata. Secondo Eschilo (“I sette a Tebe”, v. 756), fu la
paranoia a far accoppiare Giocasta ed Edipo. Secondo Euripide
(“Oreste”, v. 822), l’assassinio di Clitennestra fu paranoia. Nel
“Teeteto” di Platone (195 a), il dialogo che riguarda il retto pensare,
si usa il termine paranoia in riferimento a chi in ogni occasione vede,
sente e pensa in modo erroneo, sbaglia a classificare le cose. Per
Plotino (6°, 8°, 13), l’aggettivo “paranoeteon” indica l’allontanarsi o il
distrarsi dal ragionamento rigoroso.
Pur essendo usato nel Corpus ippocratico (dove compare insieme a
molti altri analoghi: “parakrouein”, “paraphron”, “paraphrosyne”,
eccetera), il termine paranoia si ripropone nel suo significato
corrente via via che la psichiatria si viene costituendo in sistema
nella sua forma moderna, soprattutto attraverso Vogel, Heinroth,
Sander, Westphal, Kahlbaum e infine Kraepelin; si accende
contemporaneamente la disputa intorno alla struttura della paranoia,
alle sue origini, decorso e prognosi, al suo trattamento e, soprattutto
con Jaspers, intorno alla sua natura fondamentale. Perché, se si
potesse arrivare con certezza alla definizione fondamentale della
paranoia, allora davvero saremmo in grado di definire la vera follia e
di prestare soccorso alla mente malata. Nel frattempo essa continua
ad attirare nella sua rete menti di grande levatura: come Jacques
Lacan, che sulla paranoia scrisse la sua tesi di laurea; come Elias
Canetti, concluse la sua imponente opera “Massa e potere” con una
parte intitolata a “Sovranitŕ e paranoia”.
Nella grande parata dei quadri clinici, quelle inquietanti immagini che
rappresentano la storia della psicologia clinica, la paranoia spicca
come l’unica delle sindromi piů gravi che non sia stata ridotta alla
fisiologia (3). Laddove la psicosi maniaco-depressiva, le schizofrenie
e persino le personalitŕ psicopatiche si immagina che abbiano una
base organica nella biogenetica o nella biochimica, la paranoia,
indipendentemente dalla scuola che la definisce, rimane puramente
mentale, una sindrome noetica, un disturbo del “nous” (4). Poiché
afferma l’autentica possibilitŕ della Mente di diventare pazza, poiché
afferma l’esistenza di una “Geisteskrankheit”, la paranoia afferma
l’autonomia e l’incontrovertibile pervicacia del “Geist”, ed č perciň un
argomento quanto mai idoneo agli incontri di Eranos.
Gli interrogativi psichiatrici (come nasce, quali sono la sua struttura
fondamentale, il suo decorso tipico e la sua possibile cura) collocano
un’indagine sulla paranoia non solo all’interno della fantasia, propria
della medicina, di una entitŕ-malattia, ma anche tra i topoi del
realismo filosofico (nel senso medioevale), al quale anche noi ci
atterremo in questa conferenza, pur nell’esame di casi individuali.
Partiremo cioč dall’assunto che il termine paranoia abbia un
referente, sia dotato di realtŕ sostanziale, che si possano analizzare
gli stati della mente a prescindere dalle menti individuali, che
l’universale abbracci e informi il particolare.
Sia che la definiamo, con i francesi, “monomanie”, “folie raisonnante”
o “délire cronique”, o, con la psichiatria di lingua tedesca, “primäre
Verrücktheit”, la caratteristica determinante della paranoia č la
presenza di idee deliranti (“Wahnideen”). “Il delirio” scrive Niel
Micklem “č l’essenza psichica delle psicosi. La paranoia esibisce lo
stato delirante nel modo piů diretto e scoperto …” (5). Dunque la
paranoia č davvero il disturbo mentale paradigmatico. I deliri
possono essere deliri di persecuzione (l’idea di essere spiato,
seguito, deriso); di gelosia (mia moglie fa segnali ad altri uomini
dietro le mie spalle); di riferimento: deliri ipocondriaci, erotici,
querulanti (l’idea che le cose piů svariate che mi succedono sono
determinate da altri); e, quarto, deliri di grandezza o megalomania
(l’idea di essere l’eletto, di avere nobili natali, di essere destinato a
sopravvivere a una catastrofe incombente). A prescindere dalla
bizzarria del delirio, dalla sua durata e pertinacia, non dobbiamo
dimenticare una caratteristica su cui tutti i manuali insistono, il fatto
che “di norma il comportamento, le emozioni e l’intelletto dei pazienti
affetti da questo disturbo rimangono integri, talché, se le loro
premesse fossero fondate, il loro atteggiamento generale e la loro
conversazione passerebbero per normali o quasi” (6).
“L’atteggiamento generale, la conversazione e … le reazioni
rimangono inalterati …” (7). “Il deterioramento del funzionamento
quotidiano č cosa rara. Le funzioni intellettive e pratiche rimangono
di solito integre, anche quando il disturbo č cronico” (8).
La psichiatria classica definisce il delirio nel modo piů semplice
come falsa credenza. Ma, mentre una normale falsa credenza č
erronea, un delirio paranoide č incorreggibile; č impervio alla
persuasione da parte del sentimento, alla logica della ragione e
all’evidenza dei sensi.
Per esempio, ecco una classica storiella psichiatrica. Un uomo č
convinto di essere morto. Dice ai familiari: “Sono morto” e i familiari
lo mandano da uno specialista. Subito tra medico e paziente
incomincia un’accanita discussione. Il medico fa appello ai
sentimenti dell’uomo verso la vita, verso la famiglia. Poi prova a farlo
ragionare, dimostrandogli l’intrinseca contraddizione di una frase
come “Sono morto”: i morti non sono in grado di dire che sono morti,
perché č appunto in questo che consiste l’essere morti. Alla fine il
medico ricorre all’evidenza dei sensi. Domanda all’uomo: “I morti
sanguinano?”. “Certo che no” risponde l’uomo, spazientito dall’ottusa
dabbenaggine della mente dei medici. “Lo sanno tutti che i morti non
sanguinano”. Al che il medico gli punge un dito. Ne esce una goccia
di sangue. “Ma guarda un po’, chi l’avrebbe mai detto” esclama
l’uomo. “I morti sanguinano, eccome”.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
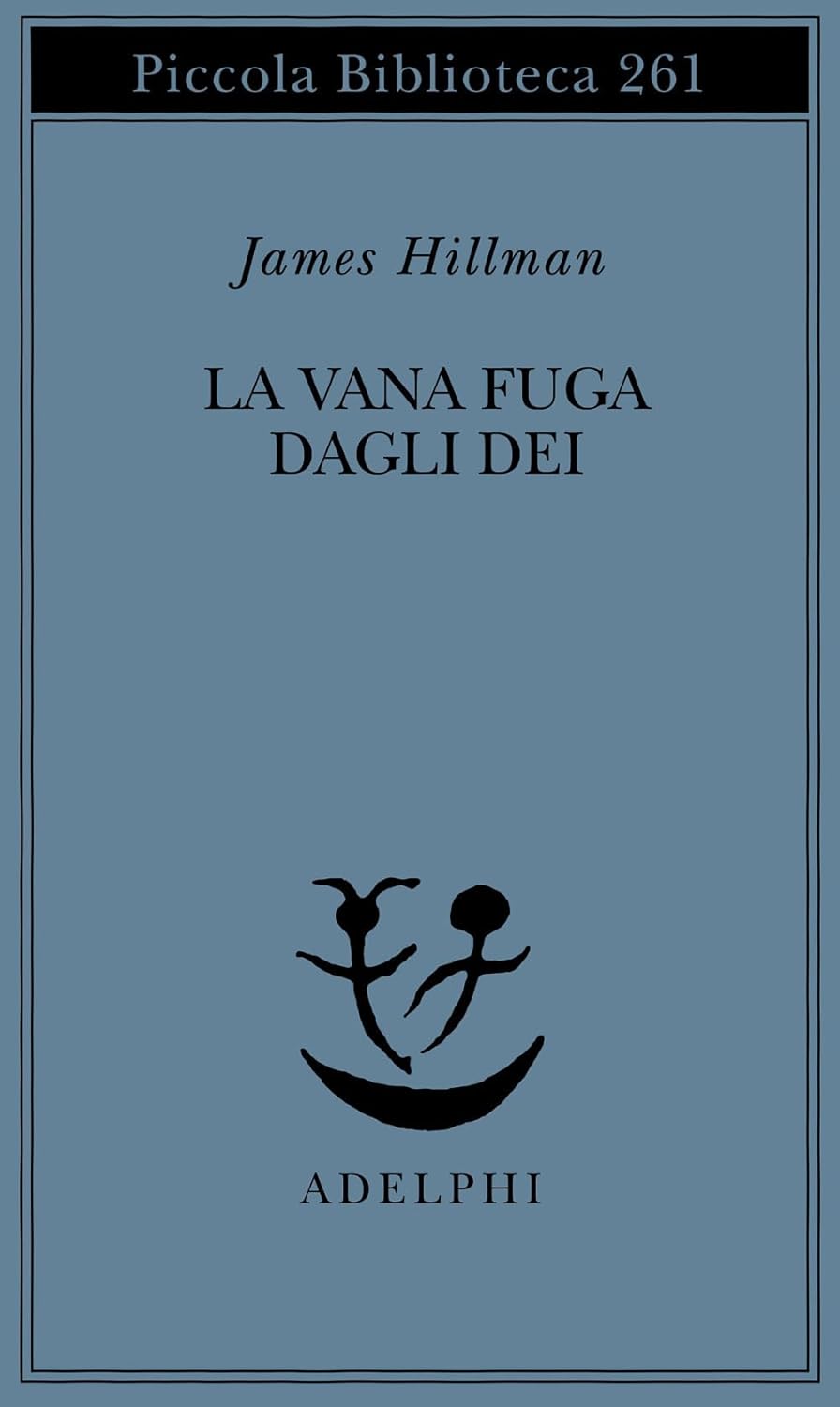






Commento all'articolo