Diritti e libertà nella storia d’Italia – Stefano Rodotà

SINTESI DEL LIBRO:
Capitolo I. Lo spazio e il tempo dei diritti
La nuova realtà di un mondo sconfinato produce spaesamento. Spesso,
allora, si torna a volgere lo sguardo allo Stato nazionale non solo con lo
spirito di chi intende mettere in evidenza il rapporto storico tra questa
forma politica e il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali.
Spiazzati dal nuovo, sconcertati da un continuo rimescolarsi di territori e
categorie, alcuni manifestano la convinzione che proprio lì, all’antico
luogo, bisogna volgere ancora lo sguardo per recuperare tutele perdute, per
un rinnovato riconoscimento di frontiere, al riparo delle quali ritrovare il
senso dell’identità e dell’alterità, che una cieca accettazione della
globalizzazione starebbe cancellando. Uno sguardo realistico, una utopia
regressiva, un esercizio che si tinge piuttosto con i colori della nostalgia?
Dal paese dei «droits de l’homme», degli inventori dei «médecins sans
frontières» e dei «reporters sans frontières» – dunque della tutela senza
confini di diritti fondamentali come la salute e l’informazione – arriva una
critica irridente, affidata a neologismi sbrigativi. «Sansfrontièrisme» e
«droitdelhommisme» sono parole che non vogliono soltanto prendere le
distanze da eccessi o improvvisazioni, ma liquidare senza appello il
riferimento alla nuova dimensione del mondo e alla vecchia garanzia dei
diritti. Il bene della distinzione, la fatica dell’analisi vengono abbandonati, e
tutto viene travolto in un indistinto universo dove compaiono e si
affollano i confini più diversi, non più soltanto quelli storicamente legati
alla logica del territorio e alla sovranità degli Stati: quelli tra i generi, tra
sfera pubblica e sfera privata, tra umano e transumano, tra normalità e
devianza; la pelle come confine del corpo; le divisioni generate dalle
asimmetrie, prima tra tutte quella che separa le guerre codificate e quelle
appunto asimmetriche; gli infiniti muri che percorrono la storia, dalla
Grande Muraglia al Muro di Berlino
22
, la cui caduta non a caso viene
considerata lo spartiacque tra due epoche (ancora un confine); le stesse
dichiarazioni dei diritti, frontiera varcata la quale si entra nel mondo delle
garanzie; e altri, altri ancora
23
. Frontiera e confine divengono tutto e nulla,
e a invocarli in maniera generica perdono ogni valore conoscitivo e ogni
forza ricostruttiva
24
.
Per cogliere i segni del cambiamento, e cercar di capire a che cosa
servono le frontiere
25
, bisogna rivolgere l’attenzione alla loro diversità, alle
modalità e agli effetti della loro determinazione, a chi ha il potere di
definirle. «I confini sono lo strumento mediante il quale riconosciamo e
classifichiamo il molteplice con cui siamo continuamente costretti a
interagire»
26
. Ma il confine può essere difesa o esclusione, riparo o
prigione, registrazione di una realtà o imposizione artificiale d’un vincolo,
demarcazione de re o demarcazione de dicto. «Il confine è l’espressione
materiale di una qualità dello spazio. In generale, in ogni differenza spaziale
si manifesta l’ordine dell’essere, che il pensiero asseconda e rispecchia: è lo
spazio, naturalmente qualificato, ad avere in sé la misura che legittima la
politica»
27
.
Guardiamo ad alcune situazioni concrete, cominciando dalla cittadinanza,
la cui vicenda storica descrive un progressivo proiettarsi della persona al di
là di frontiere concepite appunto come dispositivo di esclusione del non
cittadino. Quando i diritti di cittadinanza divengono quelli che
accompagnano la persona quale che sia il luogo in cui si trova,
l’individuazione di questo spazio infinito, di questo nuovo common, porta
con sé uno stare nel mondo che certamente sfida la cittadinanza oppositiva,
nazionale, puramente identitaria. Di fronte a situazioni come questa,
tuttavia, la reazione non può essere quella di un impossibile ritorno al
passato che, quando è perseguito, si rivela fonte di nuovi e talora
drammatici conflitti. La logica deve essere piuttosto quella della
convivenza, di una diversa dialettica, appunto quella di un continuo
attraversamento di frontiere, quale è messa in evidenza, ad esempio, dal
nuovo rapporto tra globale e locale, e da una loro relazione non
necessariamente escludente che si vuol descrivere con il termine
«glocalismo». Ma l’abbattimento dei confini, in questa dimensione, è
vicenda antica, anche se sempre difficile, che ci porta al biblico «lo
straniero che risiede tra voi lo tratterete come chi è nato tra voi»
28
, che
oggi ci parla del fondamento della cittadinanza e che trovò civilissima eco
nel già ricordato, e per l’epoca davvero rivoluzionario, art. 3 del codice
civile italiano del 1865, ispirato al principio dell’accoglienza, dove si
affermava che «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al
cittadino».SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
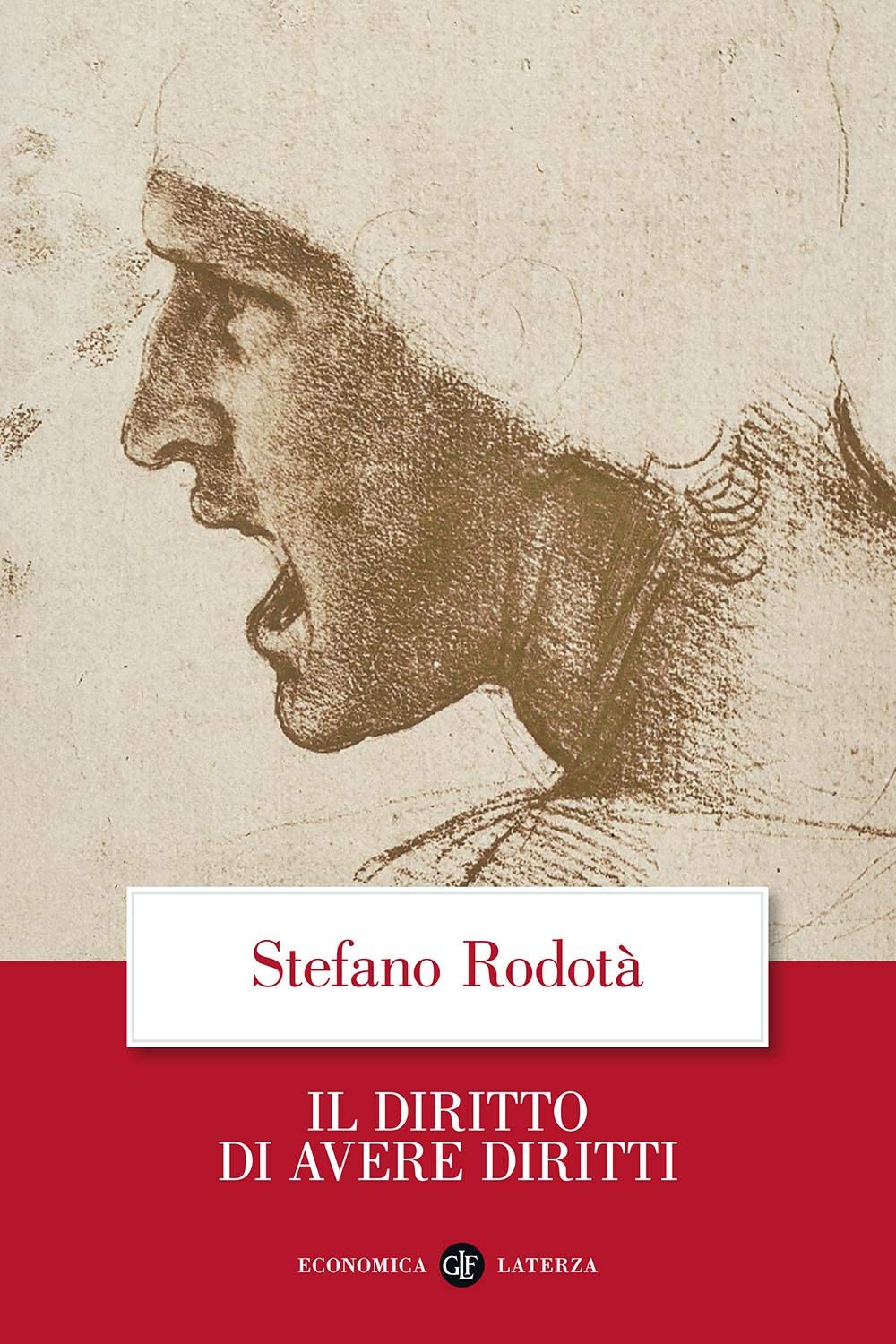






Commento all'articolo