Il richiamo della foresta: Versione integrale arricchita da splendide e rare foto sulle dure condizioni di vita dei cercatori d’oro e avventurieri dell’Alaska – Jack London
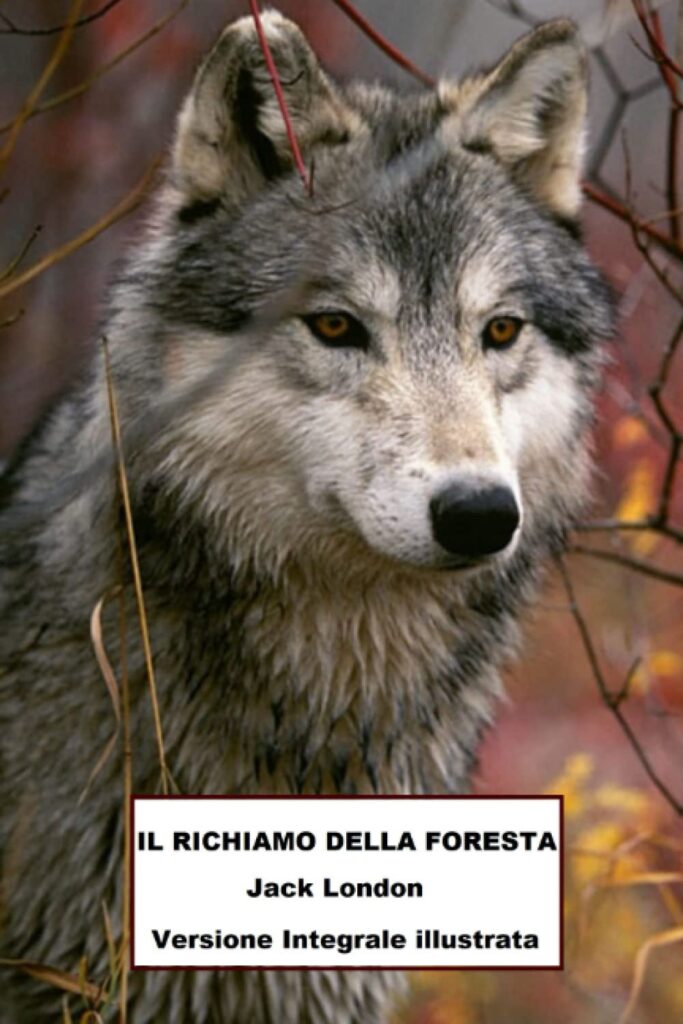
SINTESI DEL LIBRO:
Amatissimo in Italia fin dal decennio successivo alla morte, Jack London è
ancora vittima del mito che lo accompagnò in vita, un mito diffuso da lui
stesso e poi dai suoi (moglie e figlia che ne scrissero la biografia), che si è
sempre sovrapposto al suo volto impedendo di distinguere i suoi veri
lineamenti da quelli dell’eroe emergente dalle pagine dei suoi libri. Quel
biondo eroe che sfida il mondo intero, che sopporta durezze d’ogni specie
dagli uomini e dalla natura, quella specie di Cristo verniciato da superuomo
alla Nietzsche, che fa il pugile, il cercatore d’oro, il marinaio, l’ubriacone,
sempre sconfitto e sempre trionfante grazie al suo indomito nucleo di purezza
primigenia, in Italia lo abbiamo cominciato a conoscere a metà degli anni
Venti, quando il fascismo, sepolto Matteotti, stava consolidando il suo
potere. Eppure Jack London, il più popolare e meglio pagato scrittore
americano del primo quindicennio del secolo, era, o voleva essere, un
rivoluzionario, un autentico socialista marxista. Ma al fascismo andava bene
il propagandista di Nietzsche, il narratore della violenza, il poeta delle
solitudini selvagge e incontaminate.
Le case editrici se lo disputavano, pubblicavano contemporaneamente le
sue opere, la Sonzogno e la Barion («casa per edizioni popolari») avevano i
cataloghi colmi non solo di Il richiamo della foresta, Zanna bianca, Il lupo
dei mari, Martin Eden, ma anche di cose melodrammatiche e sentimentali
come La piccola signora della grande casa. Quando il fascismo finì, i
comunisti Editori Riuniti e la Feltrinelli non fecero altro che spostare
l’attenzione sulle opere di denuncia sociale, come Il tallone di ferro,
romanzo-profezia sulla lotta di classe, e Il popolo dell’abisso, inchiesta sui
cinquecentomila diseredati degli slums di Londra. Del resto, in qualunque
paese si volesse far credere che c’era una rivoluzione, si leggeva London,
proprio lui che nelle sue lettere si firmava «vostro per la rivoluzione»;
proprio lui di cui negli anni Quaranta, prima della caccia alle streghe, un
critico non sospetto come Alfred Kazin, disse che in America «fu il prototipo,
se mai ve ne fu uno, dell’intellettuale fascista adoratore della violenza».
Come penetrazione, non c’è davvero male.
Il London che abbiamo conosciuto in Italia fu colui che, assai prima degli
Hemingway, dei Faulkner, degli Steinbeck, ci portò un gran soffio di
freschezza dal nuovo mondo, un’insolita visione della vita, un’ansia di
vagabondare dovunque, per terra e per mare; colui che scriveva libri
intitolati The Road (La strada) e che teneva conferenze su uno dei suoi
argomenti favoriti, «the Tramp», ossia il vagabondo; colui che, figlio
illegittimo d’un astrologo ambulante, fu ladro di ostriche nei vivai della baia
di San Francisco, marinaio a diciassette anni, studente, cercatore d’oro, vero
eroe romantico da strada, dedito a ogni sregolatezza ma grandissimo
lavoratore (cinquantuno volumi in sedici anni, dall’inizio del secolo alla
morte, avvenuta nel 1916, in sospetto fra malattia e suicidio), giornalista
straordinario, che seguì da inviato speciale la guerra russo-giapponese del
1904 e scrisse nel 1906 un memorabile resoconto del terremoto di San
Francisco; colui che, confusamente imbevuto di darwinismo, di imperialismo
alla Kipling, di naturalismo e di superuomismo, si identificò da vivo con la
spinta progressista impressa alla vita americana dei primi anni del secolo da
Theodore Roosevelt e diventò da morto preda di tutte le ideologie; colui
infine che Trotskij giudicò con tanta simpatia, che Upton Sinclair, suo amico
e compagno di strada, definì «una delle grandi figure rivoluzionarie della
storia americana».
II.
Vi sono strane coincidenze in talune circostanze della vita e del destino di
due scrittori apparentemente così diversi quanto Jack London e Guy de
Maupassant. C’è intanto un elemento che li collega, per cui vale la pena di
arrischiare un piccolo esperi-mento di letteratura comparata; ed è questo:
ambedue popolarissimi in vita e dopo, non godono dei favori della critica
secondo i loro meriti e sono spesso snobbati anche dai loro colleghi scrittori,
restando poi veri oggetti di culto per gli altri che non possono non esser
soggiogati dalla maestria e dalla verità artistica, oltre che dalla potenza, di
molte loro rappresentazioni.
Maupassant, ammiratissimo da Tolstoj e Proust, non lo fu invece dal
supercilioso André Gide che lo definì «operaio delle lettere», da Albert
Camus, da Paul Claudel e da tanti altri più letterati che artisti, mentre un
grande narratore come Georges Simenon lo poneva davanti a Victor Hugo e
a Émile Zola. La prestigiosa collezione dell’editore Gallimard, «La Pléiade»,
che insieme ai grandi classici ha accolto tante mediocrità, non ha incluso
Maupassant che a partire dal 1975.
Quanto a London, tranne qualche eccezione, egli è stato ignorato,
bistrattato, o considerato con sufficienza dalla critica ufficiale americana.
Per fare un esempio illustre, Alfred Kazin, nella sua storia d’un
cinquantennio di letteratura americana
1 si chiede, alla fine delle poche
pagine dedicate a London:
Fu London lo scrittore veramente grande quale alcuni lo ritengono, fu un talento
possente nato fuori tempo, o fu uno di quegli artisti secondari la cui opera, grazie alla
ricchezza della loro esperienza personale, dà solo una falsa impressione di arte? È
difficile dirlo. Forse [...] egli sarà ricordato come uno degli ultimi avventurieri del
West, come romanziere «pioniere del socialismo», [..] come amico di tutti quei
ragazzi che vorrebbero scappare di casa.
Il tono sussiegoso e benevolo di Kazin, la sua retorica domanda, che può
essere applicata a qualsiasi scrittore o artista o anche a qualsiasi persona
che per un merito o l’altro abbia acquistato un certo rilievo e sia quindi
oggetto di ammirazione e denigrazione («visto da destra o da sinistra»: si
può fare anche con Dante o con Garibaldi), non bastano a nascondere una
realtà indiscutibile: che London, se non piace a certa critica, piace al
pubblico; e come il suo connazionale Edgar Allan Poe e come il francese
Guy de Maupassant, il suo vero pubblico non è quello della sua nazione,
dove l’establishment culturale deve seguire le regole, ma del mondo intero,
poiché con la sua opera egli tocca corde, chiamiamole pure primordiali, che
risuonano nel cuore d’ogni uomo: la vita, la morte, l’amore, la paura,
l’orrore, in rappresentazioni dirette e possenti.
Tornando a London-Maupassant, dopo avere notato somiglianze nella loro
vicenda come la vita breve (quarant’anni il primo, quarantatré il secondo), il
faticoso apprendistato, la gloria repentina, la produzione a getto continuo,
l’amore dell’acqua, la vigorosa vita sessuale – somiglianze che, seppure in
numero tale, da uscire dalla semplice casualità, potrebbero comunque esser
considerate coincidenze – si deve dire che la loro parentela forse più vistosa
è nella visione del mondo. Diversa, ma non tanto, nell’uno e nell’altro, la
loro Weltanschauung è a tinte forti e nette e risulta da esperienze personali
spesso traumatiche su cui si sovrappongono, a guisa di corazza protettiva,
cognizioni filosofico-scientifiche a formare una specie di sistema. Il quale,
proprio per essere così personale, non ha né può avere altro valore se non di
motivo propulsore e, in parte, di struttura portante che però non si deve
scorgere, né deve soverchiare la materia narrativa, ma far tutt’uno con essa.
Il torto dei critici è stato, nel caso di London, di prendere alla lettera certe
affermazioni, senza considerare che esse, come spessissimo le professioni di
fede (di ogni specie) hanno soprattutto un valore psicologico.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
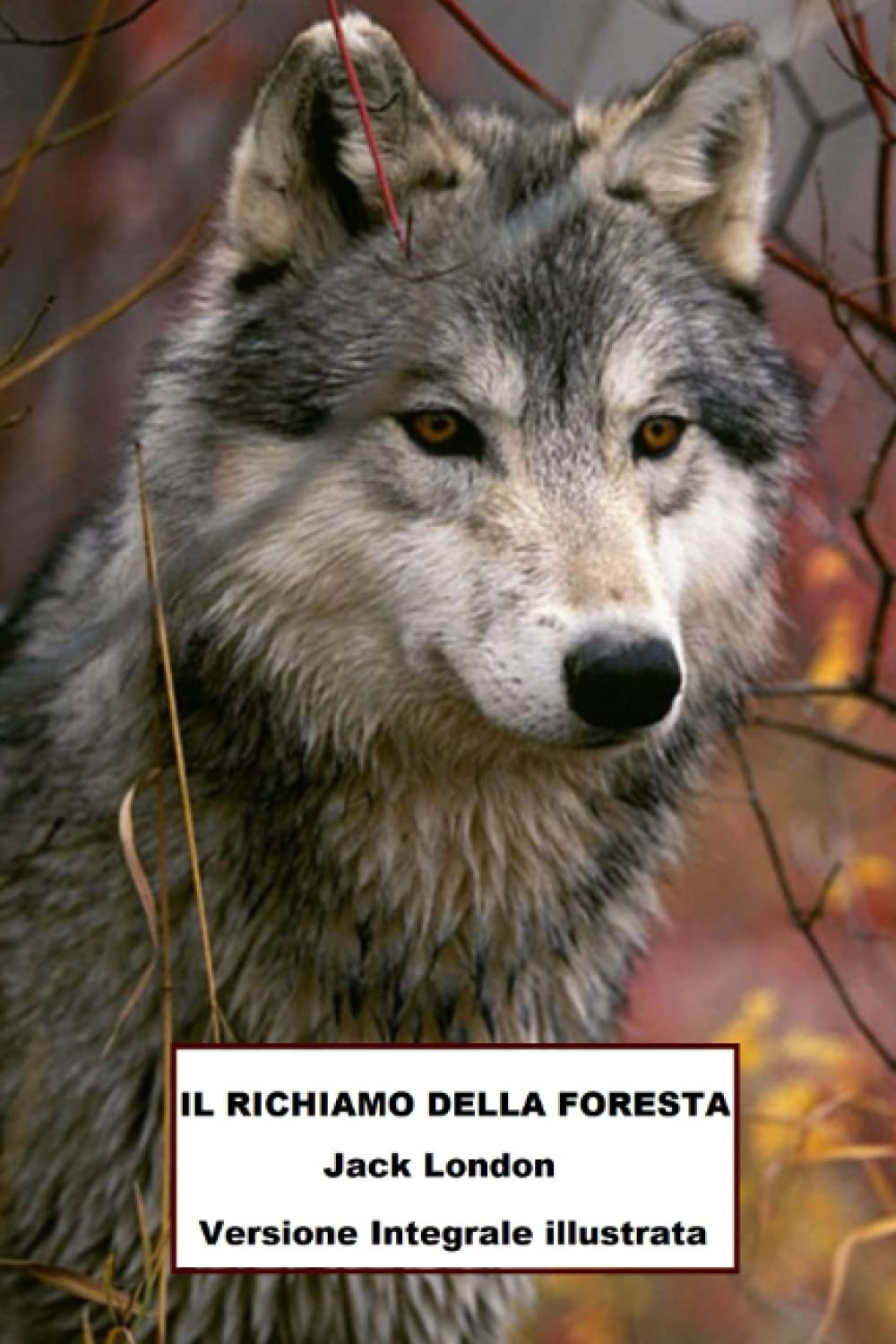






Commento all'articolo