Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia – Enzo Collotti
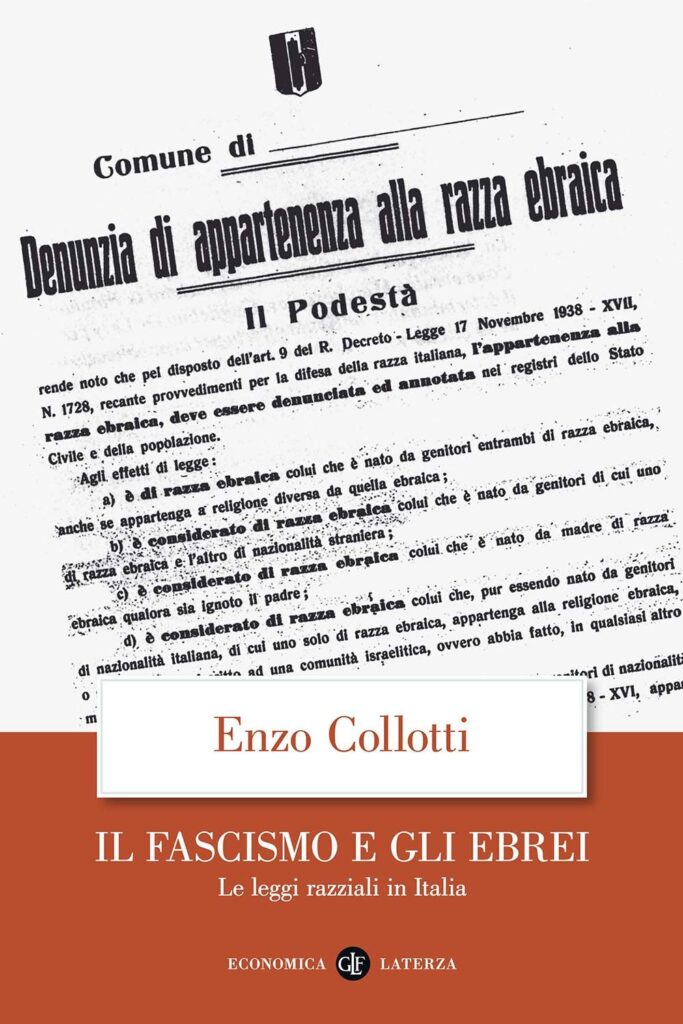
SINTESI DEL LIBRO:
Soltanto in epoca molto recente la storiografia italiana ha cominciato a
riflettere seriamente sulle origini e sul percorso di lungo periodo di un
razzismo italiano, uscendo dai limiti angusti degli anni della persecuzione
fascista contro gli ebrei. Sicuramente questa ricerca è stata sollecitata dal
recupero, seppure così tardivo, degli studi sulle conseguenze delle leggi
razziste del 1938 avvenuto con il rinnovamento di prospettiva che ha fatto
seguito alla data cinquantenaria della ricorrenza della legislazione
discriminatoria, che ha coinvolto studiosi (e non solo storici in senso
stretto) e opinione pubblica in un rinnovato e quasi inedito interesse per
la questione ebraica in Italia. Essa era stata oggetto, nel 1961, del
pionieristico libro di Renzo De Felice intitolato Storia degli ebrei in Italia
sotto il fascismo rimasto per lungo tempo un contributo isolato nel
panorama della storiografia, con l’eccezione di qualche ricerca di carattere
essenzialmente locale. Negli ultimi quindici anni la sensibilità verso
questo momento della nostra storia ha subito una notevole
rivitalizzazione e abbiamo assistito e stiamo assistendo al decollo di una
nuova storiografia attenta a integrare organicamente e in modo sempre
più avvertito il capitolo del razzismo e dell’antisemitismo nella storia del
fascismo come uno degli aspetti caratterizzanti della svolta più
tipicamente totalitaria degli anni Trenta.
In questo quadro era inevitabile che si desse luogo a un duplice processo
di rivisitazione storiografica. Essa riguarda la più generale collocazione
degli ebrei nella storia d’Italia, e non solo dell’Italia unita, sebbene sul
periodo posteriore all’emancipazione sia stata concentrata per varie
ragioni l’attenzione prioritaria, con gli studi sull’editto albertino e
soprattutto con i contributi confluiti nei due tomi del nono volume degli
einaudiani Annali della Storia d’Italia dedicati agli ebrei (1996-97), dai
quali è derivato anche l’importante libro di M. Sarfatti dal titolo Gli ebrei
nell’Italia fascista (2000), al di là del più generale svecchiamento della storia
degli ebrei italiani rispetto alla pur sempre benemerita opera di Attilio
Milano.
Già Attilio Milano ebbe a sottolineare i due tempi in cui avvenne in
Italia (o almeno in buona parte della penisola) il processo
dell’emancipazione degli ebrei quando scrisse: «1791-1815: un convulso
quarto di secolo, in cui l’ebbrezza della equiparazione si impossessò anche
degli ebrei italiani, li esaltò, li illuse, li tradì». Perché, scomparsi i segni
della risonanza della Rivoluzione e del ciclone napoleonico, la
Restaurazione ripristinò buona parte dei limiti e dei divieti che la
presenza delle armate francesi aveva temporaneamente abbattuto
nell’Italia centro-settentrionale in territori piemontesi, lorenesi, austriaci
e financo pontifici. Tuttavia, con la sconfitta napoleonica e il ritiro delle
armate francesi quasi in nessuna parte dell’Italia il ripristino della
situazione ad essi anteriore significò il ritorno degli ebrei alle condizioni
restrittive precedenti, poiché una prima breccia nei loro statuti di
interdizione era stata pur sempre praticata. Soltanto nella Roma papalina
il ritorno del potere temporale comportò anche che gli ebrei fossero
ricacciati nel ghetto, che sarebbe stato dischiuso definitivamente soltanto
il 20 settembre del 1870. Quasi dappertutto aveva avuto inizio un
processo di liberalizzazione che la Restaurazione poté contenere ma non
fare regredire, come se le ondate egualitarie della Rivoluzione e della
dominazione napoleonica non si fossero mai abbattute sull’Italia.
L’emancipazione finale avvenne nel solco del Quarantotto italiano ed
europeo quando erano maturate anche nella coscienza civile e pubblica –
sono del 1837 le Interdizioni «israelitiche» di Carlo Cattaneo – le condizioni
per il pieno riconoscimento dell’equiparazione degli ebrei agli altri
cittadini degli Stati italiani nella conquista dei diritti civili. Lo Statuto
Albertino del 4 marzo 1848 non sancì l’agognata emancipazione ma ne
costituì il presupposto. Riconosceva intanto l’eguaglianza dei cittadini
senza distinzione di confessione; a questo primo riconoscimento fece
seguito il 29 marzo l’editto che riconosceva esplicitamente agli ebrei i
diritti civili, completato nei mesi successivi dalla legge del 19 giugno che
ne proclamava la piena integrazione anche nei diritti politici. In tal modo,
con questo complesso iter legislativo parallelo anche all’equiparazione di
altre minoranze (nel caso specifico i valdesi), si compiva anche un capitolo
della trasformazione in senso liberale del regno sabaudo. E nello stesso
tempo si stabilivano un precedente e un modello che, con le successive
annessioni al Regno di Sardegna di altri territori italiani attraverso le
guerre di indipendenza, avrebbero consentito di estendere anche alle altre
regioni i principi dell’emancipazione.
Si è avuta poi una totale revisione, se di fondazione non si volesse
parlare, di una storiografia sul razzismo italiano. Ferma restando
l’autonomia concettuale e fattuale della categoria dell’antisemitismo nelle
sue diverse declinazioni (come antigiudaismo cattolico e come
antisemitismo di derivazione laico-illuministica), merito dei nuovi studi è
stato quello di consentire un approccio globale al fenomeno del razzismo,
nella complessità delle sue componenti e delle sue derivazioni culturali,
nel cui alveo è venuto a situarsi nel periodo fascista anche l’antisemitismo,
con la radicalizzazione biologistica assunta dalla persecuzione contro gli
ebrei. Già la mostra bolognese La menzogna della razza del 1994, promossa
dal Centro culturale Furio Jesi, e il successivo convegno di studi derivato
dallo stesso ambito culturale (e sfociato nei contributi del volume Nel
nome della razza uscito nel 1999 a cura di Alberto Burgio) avevano messo
in evidenza la fecondità di approcci diversi ma convergenti alla
problematica dell’onda lunga di un razzismo italiano, sì da fare emergere
negli anni del fascismo non la risultante necessaria e scontata di una serie
di corposi precedenti, ma il momento di massima concentrazione e
condensazione di pulsioni, elaborazioni dottrinali ed esperienze pratiche
che non erano state estranee alle vicende storiche della cultura italiana nei
campi più diversi (dall’antropologia alla medicina, all’eugenetica,
dall’etnologia alla psicologia, alla demografia, alla geografia, alla
storiografia, alle scienze giuridiche). Pertanto, le leggi razziste del 1938
non potevano essere più considerate alla stregua di un masso erratico
caduto su un terreno vergine al di fuori di ogni precedente
contaminazione.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
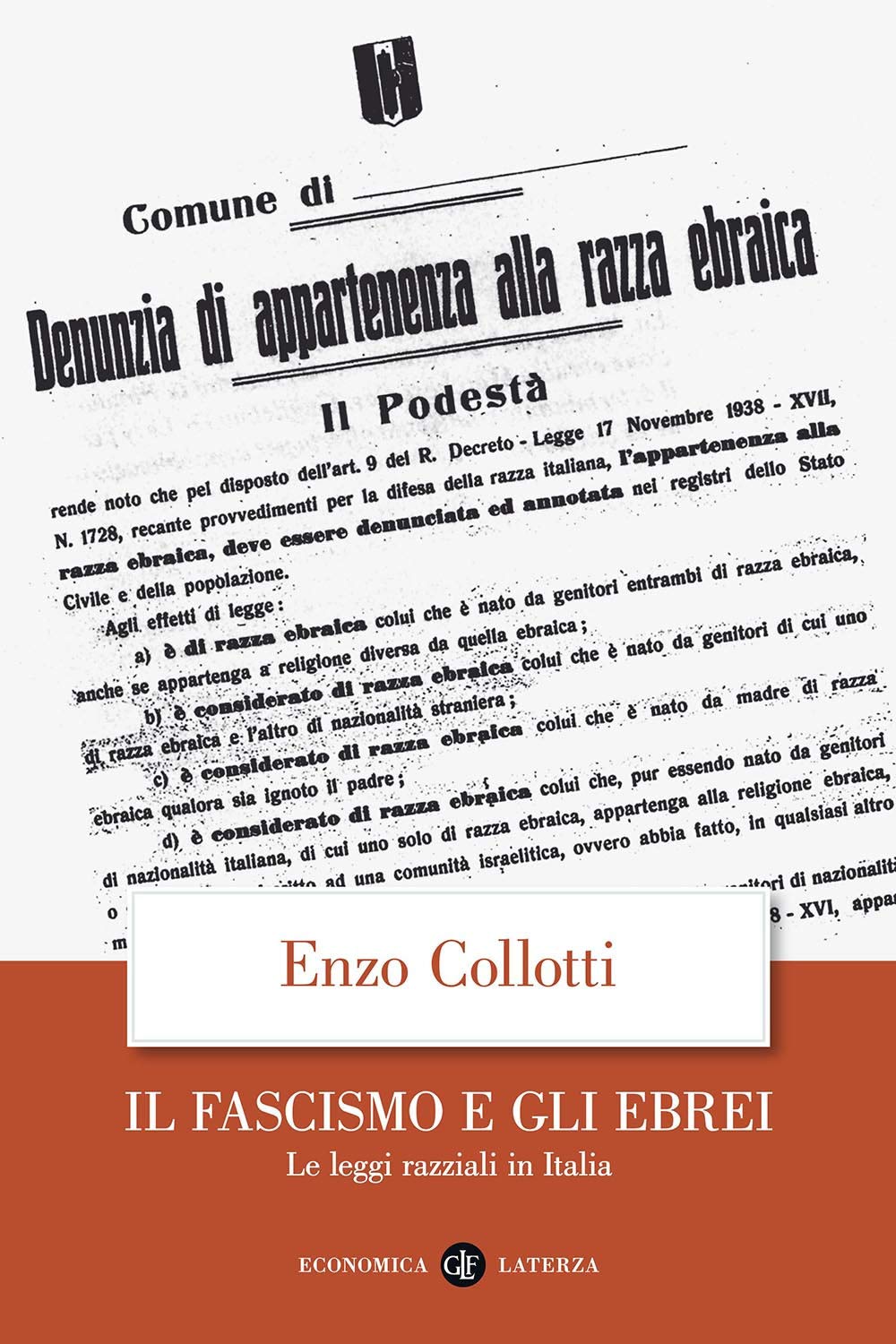






Commento all'articolo