I nemici degli italiani – Amedeo Feniello
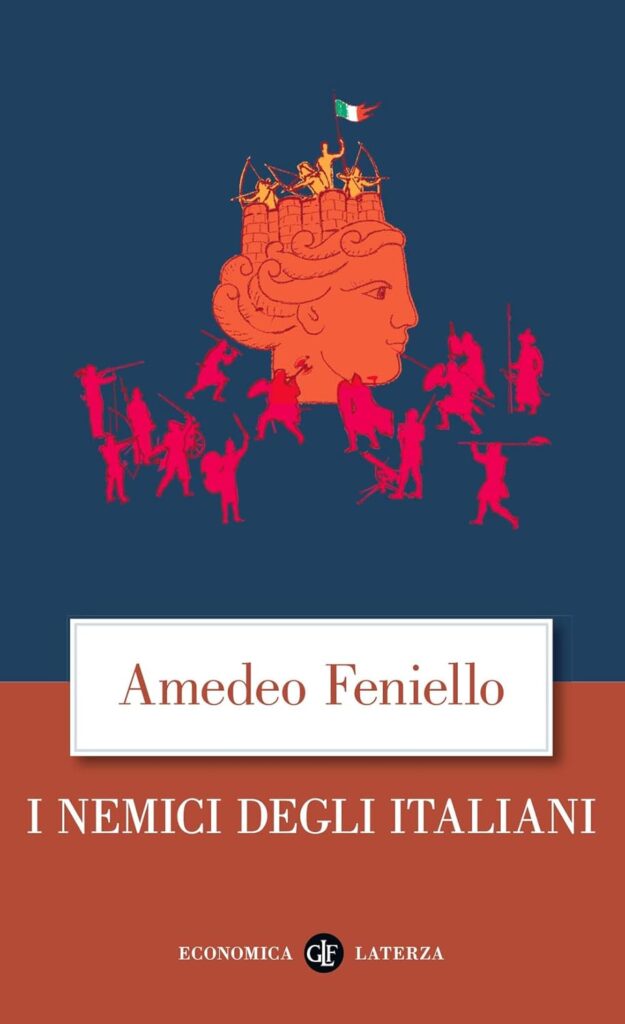
SINTESI DEL LIBRO:
Latini, Volsci, Equi, Etruschi, Sanniti, gente della Magna Grecia,
Tarantini, Siracusani. Sì, perché prima di Roma, l’Italia ebbe altri popoli.
E a un certo punto tutti ebbero un solo nemico, che, pian piano li
fagocitò: Roma. Cosa pensassero di quel piccolo popolo laziale, difficile
dirlo: la storia come al solito l’hanno scritta i vincitori. Qualcosa però è
rimasto, nelle pieghe, negli interstizi, in qualche traccia sperduta. Come
le parole del sannita Gaio Ponzio, figlio di Erennio, per Livio «insigne
guerriero e condottiero egli stesso», pronunciate intorno al 320 a.C. Sono
frasi filtrate, smussate dall’ideologia, trasformate dallo storico romano,
eppure qualcosa dell’odio verso l’assalitore romano la dicono: i Romani
sono «coloro che non potranno essere placati se non daremo loro il nostro
sangue da succhiare e le nostre membra da sbranare» (Livio, Storie, IX, 1,
9). Ed è la stessa rabbia, spesso impotente di fronte ad un nemico
implacabile, che ritroviamo in altri, non Italiani, che comunque vissero lo
stesso furore, la stessa collera romana. Una prospettiva dei vinti che
qualche volta ritorna: come nel discorso, celebre, del gallo Critognato,
che vale la pena che le ricordi, passo per passo, perché le sue parole sono
fiere ma disperate, come lo furono per i tanti Italici che si scontrarono
con questo nemico spietato sorto un giorno al centro della Penisola:
Ma i Romani che altro chiedono e vogliono se non, spinti dall’avidità, insediarsi sulle terre e
nelle città di coloro che conobbero nobili per fama e possenti in guerra e imporre loro per sempre
il giogo della schiavitù? Non hanno mai fatto una guerra senza altro motivo. Se ignorate quanto
accade alle nazioni lontane, guardate, vicino a noi, la parte della Gallia che, ridotta a provincia,
sottoposta a leggi e istituzioni diverse, soggetta alla scure di Roma, è oppressa da una perpetua
schiavitù (Cesare, La guerra gallica, VII, 77).
Le parole. Sono loro a seminare la memoria del nemico. Cosa sono i
Romani, allora, questi costruttori di impero e di civiltà? Dei latrones,
ladroni, avidi di ricchezze, cupidi di potere, inaffidabili e in malafede.
Quasi barbari, d’altronde, per altri, per i Greci del Sud Italia. Perché, la
sapeva lunga Tacito, i Greci non ammirano che loro stessi. Per loro, tutti
gli altri sono ostili. Barbari, cioè balbettano lingue incomprensibili.
Anche i Romani rientrano in questa categoria? Sì e no. Non sono proprio
subumani ma quasi. Hanno le loro regole, la loro civiltà, le loro
istituzioni. Ma vuoi mettere coi Greci. Altra gente, altra stirpe. Anche per
san Paolo era così: «Greci e barbari, sani e folli». Insomma, in due si
divide il mondo. E i Romani fanno parte degli altri. Sono nemici e sono
quasi barbari. Che si espandono, mai secondo una politica di annessione
pura e semplice. Ad ondate, che si allargano a mano a mano, prima
lentamente poi con una velocità che sorprende, rapida ed esclusiva. Con
tappe leggendarie: Regillo, lo scacco sannita delle Forche Caudine, il
terrore dei Galli di Brenno, la vittoria su Pirro, capace di vincere tutto ma
di non vincere la guerra. Come ci siano riusciti i Romani a vincere tanto
e progressivamente, si sa. Attraverso tre imperativi: organizzazione,
organizzazione, organizzazione. Di una società, di una cultura, di un
esercito. E di una rivoluzione, che si inserisce intorno al 390 a.C.,
quando la macchina militare muta sembianze. Si trasforma nella pelle e
nell’anima. Comincia ad adattarsi a circostanze impreviste e inattese. Si
determinano ruoli, incombenze, capacità, gerarchie. Niente viene lasciato
al caso. Niente deve essere caotico, ma ognuno, nella legione manipolare,
deve avere il suo posto. Il suo compito preciso. La legione diventa un
organismo dotato di una sua autonomia ma, al contempo, di una sua
razionalità organizzatrice. Così si fa la guerra. Contrapponendo ordine al
disordine. Razionalità all’entusiasmo. Capacità di controllo dello spazio,
con un esercito di genieri abile nel costruire strade, palizzate, armi
d’assedio, fortilizi in grado di occupare stabilmente un territorio da
contrapporre alla casualità di operazioni militari spesso coraggiosissime
ma prive di qualunque pianificazione. E Roma travolge i suoi avversari.
Ma non li vince solo militarmente. Perché le genti conquistate, le altre
popolazioni italiche, vanno assimilate. Azzerate nelle loro abitudini e nelle
loro culture. Assoggettate, con l’imposizione di nuovi vincoli, costumi,
leggi. E Roma si allarga sempre di più, non solo aggregando alleati ma
colonizzando terre e creando cloni della madrepatria, dappertutto.
E i Greci del Mezzogiorno quanto furiosi fossero i Romani, quanto
terrorizzanti le loro legioni, lo vissero direttamente sulla loro pelle, come
durante la seconda guerra punica. Con massacri atroci, pensi a quello
perpetrato allora ad Enna, dove, è Livio a guidarci, la strage e la fuga degli
abitanti fu tale che «precipitavano gli uni sulle teste degli altri e si
ammucchiavano cadendo gli illesi sui feriti, i vivi sui morti» (Livio, Storie,
XXIV, 39, 5). Come atroce fu il saccheggio di Siracusa, disgustoso per furore
e cupidigia, con un bottino «altrettanto grande che se fosse stata presa
Cartagine» (Livio, Storie, XXV, 31, 11). Niente di nuovo. È la guerra. La
sua follia. Il disprezzo totale del nemico. Una vicenda barbara, agli occhi
dei Greci. Una storia italiana, come vedremo.
Questo mondo, per i Romani, doveva morire. E si scontrano due
culture: tecnologia e scienza ellenistica contro tenacia e organizzazione
romana. Fino all’assedio durissimo e al massacro di Siracusa. Punta
estrema di un’espansione cominciata nel tardo IV secolo a.C. e che
adesso, in questo fatidico ultimo decennio del III, era arrivata ad un
momento cruciale, alla sfida con Cartagine per il controllo del
Mediterraneo e delle terre che lo circondavano.
Contro un nemico così resiliente, così potente, così convinto della
propria energia, capace di ricostruire dalle proprie ceneri legioni e legioni,
cosa fare? Militarmente niente. Soccombere e basta. Ma prima di morire,
alcuni vinti da Roma, come i Greci della Magna Grecia, hanno un
ultimo sussulto. E inoculano un virus. Che si insinua a partire già qualche
decennio dopo la caduta di Siracusa. È un virus rapido che trasforma il
vinto in vincitore. Nessuno, meglio di Orazio, ha spiegato questa cosa.
Con un verso straordinario. Rapido ed essenziale, come era spesso nel
suo stile: «la Grecia conquistata [dai Romani], conquistò il selvaggio
vincitore e le arti portò nell’agreste Lazio» (Orazio, Epistole, II, 1, 156-
157).
Il virus serpeggia dappertutto. Superando gli ostacoli, attraversando gli
spazi, coinvolgendo senza distinzione donne e uomini. E penetrò.
Profondo. Nei costumi. Nella vita e negli stili quotidiani. Nei profumi
delle donne. Nel lusso degli uomini. Nelle danze e nelle musiche. Nei
modi di vestire e di mangiare, di pregare e di governare. Nell’arte e nella
conoscenza. Questa cultura che ha il profumo del Mediterraneo sprizza
quell’intensità che non apparteneva assolutamente al senso della vita
romano, selvaggio, barbaro e agreste, come diceva Orazio. Improntato al
rigore, alla misura, al decoro, ai buoni costumi, a tradizioni rurali e
conservatrici, al mos maiorum. La vita vista con l’occhio di un greco offre
invece un orizzonte nuovo, di passionalità, inventiva, filosofia,
immaginazione, fantasia. Crea qualcosa che a Roma quasi non si
conosceva: il gusto di scrivere versi d’amore, di cantare i baci, gli abbracci,
il piacere di raccontare chi si ama. Crea, insomma, la letteratura. E, poi,
cosa dire di quella nuova sensibilità spirituale che arriva dalla Magna
Grecia che spingeva a rinnovare i culti. La fede. La religione. Di ispirarsi a
qualcosa di arcano che fosse più adatto ad una civiltà giorno dopo giorno
sempre più complessa cui rispondevano con sforzo le voci di Lari e
Penati, dei pontifices maximi, dei culti contadini remoti e trapassati. Di
fronte a queste possibilità, di fronte a queste novità, non c’è muro di
tradizioni che tenga. E la diga si spacca. Senza neanche che ci voglia
troppa energia. E l’onda greca tracima e sussulta. Benché le resistenze non
mancassero. Le leggi suntuarie. Le censure. I blocchi. Le ingerenze. I
senatusconsulta, i pareri vincolanti del Senato, come quello, celebre, contro
il culto di Bacco, del 186 a.C., considerato pericolosissimo per l’intera
società e che, anche per Livio, si propaga come un flagello che si spande a
macchia d’olio, dalla Magna Grecia verso il nord, alla Campania,
all’Etruria e poi a Roma, dove questo nemico invisibile si nascose entro la
vastità dell’Urbe, per i benpensanti una incomprensibile fucina di
depravazioni, in cui la follia sembra farla da padrona e «gli uomini come
impazziti vaneggiavano gesticolando da invasati con tutta la persona e le
matrone, in atteggiamento di baccanti, coi capelli sparsi [...] si dicevano
rapite dagli dèi». Un’isteria collettiva che assume presto i contorni di un
fenomeno di massa, composto da «una folla numerosa, ormai quasi un
secondo popolo e, fra questi, taluni cittadini e donne della nobiltà» (Livio,
Storie, XXXIX, 13, 12-14), che fu repressa nella maniera più violenta e
accanita.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
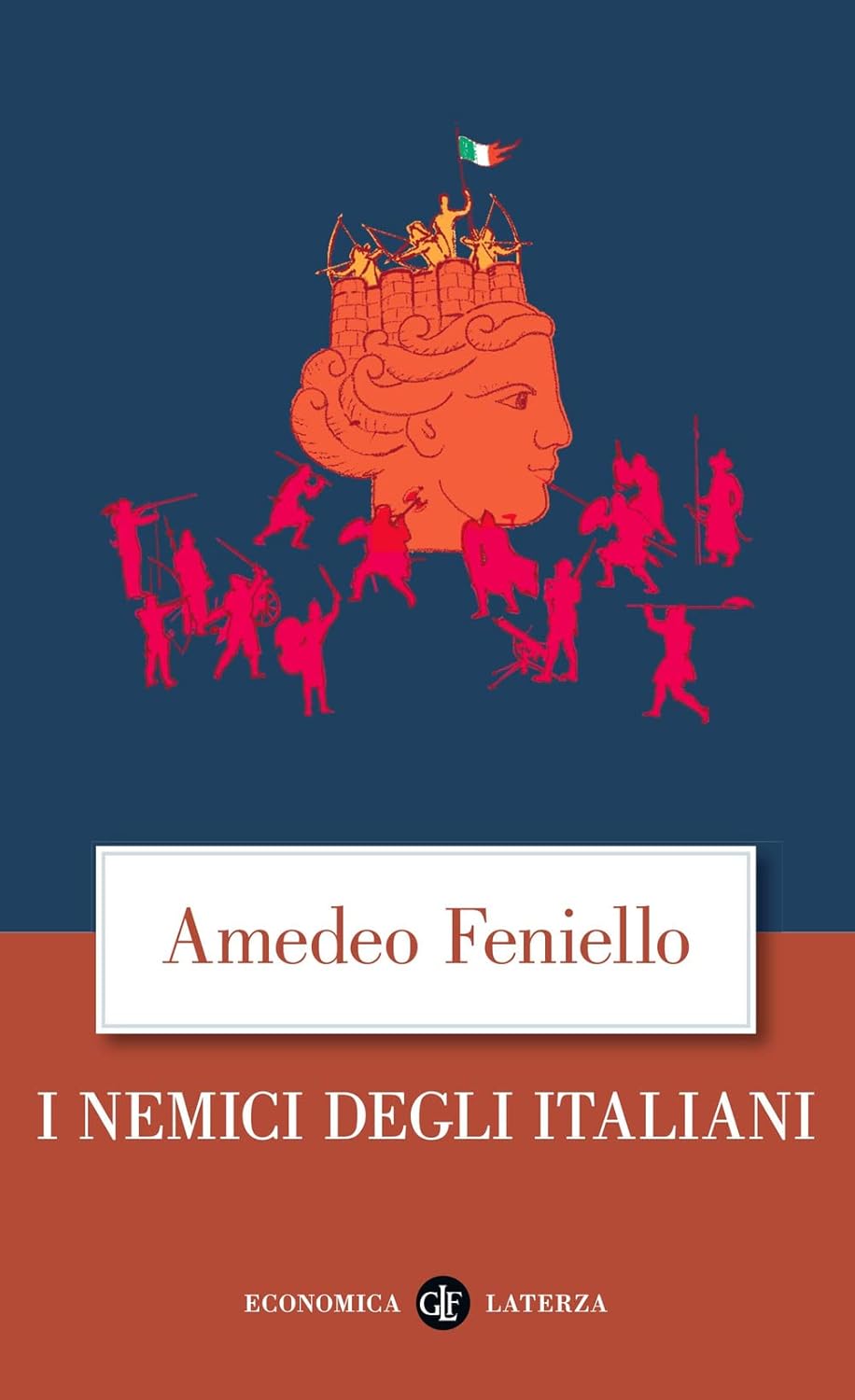






Commento all'articolo