I manicomi criminali – Valcarenghi Marina
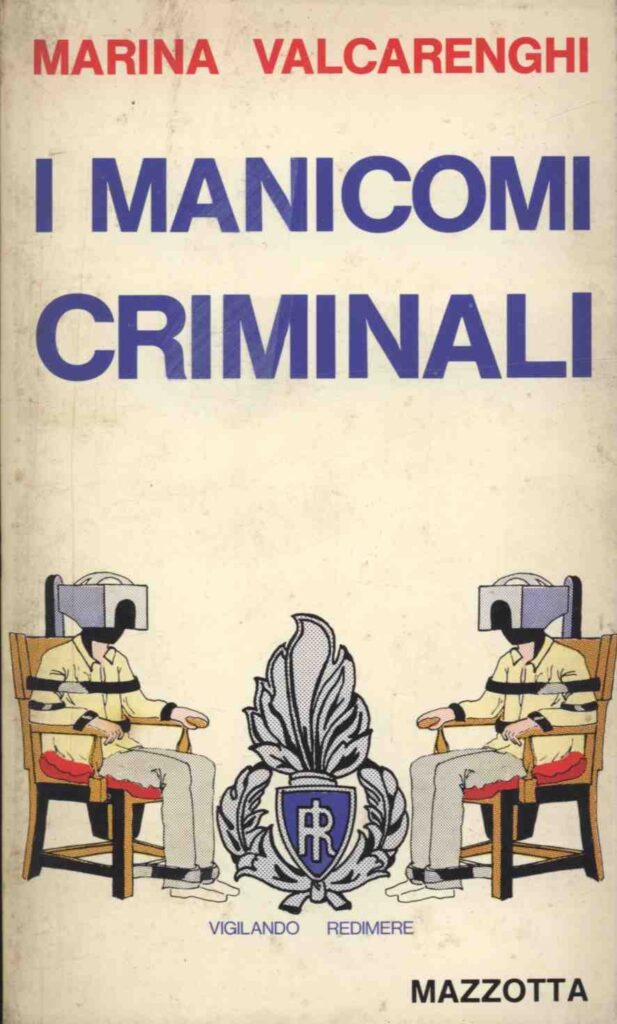
SINTESI DEL LIBRO:
Origine dell’internamento
La reclusione e l’internamento nascono assieme al capitalismo alla fine
del XVIII secolo e si affermano come pena universale intorno al 1830.
Intendo la reclusione e l’internamento fini a se stessi, perché il carcere
esisteva da sempre, si può dire, ma prima era solo un passaggio per uomini
e donne in attesa di altri destini: la gogna, l’esilio, il supplizio.
La monarchia assoluta celebrava nel supplizio pubblico la vendetta
contro l’offesa al principe e la ricomposizione della sovranità violata; il
popolo con la sua presenza in piazza testimoniava la restaurazione
dell’ordine.
Ma la vita dei poveri aveva, in una società feudale, assai scarso valore,
ce n’erano troppi. Le guerre, le epidemie, le carestie, la mortalità infantile
contribuivano a fare della morte un avvenimento consueto. Certamente,
quindi, nel supplizio, l’esecuzione era il punto d’arrivo obbligato, ma non
credo il fondamentale. Quello che veramente contava era il tormento fisico,
il corpo essendo l’unica ricchezza della stragrande maggioranza dei
condannati; non a caso, il carnefice prolungava al massimo il colpo mortale.
All’eccesso della pena si contrapponeva, però, un controllo sociale
distratto e discontinuo che lasciava filtrare continui illegalismi, perché il
potere assoluto poteva in qualsiasi momento stringere le maglie della
repressione.
Dopo la rivoluzione francese il progressivo affermarsi della società
industriale richiedeva un ribaltamento di questa logica: da una parte,
l’esigenza di un controllo sociale sulla proprietà ormai suddivisa e sui centri
urbani che cominciavano a gonfiarsi, dall’altra, una pena che tenesse conto
del diverso (aumentato) valore mercantile dell’uomo proletario. Alle
«grida» si sostituiscono le leggi. La funzione primaria della pena non
cambia: era (ed è) quella di legittimare il potere che la infligge, ma
cambiava la sua qualità perché era mutato l’assetto economico e quindi il
ruolo dello sfruttato e il suo valore. Così, la pena non doveva più essere
esemplare, ma efficace, non doveva più necessariamente uccidere una
persona, ma sorvegliarla.
Intorno alle leggi si cementa la sovrastruttura giudiziaria, un solido
pilastro del potere politico. Così, il recluso, non potendo in quella fase
congiunturale essere utilizzato come forza-lavoro, viene adoperato per far
guadagnare altre persone: polizia, avvocati, giudici, cancellieri, medici,
amministratori, direttori di carceri ecc. Scontata la reclusione, in circostanze
economiche favorevoli l’ex recluso verrà assorbito dal ciclo produttivo,
altrimenti le pressanti necessità vitali lo riporteranno a «delinquere» e
quindi di nuovo in carcere.
In epoca di sviluppo industriale la reclusione era, dunque, più economica
del supplizio.
Naturalmente niente nella storia è schematico come, inevitabilmente,
certe brevi descrizioni. Un’ombra suppliziatoria nei meccanismi della pena
non era e non è ancora esorcizzata: le botte, le catene, gli schiavettoni,{1} i
letti di forza, l’astinenza sessuale, l’isolamento sono mezzi di uso
quotidiano; e tuttavia la linea di forza del sistema punitivo in epoca
capitalistica lo porta ad essere un filtro regolatore del surplus di
manodopera.
Dall’inizio del secolo scorso, dunque, l’internamento istituzionalizzato è
il parcheggio di una gran parte dell’esercito industriale di riserva
(attualmente l’85% degli internati è composto da disoccupati, sottoccupati,
occupati precari o lavoratori dipendenti degli strati inferiori) e funziona da
valvola di controllo della manodopera.
Durante le depressioni del ciclo economico, il carcere assorbe
disoccupati e protegge la società contro agitazioni e rivolte; quando la
congiuntura è favorevole le carceri si vuotano e forniscono nuova
manodopera rallentando la spinta inflazionistica. E, infine, nei periodi di
salita e di discesa della curva ciclica esso funziona rispettivamente da freno
o da acceleratore, contribuendo a bilanciare l’occupazione. Le statistiche
del ministero di Grazia e Giustizia confermano questa ipotesi.
Nel corso del suo sviluppo la società borghese doveva progressivamente
articolare la realtà dell’internamento in modo selettivo, dividendo i
«condannati normali» dai «condannati matti»; questa distinzione
corrispondeva alla diversità del ruolo produttivo previsto per le due
categorie, da un lato, e, dall’altro, ad una maggior omogeneità ed efficienza
del sistema penitenziario che andava rapidamente estendendosi dappertutto.
Anche in Italia questa specializzazione portò a distinguere, con la legge
Giolitti del 1904 e col codice Zanardelli, fra reclusione e internamento, fra
«repressione» e «cura», fra delinquenti, folli e folli-delinquenti.
A quel periodo dobbiamo i primi cinque manicomi giudiziari del nostro
paese.
Ma l’istituzione detentiva aveva bisogno di un supporto ideologico che
la giustificasse.
Dalla fine del secolo scorso si erano già sviluppate in Italia due scuole di
dottrina penale, la classica e la positiva.
La prima vedeva nella pena un risarcimento che il colpevole pagava alla
società per averla offesa violando le sue leggi e la intendeva come vendetta
e afflizione; la seconda interpretava la pena come isolamento e rieducazione
del condannato a difesa della società, per cui sollecitava l’elaborazione di
misure diverse dalla pena tradizionale e che, come scrive il giudice
Accattatis, «con terminologia attuale potrebbero essere dette misure di
sicurezza».{2}
Queste due scuole (dette anche della retribuzione e della difesa sociale)
si contrapponevano frontalmente senza possibilità di compromesso, posto
che partivano da presupposti ideologici inconciliabili: i «classici» dalla
libera scelta dell’individuo, i «positivi» dallo stato di necessità.
Nel codice Zanardelli prevalse l’impostazione classica della pena, ma
una specie di misura di sicurezza si applicava in presenza di malattia
mentale.
Infatti, nel caso di seminfermità mentale, il giudice diminuiva la pena,
che poteva essere scontata, a discrezione del magistrato, in un manicomio.
Il totalmente infermo di mente non era punibile, tuttavia il giudice, quando
lo avesse valutato pericoloso, lo faceva internare in manicomio, che poteva
anche essere, ma non in via esclusiva, un manicomio giudiziario.
Nel codice Zanardelli erano quindi presenti sia la pena, sia un embrione
di misura di sicurezza, applicabili alternativamente a casi diversi.
Per quanto invece riguarda la distinzione fra manicomio civile e
giudiziario, la legge Giolitti del 1904 «sui manicomi e gli alienati» (che
ancora oggi regola sostanzialmente gli ospedali psichiatrici) lasciò
inalterata una certa confusione di competenze, mantenendoli in vita tutti e
due. L’orientamento che era però prevalso, nel corso del dibattito
parlamentare sulla legge, era stato favorevole alla loro confluenza in un
unico ordinamento in base alla convinzione che, in presenza di malattia
mentale, non avesse senso distinguere fra colpevoli e innocenti.
Questo equilibrio si mantenne per vent’anni, fino a che le maggiori
necessità repressive, politiche, oltre che economiche, dello Stato fascista e
dello sviluppo capitalistico consigliarono al ministro guardasigilli Rocco di
trasformare il sistema della pena, offrendo all’Italia, nel 1931, un nuovo
codice penale, il suo coerente regolamento penitenziario e il Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza, tutti e tre ancora felicemente vigenti.
2. L’attuale ordinamento fascista
Il codice Rocco riesce paradossalmente a fondere nel segno della
repressione la scuola classica e la scuola positiva, accogliendo nel sistema
punitivo sia la pena sia la misura di sicurezza, applicabili allo stesso
soggetto per lo stesso reato.
La restrizione della libertà personale è divisa nel codice fascista in tre
parti: pena , misure di sicurezza (dopo il reato), misure preventive (prima
del reato). Ma la novità è che mentre prima il giudice applicava o la pena
(agli imputabili) o la misura di sicurezza (ai non imputabili), col codice
Rocco può infliggerle insieme.
Questo sistema, che ci valse allora l’incredula stupefazione della scienza
straniera, viene definito a «doppio binario» perché, nello stesso caso, la
pena colpisce il reato e la misura di sicurezza la personalità.
Si tratta invece di un sistema a triplo binario (quasi una stazione
ferroviaria), posto che esistono anche le «misure preventive» contro i reati
non ancora commessi.
In questo modo il codice Rocco arrivava a coprire tutto l’arco delle
possibilità; mentre il proletariato occupato attendeva alacremente alla
costruzione dell’impero, il proletariato inoccupato e marginale, il
sottoproletariato e gli oppositori politici cadevano di volta in volta, a
seconda delle circostanze, in una delle tre possibilità.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
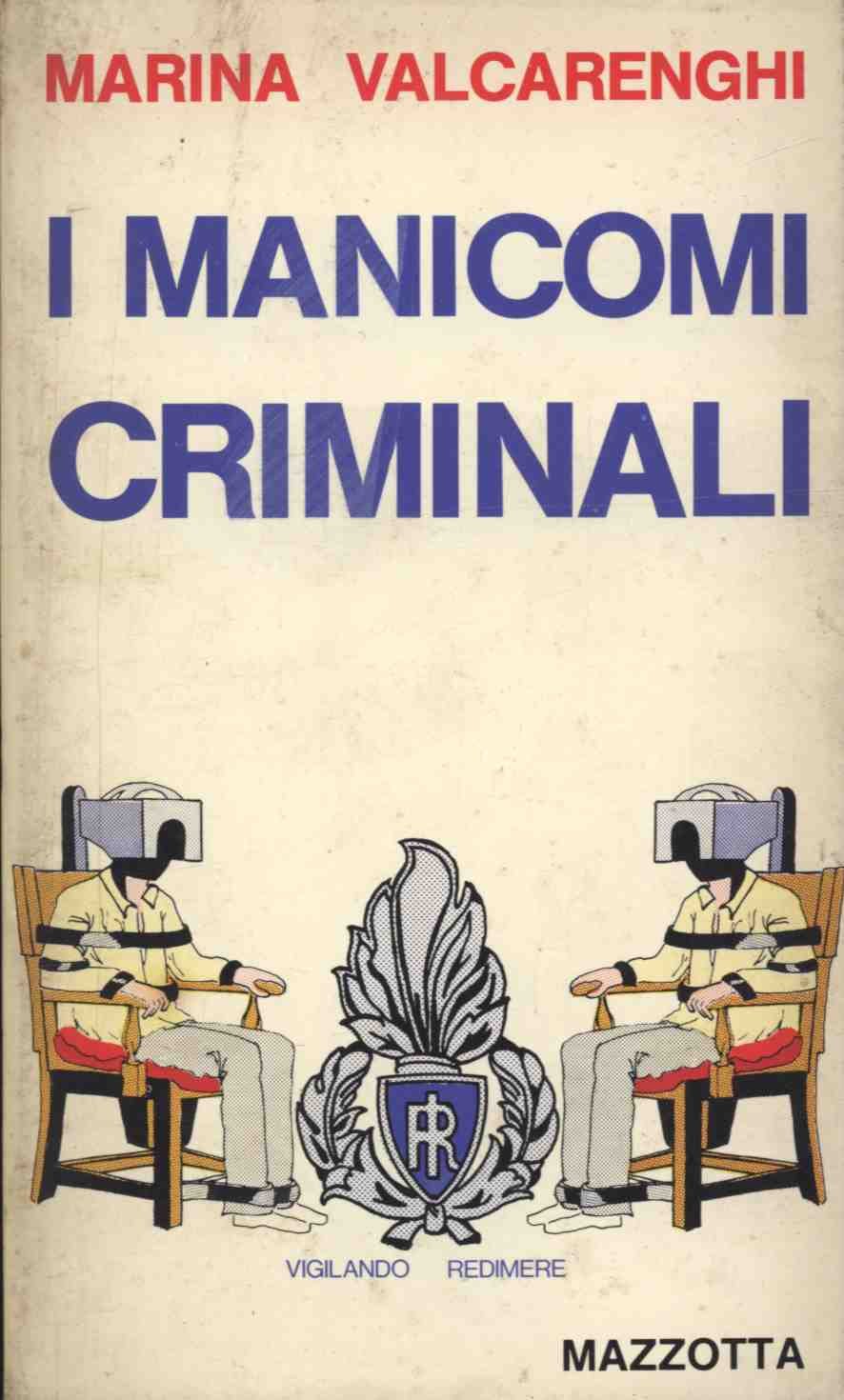






Commento all'articolo