Esercizi spirituali e filosofia antica – Pierre Hadot
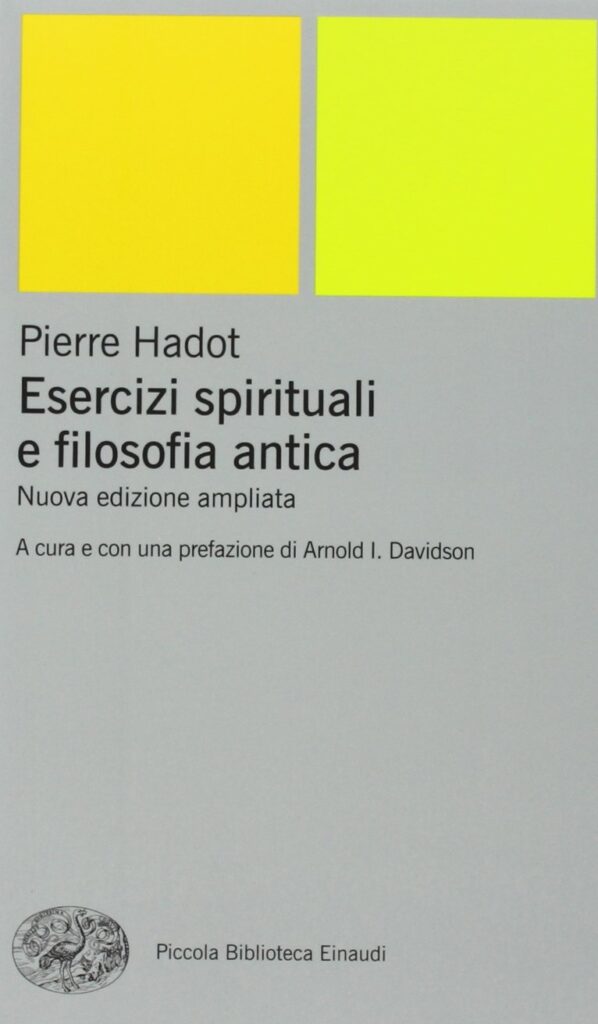
SINTESI DEL LIBRO:
La storia del pensiero ellenistico e romano
«Signor Amministratore,
cari colleghi,
signore e signori,
ognuno di voi si aspetta da me due cose, in occasione di questa
lezione inaugurale: in primo luogo che io ringrazi coloro grazie a cui
sono potuto venire qui, poi che faccia un’esposizione del metodo che
seguirò per assolvere al compito che mi è stato affidato». Questo è il
senso delle prime parole della lezione inaugurale pronunciata in
latino, il 24 agosto 1551, da Pietro Ramo, titolare della cattedra di
retorica e di filosofia al College Royal, dunque solo una ventina
d’anni dopo la fondazione di questo istituto. Come si può vedere,
oltre quattro secoli fa erano già fissati l’uso di tale lezione, ma anche
i suoi principali temi. E a mia volta oggi resterò fedele a questa
venerabile tradizione.
Già più di un anno fa, cari colleghi, avete deciso di creare una
cattedra di Storia del pensiero ellenistico e romano, e, un po’ più
tardi, mi avete fatto l’onore di affidarmene l’incarico. Come dirvi, in
una maniera che non sia maldestra e superficiale, la profondità della
mia gratitudine e della mia gioia di fronte alla fiducia che mi avete
testimoniata?
Credo di poter scoprire, nella vostra decisione, un tratto di quella
libertà, di quell’indipendenza di spirito che caratterizzano
tradizionalmente la grande istituzione in cui mi avete ammesso.
Infatti, per attirare la vostra scelta, avevo poche di quelle qualità che
permettono abitualmente di farsi notare, e la disciplina che
rappresentavo non era una di quelle che sono attualmente di moda.
In certo qual modo ero un «homo nouus», come dicevano i romani,
poiché non appartenevo a quell’aristocrazia intellettuale di cui uno
dei principali titoli è tradizionalmente quello di ex allievo dell’École
Normale Supérieure. D’altronde, come avete certamente notato
durante le visite da me fattevi, non ho quell’autorità tranquilla che
conferiscono l’uso e il dominio degli idiomi che si parlano
attualmente nella Repubblica delle Lettere. Il mio linguaggio — lo
constaterete ancora oggi — non si fregia di quel manierismo che
sembra essere attualmente di rigore, quando ci si azzarda a parlare
di scienze umane. Eppure parecchi di voi mi hanno incoraggiato a
presentare la mia candidatura, e, nel corso delle visite tradizionali
che costituirono per me un grande arricchimento, fui estremamente
commosso per aver incontrato grande simpatia e interesse,
specialmente tra gli specialisti di scienze esatte, per il campo di
ricerca di cui mi assumevo la difesa davanti a voi. In altri termini,
credo di non avervi dovuto convincere poiché eravate già persuasi
della necessità di assicurare al College un insegnamento e una
ricerca che tenessero strettamente legati orientamenti che troppo
spesso sono artificialmente scissi: il latino e il greco, la filologia e la
filosofia, l’ellenismo e il cristianesimo. Sono stato così sorpreso di
scoprire che alla fine di questo secolo XX, quando molti di voi usano
quotidianamente procedimenti tecnici, modi di ragionamento,
rappresentazioni dell’universo di una complessità quasi sovrumana,
che aprono all’uomo un futuro che non può neanche concepire,
l’ideale umanistico che ispirò la fondazione del Collège de France
conservava sempre tra voi, in una forma certo più cosciente, più
critica, ma anche più ampia, più intensa, più profonda, tutto il suo
valore e il suo significato.
Ho parlato di uno stretto legame fra greco e latino, filologia e
filosofia, ellenismo e cristianesimo. Credo che questa formula
corrisponda esattamente all’ispirazione dell’insegnamento di Pierre
Courcelle a cui succedo, se così posso dire, in linea indiretta, con la
mediazione dell’ufficio amministrativo di R. Stein che fu mio collega
alla V sezione dell’École Pratique des Hautes Etudes e a cui tengo a
rendere omaggio in questo giorno. Credo che, questa sera, Pierre
Courcelle, che ci è stato così brutalmente strappato, sia
intensamente presente nel cuore di molti di noi. Per me fu un
maestro che mi ha molto insegnato, ma anche un amico che mi
dimostrò grande sollecitudine e attenzione. Ora posso solo parlare
dello studioso, per rievocare quest’opera immensa, composta di libri
grandissimi, di innumerevoli articoli, di centinaia di recensioni. Non
so se la portata di questa fatica titanica sia stata sufficientemente
stimata. Le prime righe della sua grande opera Les Lettres grecques
en Occident de Macrobe à Cassiodore sottolineavano bene ciò che
l’orientamento della sua ricerca aveva di rivoluzionario per la sua
epoca. «Un grosso libro sulle lettere elleniche in Occidente dalla
morte di Teodosio alla riconquista giustiniana ha di che
sorprendere», scriveva Pierre Courcelle. La sorpresa era destata in
primo luogo dal fatto che un latinista si interessasse delle lettere
greche. Eppure, come notava P. Courcelle, sono queste lettere
greche ad avere consentito la fioritura della letteratura latina, ad
avere prodotto Cicerone, il tipo più compiuto della cultura grecoromana al suo apogeo, a essere state persino sul punto di sostituirsi
al latino, quando, nel secolo 11 d. C., fu eclissato dal greco come
lingua letteraria. Tuttavia occorre constatare e deplorare il fatto che,
nonostante l’iniziativa e l’esempio di P. Courcelle, a causa di un
pregiudizio che non è interamente superato e che è legato alla
disastrosa scissione che la ricerca francese stabilisce fra il greco e il
latino, ciò che diceva P. Courcelle nel 1943, ossia quarant’anni fa,
resti disgraziatamente vero anche oggi: «Non conosco un lavoro
d’insieme che studi l’influenza greca sul pensiero o sulla cultura
romana dell’Impero».
Sorprendente era inoltre vedere un latinista che dedicava uno
studio tanto importante a un’epoca tarda, e che mostrava come nei
secoli V e VI, in un periodo di pretesa decadenza, le lettere greche
avessero conosciuto una rinascita notevole che, grazie ad Agostino,
Macrobio, Boezio, Marziano Capella e Cassiodoro, doveva
permettere al Medioevo occidentale di conservare i contatti col
pensiero greco, finché le traduzioni arabe non gli avrebbero
permesso di ritrovarlo in fonti più ricche. Sorprendente era ancora
vedere un filologo affrontare problemi di storia della filosofia,
mostrando l’influenza fondamentale esercitata sul pensiero latino
cristiano dal neoplatonismo greco e pagano, e — precisazione
importante — non tanto da Plotino quanto dal suo discepolo Porfirio.
Nuova sorpresa: questo filologo determinava i suoi risultati con un
metodo rigorosamente filologico. Voglio dire che non si accontentava
di scoprire vaghe analogie fra le dottrine neoplatoniche e cristiane, di
valutare in una maniera puramente soggettiva le influenze o le
originalità, insomma di affidarsi alla retorica e all’ispirazione per
trarre le sue conclusioni. No, seguendo l’esempio di Paul Henry, il
dotto editore di Plotino che è stato parimenti per me un modello di
metodo scientifico, P. Courcelle confrontava i testi. Scopriva ciò che
tutti avrebbero potuto vedere ma che nessuno aveva visto prima di
lui: come un certo testo di Ambrogio fosse tradotto letteralmente da
Plotino, come un certo testo di Boezio fosse letteralmente tradotto
da un commentatore greco neoplatonico di Aristotele. Tale metodo
permetteva di stabilire fatti indiscutibili, di liberare la storia del
pensiero dalle sue approssimazioni, da quella nebulosità artistica
dove tendevano a relegarla certi storici, anche contemporanei di P.
Courcelle.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
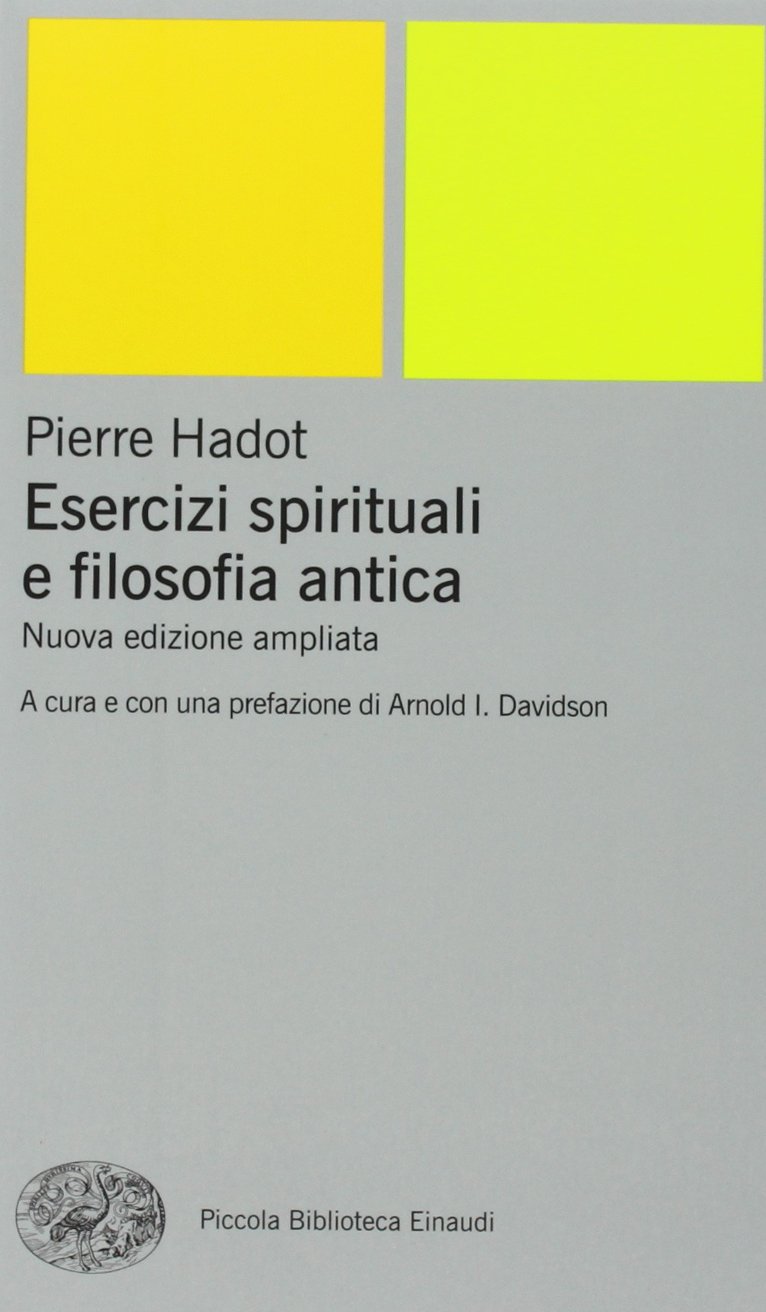






Commento all'articolo