Critica della vittima. Un esperimento con l’etica – Daniele Giglioli
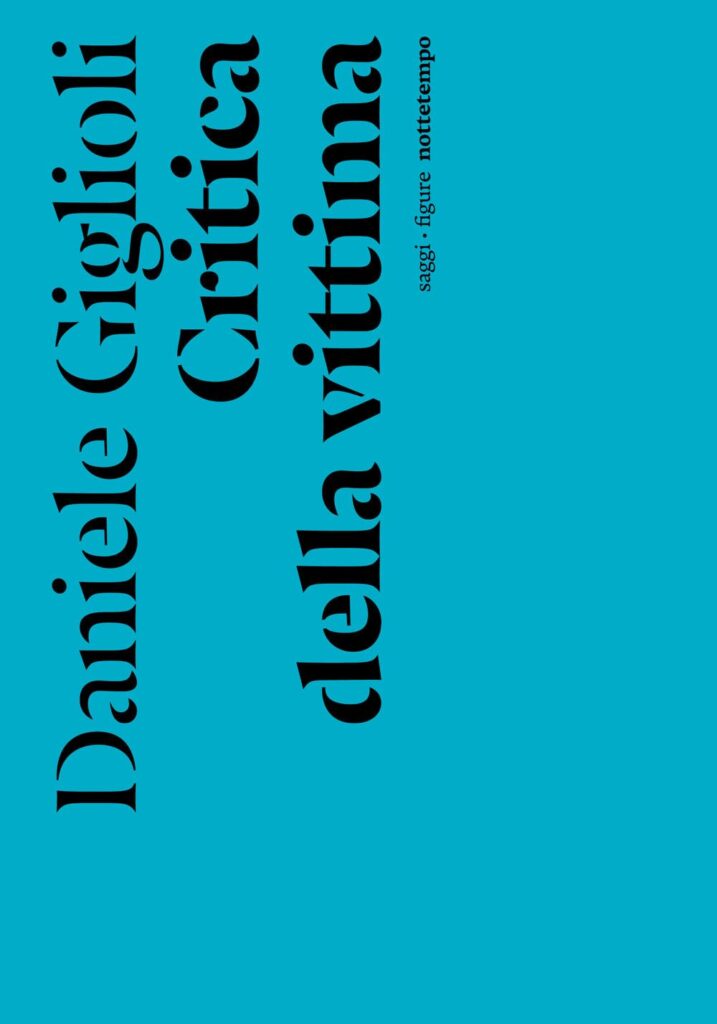
SINTESI DEL LIBRO:
Tracciamo per prima cosa una sintomatologia del fenomeno, per poi
cercare di rinvenirne se non l’origine l’avvio, con un’ipotesi sulle sue
cause probabili, e di stilarne infine la critica propriamente detta: cosa
promette e soprattutto cosa toglie, impedisce, rende impossibile; e
perché; e cosa forse tornerebbe possibile a critica avvenuta. Le sue
manifestazioni sono infinite da qualunque campo le si convochi,
politica e cronaca, costume e letteratura, storia e filosofia, diritto e
psicologia, e non ha senso prefiggersi alcuna pretesa di
completezza: “Gli ingenui”, ha scritto una volta Marcel Proust,
pensano che le vaste dimensioni dei fenomeni sociali ci aiutino a penetrare piú a fondo
nell’animo umano: dovrebbero, al contrario, rendersi conto che solo addentrandosi in una
singola individualità avrebbero modo di capire quei fenomeni.
Commenteremo di scorcio un ristretto numero di esempi,
scommettendo sul valore di illuminazione reciproca del loro
accostamento, si spera imprevisto ma non arbitrario. L’analogia, piú
che l’analisi esaustiva, ci farà da bussola.
Remember me!
In primo luogo la memoria, l’ossessione della memoria. Il dovere,
addirittura, della memoria, un termine che nel nostro spirito pubblico
aspira a spodestare, come ha notato Enzo Traverso, il suo
gemello/antagonista storia. Rispetto alla storia, la memoria è
soggettiva, intima, vissuta, non negoziabile, autentica se non vera a
prescindere: assoluta proprio perché relativa. Configura un rapporto
col passato di tipo inevitabilmente proprietario: il mio, il nostro
passato. La memoria non si scrive senza pronomi e aggettivi
personali. Al suo centro, il testimone; e testimone per eccellenza è
oggi chi reca inscritto in sé, nel corpo prima ancora che nella mente,
il peso dei processi da cui è stato affetto: la vittima, dunque. Vera
protagonista del passato è la soggettività sofferente, cui le istituzioni
attribuiscono volentieri il crisma dell’eticità di Stato, istituendola a
oggetto di celebrazione pubblica avente forza di legge: il “Giorno
della Memoria” (27 gennaio, commemorazione delle vittime della
Shoah); il “Giorno del Ricordo” (10 febbraio, in onore delle vittime
delle foibe); la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie” (21 marzo); il “Giorno della Memoria
dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle
stragi di tale matrice” (9 maggio, anniversario dell’omicidio di Aldo
Moro).
Sinistro cortocircuito, che isola gli eventi dalla catena del loro
accadere, li ipostatizza in valori invece di spiegarli come fatti, e in tal
modo invalida anche il proposito di elevarli a monito perché ciò che è
accaduto non accada di nuovo: non chi non ricorda, ma chi non
capisce il passato è condannato a ripeterlo. Passaggio illecito di
testimone, che onora chi non può piú parlare occupando il suo
silenzio con la grancassa delle retoriche commemorative. La
memoria serve sempre ai vivi, il suo tempo vero è il presente; ma
che pensare di un presente che addita valori soltanto tramite lutti?
Conferendo loro, per di piú, un significato salvifico: se oggi siamo qui
è grazie a voi.
Nella prosopopea della vittima opera surrettiziamente una
sostituzione, una sovrapposizione tra tempi, punti di vista, soggetti
dell’enunciato e dell’enunciazione: il “noi” che si cementa e si
rafforza col dolore è e insieme non è – come nelle figure retoriche –
lo stesso che ha patito un tempo. Chi parla da vittima, o per la
vittima, è sempre nella situazione di chi parla al posto di qualcun
altro. Ciò è ovvio quando qualcuno prende la parola in nome di
vittime silenti. Ma paradossalmente vero è anche nel caso della
vittima che parla per sé, in quanto la vittima è tale in primo luogo
perché costretta a tacere, inascoltata, privata del potere del
linguaggio. Parlare è la prima forma di agency. La vittima è l’in-fante.
I nazisti lo sapevano: se lo racconterete, nessuno vi crederà. Ma un
imperativo di ascolto stabilito per legge, oltre a trapiantare la logica
giudiziaria al centro della vita pubblica (il processo è di per sé il solo
luogo dove il diritto al discorso delle vittime è legittimamente
obbligatorio, pur restando quello della vittima un discorso di parte),
indica che si è passati su un altro piano. Salite alla tribuna, anche le
vittime piú vere diventano rappresentanti di se stesse: siamo qui per
il noi, per il voi che siamo stati, proprietari della vita di un altro.
La pietà ingiusta
Ma “siamo qui per voi” è anche l’enunciato matrice di tutta quella
vasta galassia ideologica che Philippe Mesnard ha sostantivato nel
termine “l’umanitario”. Sotto le spoglie di una morale universale, a
basso costo e alta spendibilità perché non problematica, il credo
umanitario è piuttosto una tecnica, un insieme di dispositivi che
disciplinano il trattamento delle parole, delle immagini sapientemente
articolate in icone e didascalie, delle reazioni emotive ingiunte agli
spettatori: estetizzazione kitsch, sensazionalismo riduttivo,
naturalizzazione vittimaria di intere popolazioni. Che abbia fornito la
prima fonte di legittimità a quasi tutte le ultime guerre è un’evidenza,
dalla Somalia alla ex Jugoslavia, dall’Afghanistan all’Iraq,
sovrapponendo all’immagine corrusca del guerriero le figure piú
rassicuranti del poliziotto, del medico, del vivandiere.
Ma non è questo il suo scandalo, cosí come è altrettanto a basso
costo l’indignazione reattiva che pure insorge spontanea quando,
non appena da qualche parte al mondo si soffre, si fanno innanzi
immancabili personaggi come BHL, al secolo Bernard-Henri Lévy, il
piú esposto e servizievole di quei nouveaux philosophes che
scoprirono e denunciarono – a fine anni ’70! – l’orrore del
totalitarismo (si vede che Orwell era arrivato in ritardo nei Livres de
Poche, commentò all’epoca Umberto Eco); e come lui molti altri. La
mera denuncia della manipolazione non fa mai molta strada: se
l’inquadramento ideologico può essere falso, la materia inquadrata è
purtroppo in genere vera. Al mondo non si soffre per finta, e non
saranno mai abbastanza i distinguo.
Ma c’è pietà e pietà. Piú significativo è infatti ciò che questo
inquadramento opera sulle vittime stesse, stigmatizzandole in
un’identità “che le spoglia del tutto o in parte”, scrive ancora
Mesnard, “della loro biografia e dei loro riferimenti culturali, oppure
ve le rinchiude”, privandole di soggettività nonché di ogni diritto che
non sia quello al soccorso (con quali esiti pratici bisognerebbe poi
vedere). Rimpicciolite a ciò che gli è stato fatto, hanno lacrime ma
non hanno ragioni. La loro voce, come quella degli animali, serve
soltanto a esprimere piacere e soprattutto dolore, non a deliberare in
comune sul giusto e sull’ingiusto, prerogativa che secondo Aristotele
distingue la specie umana dalle altre in quanto dotata di logos e di
società. La loro verità è nello sguardo dell’altro, il clemente, il
misericordioso. Medici e reporter senza frontiere, ONG, rockstar chi
in auge e chi in disarmo, spesso in ambigua e nella migliore delle
ipotesi ingenua collaborazione con potentati locali o con eserciti
invasori, sono i soli davvero accreditati a parlare, gli unici, osserva
Didier Fassin, “testimoni legittimi che parlano in nome di chi ha fatto
esperienza di eventi traumatici”: “La prolissità del racconto
umanitario aumenta parallelamente al silenzio dei sopravvissuti”.
In apparenza fraterno, il credo umanitario è un sentire sovrano che
rende suddito tutto ciò che tocca: un campo di rifugiati, afferma
candidamente il manager di un’organizzazione umanitaria, “non ha
bisogno di democrazia per sopravvivere”. Sovranità senza politica,
che inizierebbe invece laddove, piuttosto che con le vittime, si
solidarizzasse per esempio con gli sfruttati, gli oppressi, gli esclusi
con cui potremmo avere degli interessi (un logos, una praxis) in
comune: tutti enunciati che implicano un giudizio, giusto o sbagliato
non importa, e non una semplice scarica emotiva. Commozione a
comando, sovrapposizione adialettica tra sentimento e interesse, il
credo umanitario mantiene inermi i disarmati (che cos’altro è
successo a Srebrenica?) e lascia intatti gli arsenali dei forti, in
perfetta armonia tra risultati e intenzioni – quelle profonde, se non
quelle vere. “Umano sei, non giusto”, replicava stizzito l’abate Parini
a un tale che lo compativa, e gli consigliava di farsi servoSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
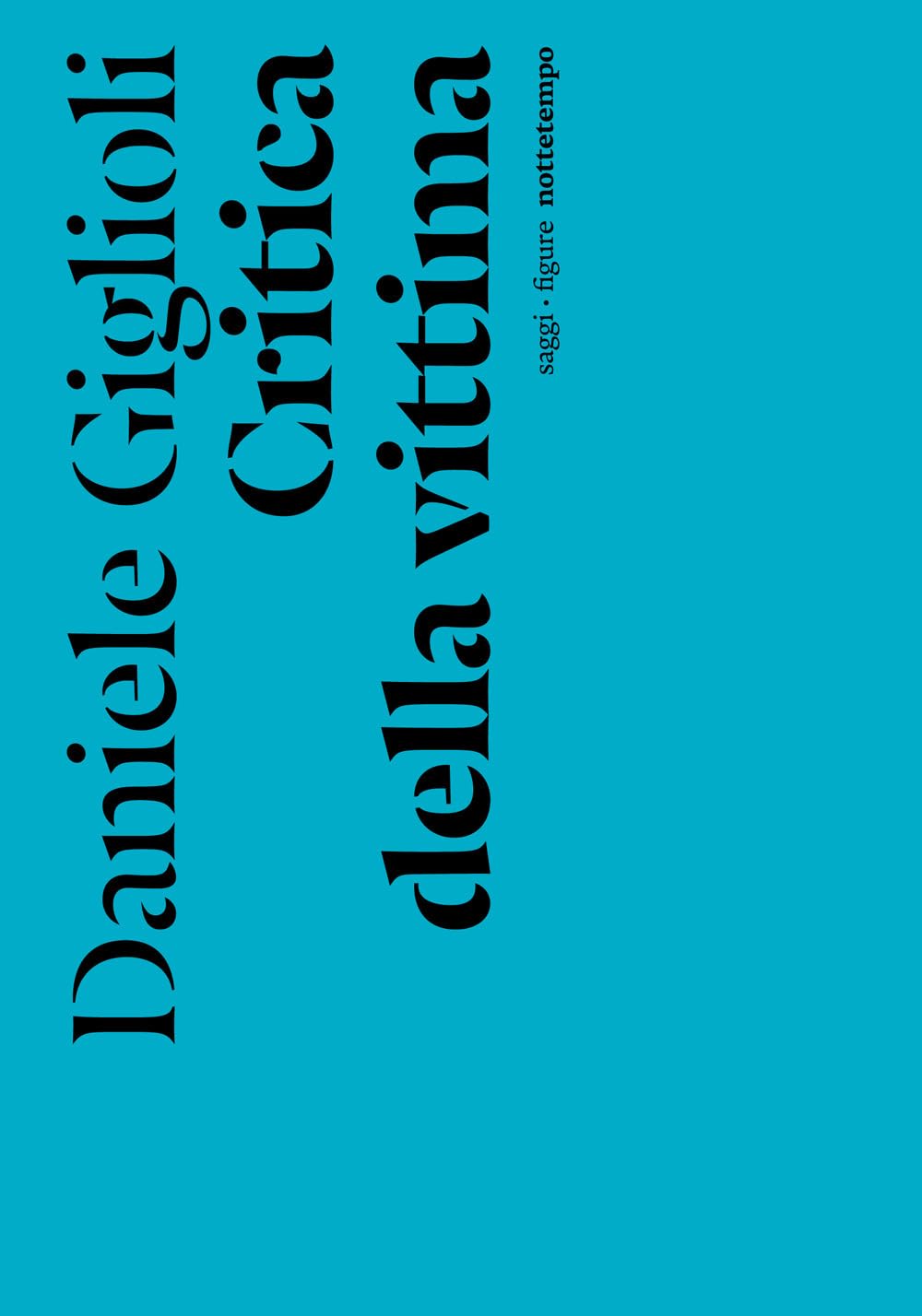






Commento all'articolo