Capire la musica classica. Ragionando da compositori – Nicola Campogrande
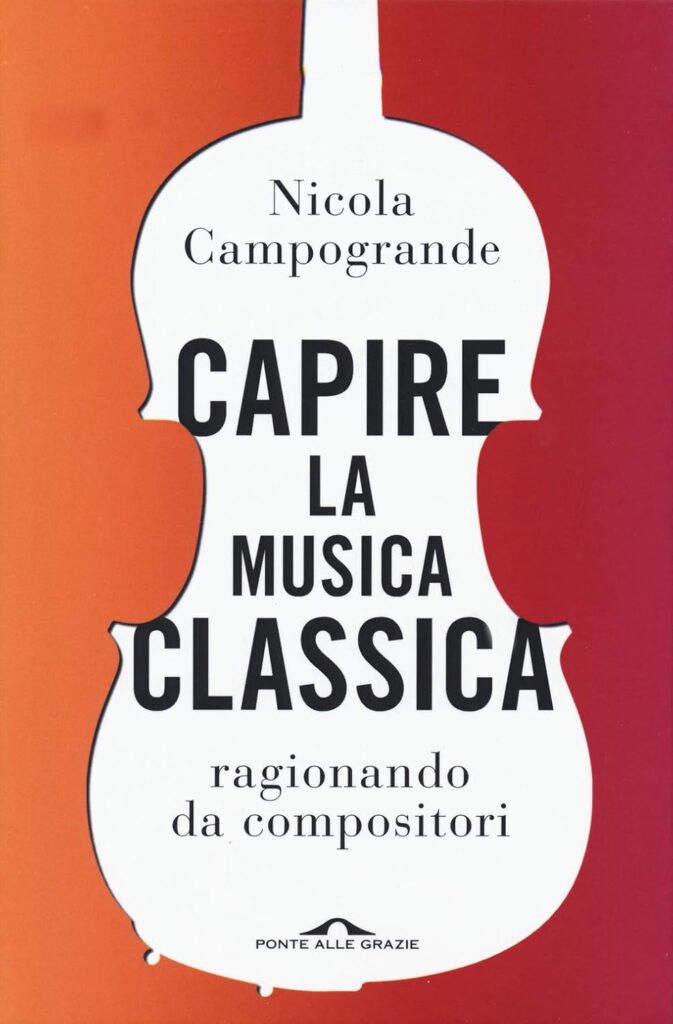
SINTESI DEL LIBRO:
La cosa da decidere, quando vi mettete a scrivere un pezzo di
musica classica, è la sua velocità. Non è un caso che il primo segno
al quale andranno incontro gli occhi dei vostri interpreti sarà
un’espressione, in italiano, che serve a indicarla: le parole Largo,
Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto e così via, che da secoli
compaiono in alto a sinistra sulle partitura, hanno questo scopo.
Perché la velocità stabilirà il carattere del brano, il modo nel quale
entrerà in contatto con le orecchie e con il cuore, per certi versi il suo
senso. E peraltro, una volta deciso se il vostro pezzo sarà lento o
veloce, saprete come sfruttare al meglio gli strumenti per i quali state
componendo: per capirci, è inutile scrivere dozzine di note
brevissime che risultano poi impossibili da suonare in un tempo
veloce; ed è altrettanto vano scrivere note lunghissime, se il tempo è
molto lento, visto che a un certo punto un flauto o una tromba
dovranno comunque prendere fiato, il suono di un pianoforte andrà a
estinguersi, un violino o un violoncello saranno obbligati a cambiare
la direzione dell’arco, spezzando la nota, così che ciò che avevate
previsto si rivelerà tecnicamente infattibile.
Sappiate però che la velocità del vostro brano cambierà, da
esecuzione a esecuzione, da sala a sala, da interprete a interprete.
E voi stessi, durante i mesi che impiegherete per comporre –
raramente si cava qualcosa di buono in poche settimane – avrete
opinioni diverse. Probabilmente partirete con le idee molto chiare,
cercherete sul metronomo il valore numerico perfetto, il suo toc toc
sarà del tutto uguale alla pulsazione che desiderate per la partitura.
Ma poi, a tradimento, una mattina vi ritroverete a pensare che il
brano vada suonato più in fretta; e certe sere lo sentirete invece
terribilmente ansiogeno, tanto da chiedervi come mai abbiate fissato
un metronomo così rapido.
Non spaventatevi: fa parte del gioco. Quella della velocità è la
variazione più frequente nella musica, sin dalla costruzione della
partitura; e, quando poi il pezzo sarà finito e comincerà a circolare, la
sua impercettibile variazione, per tutto il brano o per alcune sezioni,
sarà un elemento importante nel rendere ogni interpretazione
potenzialmente unica.
Stabilita la velocità, con il suo meraviglioso ambito di sfumature –
quello della musica classica è un linguaggio raffinato e complesso,
non dimenticatelo – considerate che la musica attraversa il cervello,
certo, e gli regala idee, suggestioni, pensieri; ma si trasmette anche
al resto del corpo. Tanto da generare reazioni fisiche nei nostri arti
che la buona educazione ci impedisce di esplicitare in sala da
concerto ma che, davanti a un’orchestra, se fossimo soli, o molto
disinibiti, probabilmente lasceremmo scatenare.
Certo, non è solo la velocità a ordinarci come reagire. Il ritmo,
come leggerete tra un paio di pagine, gioca la sua parte. Ma intanto,
scegliendo quanto premere sul vostro acceleratore, sappiate che
potete ottenere effetti molto diversi.
Viaggiando a velocità elevata potete ad esempio indurre il corpo a
correre. Magari in modo scatenato come fa John Adams (*1947) nel
finale della sua Chamber Symphony, intitolato Roadrunner: è il nome
dell’uccello dei cartoni animati Warner che in Italia chiamiamo Beep
Beep, perennemente in fuga davanti al coyote che lo insegue.
Adams ha raccontato che stava studiando la serissima
Kammersymphonie op. 9 di Schönberg mentre, nella stanza
accanto, suo figlio guardava la tv; e nella sua testa tutto si è
mescolato, suggerendogli l’idea di questa pagina vorticosa, molto
virtuosistica per gli interpreti, che è difficile ascoltare senza aver
voglia di muoversi.
Oppure, al contrario, potete comporre un pezzo che dica al nostro
corpo di rallentare, di calmarsi. L’Ave Verum Corpus di Mozart,
nonostante la bellezza conturbante della sua melodia, la tensione
delle armonie, l’empatia richiamata dalle voci del coro, ha una
lentezza tale che il tutto arriva alle orecchie, e al cuore, quasi al
rallentatore, e l’emozione ci raggiunge con il contagocce. Quella
stessa musica, più rapida, sarebbe davvero altra cosa. Cambierebbe
di significato.
La prima lezione, dunque, è: prendetevi il tempo per farlo, ma
ragionate con cura sulla velocità del vostro brano. Ne vale la pena.
Ritmo
Avete fatto i vostri esperimenti con la velocità, giocando con
l’acceleratore e spingendo gli ascoltatori a correre o a rallentare. Ora
è il momento di andare più a fondo e imparare a gestire il ritmo della
vostra partitura, il suo cuore, il suo pulsare.
Perché la musica organizza il tempo, dividendolo in parti, come fa
un orologio – su questo non ci sono dubbi. Ma è il modo nel quale lo
divide, lo separa in pezzetti, a fare la differenza. Un orologio
scandisce minuti e secondi in parti uguali; la musica no. Meglio:
presuppone che sotto scorra un tempo costante, e però con questa
costanza gioca, e talora la asseconda, talaltra la inganna. Per voi
costruire un ritmo significherà scegliere una collocazione nel tempo
e una durata per ogni nota, per ogni pausa che scriverete sul
pentagramma – arriveranno all’inizio della battuta, o a metà, o poco
prima, o poco più in là, e saranno lunghe un trentaduesimo, un
ottavo, un quarto, un mezzo e così via; per le orecchie lo specifico
ritmo che andrete a costruire si rivelerà il motore, la spinta, la scossa
con la quale ogni istante di musica giungerà a destinazione.
Prendete ad esempio il Preludio n. 1 dal Primo Libro del
Clavicembalo ben temperato di Bach. È una pagina incredibilmente
regolare, come un metronomo. Potrebbe quasi fare toc toc, tanto il
ritmo, la scansione delle note, sono squadrati, perfetti, imperturbabili.
Eppure, badate, è musica molto lontana dall’assomigliare a un
orologio. Perché mentre scorre il ritmo piccolo, rapido, delle singole
note, tara tara tara tara, Bach gioca con l’armonia, con gli accordi,
che una volta per battuta aprono e chiudono, si complicano e si
semplificano, domandano e rispondono. Lo fanno con un loro ritmo
ulteriore, più lento, perché si tratta di armonie che rimangono ferme
per molte note, e questa stratificazione, questa sovrapposizione di
un ritmo lento sopra uno veloce, nella sua semplicità risulta
efficacissima, e meravigliosaSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
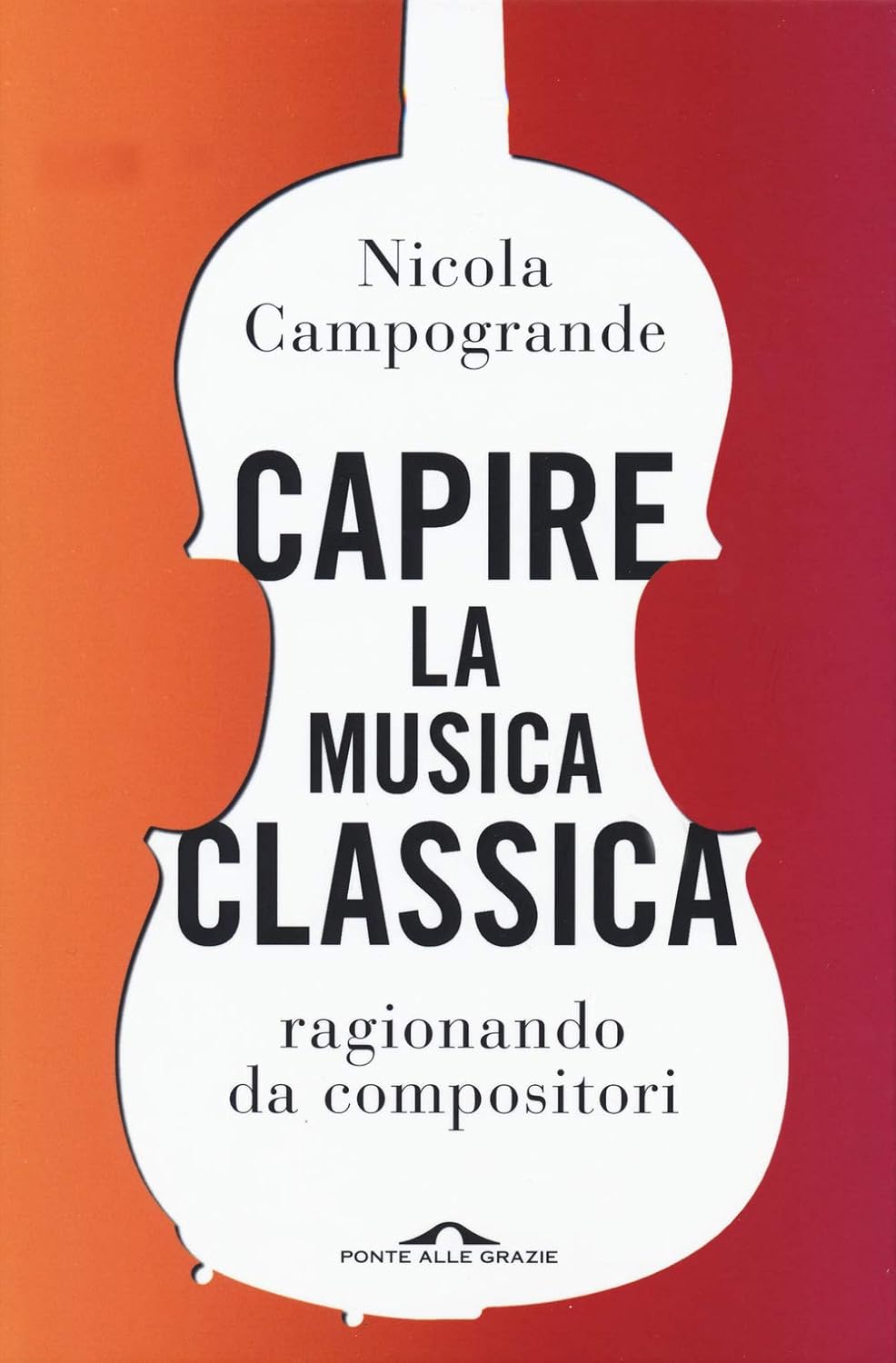






Commento all'articolo