Acqua santissima. La Chiesa e la ‘ndrangheta: storia di potere, silenzi e assoluzioni – Nicola Gratteri
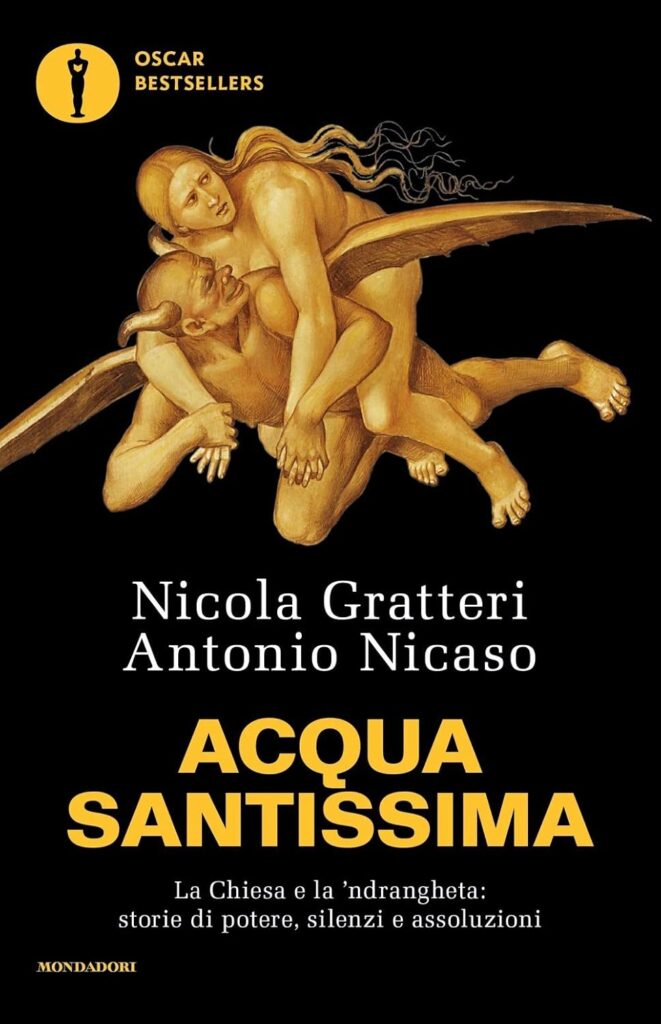
SINTESI DEL LIBRO:
La Madonna della Montagna ha «due occhi bianchi e neri, fissi,
che guardano da tutte le parti».1 La statua, costruita in pietra di tufo,
è custodita in un santuario nascosto tra i dirupi dell'Aspromonte, in
una gola bagnata da due fiumi, una zona boschiva, piena di laghetti,
felci, ginestre, in cui crescono il castagno, il pino, la quercia, il
nocchio, il frassino e l'abete. Racconta Edward Lear, scrittore ed
illustratore inglese che visita la Calabria nel 1847:
Senza dubbio, Santa Maria di Polsi è una delle più notevoli scene
che io abbia mai visto; l'edificio è pittoresco, ma non molto antico, e
senza pretese di gusto architettonico, ed è situato in alto sopra il
grande torrente, che viene giù dalla vera cima dell'Aspromonte, la cui
alta vetta - Montalto è il tetto e la corona del paesaggio {...}. Nessun
altro posto, persino più remoto, fa intravedere un paesaggio di
maggiore contrasto persino con quelli in cui giacciono spesso i
solitari monasteri d'Italia, che dalla loro altezza e dal loro angolo
dominano o una distante pianura o il mare. Qui, invece, tutto
intorno, al di sopra e al di sotto, è chiuso da boschi e montagne -
nessuno sbocco, nessuna varietà - soltanto la solitudine ed il senso
dell'eremitaggio regnano sovrani.2
Alla devozione di questa Madonna è legato uno dei pellegrinaggi
più antichi di tutto il Sud d'Italia. Secondo la leggenda, nel luogo
dove oggi sorge l'altare maggiore, nell'XI o XII secolo sarebbe stata
rinvenuta una strana croce di ferro, dissotterrata con le corna da un
torello. C'è chi dice che a trovarla fu un pastorello di Santa Cristina
d'Aspromonte e chi, invece, i levrieri del conte Ruggero, durante una
battuta di caccia. Da allora, migliaia di persone venerano la Madonna
della Montagna, che viene portata in processione ogni anno, nel terzo
giorno di settembre.
«Hanno il privilegio di portatori gli uomini di Bagnara, gente di
mare, audaci e ricchi migratori, pescatori accaniti di pescespada e di
tonni» scrive Corrado Alvaro, l'autore di Gente d'Aspromonte.
Sono loro i più abili a far correre, come se volasse, l'immagine
della Madonna sul suo pesante piedistallo, mentre le buttano intorno
grano, confetti, fiori; non si sente altro, tra lo sparo dei fucili {...} che
il battito di migliaia di pugni su migliaia di petti, un rombo di
umanità viva tra cui l'uomo più sgannato trema come davanti a
un'armonia più alta della mente umana. Le semplici donne che non
si sanno spiegare nulla, si stracciano il viso e non riescono neppure a
piangere.3
Le cose cambiano sensibilmente alla fine dell'Ottocento, quando
presso il monastero si cominciano a vedere uomini di 'ndrangheta.
Anni in cui centinaia di capre vengono arrostite nei prati vicini, in un
incendio di lumi e lampi di fucili favorito da una concessione
risalente al tempo dei Borbone che, tra arcaicità e tribalismo,
consente l'accesso al santuario anche agli uomini armati.4 L'uscita
della statua della Madonna, allora, veniva celebrata a colpi di fucile
esplosi per aria. Capitava, così, che al termine della festa, tra i boschi
venissero trovati i corpi di persone giustiziate per essere venute
meno alla consegna del silenzio o dell'onore.
Il sangue degli «infami» si mischiava a quello delle capre
scannate per santificare la festa.
Rocco D'Agostino, un commerciante di Santo Stefano
d'Aspromonte citato come teste al processo per l'omicidio di Pietro
Maviglia, ucciso ad Africo, racconta:
Il 3 settembre 1894 mentre mi trovavo a Polsi per la festa della
Madonna della Montagna vidi una sessantina di persone che,
disposte a ferro di cavallo, bevevano e mangiavano.
Tra loro ho riconosciuto Antonio Sergi di Condonili, il quale, al
rientro da Polsi, mi confidò che quella mangiata era stata organizzata
con i soldi delle estorsioni.5
Due anni dopo, Pasquale Trimboli, in un processo davanti al
tribunale di Palmi parla di decine di boss raccolti a cerchio formato,
un rituale della 'ndrangheta, proprio nelle vicinanze del santuario, in
occasione della festa della Madonna.
Le dichiarazioni di D'Agostino e Trimboli trovano conferma in un
rapporto inviato alla procura del Regno dal tenente dei carabinieri
reali di Reggio Calabria, Giuseppe Passarelli, il 17 agosto 1901:
L'ingresso nella società ha luogo ordinariamente il 3 settembre di
ogni anno alla festa della Madonna di Polsi d'Aspromonte, in
prossimità del convento, dove si radunano i principali capi delle
associazioni a delinquere dell'intera provincia e di quelle vicine. A
tutte le associazioni della provincia di Reggio Calabria presiede il
bandito Musolino Giuseppe {...} che in un giorno del settembre 1900
in quel di S. Eufemia d'Aspromonte venne proclamato dai vari capi
ivi convenuti «capo onorario di tutte le società».
Forse, si deve proprio a Musolino, reso celebre anche dalle
copertine della «Domenica del Corriere» e devotissimo alla Madonna
della Montagna, la decisione di organizzare a Polsi il raduno annuale
della 'ndrangheta, un luogo che, trovandosi al centro dei tre
mandamenti giudiziari della provincia di Reggio Calabria, da secoli
riveste una forte centralità geografica. In una lettera inviata ad un
boss di Africo e intercettata dai carabinieri nel 1899 si coglie «la
necessità morbosa negli associati di riunirsi alla "Madonna della
Montagna" {...} luogo di gara alle cortesie reciproche, convegno di
nuovi iniziati, baldoria e gavazzo a spese di questi, dei capi, dei
camorristi e di vecchi affiliati».6
In un racconto dal titolo Angelino, Corrado Alvaro ricostruisce la
storia di un giovane tornato in Calabria, dopo essere stato espulso
dalle Americhe come indesiderato.
Legato alla 'ndrangheta, Angelino è un uomo di rispetto, uno che
si può permettere di scortare il vescovo nelle sue visite pastorali in
segno d'onore, ma anche perché «la Società {a cui appartiene} è
religiosa e perché il territorio in cui opera è il luogo "dove si trova il
Santuario" della Madonna "dove si nomina il capo dell'Associazione
dai {...} capi dei tre versanti"».7
Sono gli anni della tregua. Massaru Peppi, il leggendario
maresciallo Giuseppe Delfino, stringe un accordo d'onore con don
Antonio Macrì, galantuomo dei galantuomini, e per oltre trent'anni
al santuario non succede alcun fatto di sangue, nonostante i chili di
polvere che vengono sparati sotto le querce come segno di
ringraziamento alla Madonna.
Col tempo, cresce anche la devozione dei boss per il santuario di
Polsi e l'interesse a proteggerlo. Nel 1936, il furto dell'oro votivo (6
chili abbondanti) conduce a morte i responsabili, mentre nel 1982 la
refurtiva, accompagnata anche dalle scuse, viene restituita due mesi
dopo. I soldi rubati, circa due milioni di lire, «vengono lasciati in un
incavo del muro dell'antistante piazzola che esiste davanti
all'ingresso principale della parrocchia».8 Pare che le famiglie più
potenti della 'ndrangheta si siano mobilitate per catturare e punire i
due malviventi.
La pretesa «intoccabilità» del santuario, comunque, prescinde
dalla 'ndrangheta. Si racconta che nel XVI secolo, durante l'inverno,
quando i monaci riparavano in luoghi meno freddi, la chiave della
chiesa veniva lasciata nella toppa per permetterne l'accesso ai
pellegrini di passaggio. Incustodito veniva lasciato anche un vaso
pieno di olio per consentire l'accensione dei lumi. Venuto a
conoscenza di questa consuetudine, pare che un pastore di San Luca
abbia cercato di rubare l'olio dalla chiesa, rimanendo prima colpito
dallo sguardo della Madonna che «volgea gli occhi e la faccia
ovunque egli si portava» e poi sommerso da una marea di sostanza
liquida caduta dal soffitto, come se piovesse.9
Finisce male anche il tentativo di spostare da Polsi l'annuale
summit della 'ndrangheta. L'11 settembre 1960 don Mico Trípodo,
boss di Sambatello, allora latitante, chiama a raccolta i capibastone
del Reggino, prima nel bosco di Gambarie e, poi, all'ultimo
momento, in una casa di campagna nei pressi del ponte di Calanna,
lungo la statale 184.
Non sono tutti d'accordo con questa decisione. I clan della
Locride non si presentano. Arrivano invece gli uomini della questura
di Reggio Calabria che procedono al fermo di diciassette persone,
residenti a Fiumara di Muro, Seminara, Sant'Eufemia d'Aspromonte,
Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Scilla e Castellace di Oppido
Mamertina. Scrive il dirigente della squadra mobile Alberto
Sabatino:
{Ci} giunse una vaga indicazione circa la data in cui si sarebbe
effettuata una di queste riunioni. Furono disposti adeguati servizi ma
non fu possibile sorprendere i mafiosi sul fatto bensì soltanto alcuni
di loro mentre con una decina di macchine transitavano sulla strada
che da Gambarie porta a Gallico.10
Ancora più esplicito è Filippo Barreca, oggi collaboratore di
giustizia. Nelle dichiarazioni rese ai magistrati, rivela: «I sanlucoti e i
platioti insorsero anche in rappresentanza dei preti del santuario,
impedendo che lo spostamento venisse attuato».11
Nel 1969, un altro tentativo per trasferirne la sede non ha
migliore esito e le forze dell'ordine, imbeccate da una fonte anonima,
accerchiano e arrestano più di cento boss a Montarte, il punto più
alto dell'Aspromonte, dove la 'ndrangheta aveva convocato i
rappresentanti delle varie «famiglie» per scongiurare pericolosi
strappi che potessero minare l'unitarietà dell'organizzazione. Già
l'anno dopo, Polsi torna ad essere la sede del raduno annuale dei
boss e nessuno oserà più metterla in discussione.
Nel 2007, dopo la strage di Duisburg, proprio qui, in occasione
della festa della Madonna, le famiglie coinvolte nella faida di San
Luca sono costrette a fare la pace. «Lo vuole la Madonna» dicono i
boss intercettati, vantandosi di essere stati ringraziati pubblicamente
in chiesa. A Polsi si ritrovano uomini divisi dalla faida, ma
accomunati dalla devozione per la Madonna. I Nirta ne appendono
l'immagine in un bunker, mentre Sebastiano Sfrangio, una delle
vittime di Duisburg, la teneva esposta all'ingresso del suo ristorante,
teatro della strage.
«In quei luoghi il sacro si unisce al profano e tutto {...} ha il
sapore di religione, ma anche di mafia» si legge in un rapporto della
questura di Reggio Calabria.12 Solo la Chiesa continua a negare ed a
protestare. «Che mandino un maresciallo a predicare, così la
facciamo finita una volta per sempre» si lamenta nel 1999 il rettore
del santuario, don Pino Strangio, minacciando le dimissioni. «Quei
signori sono ormai anni che ci perseguitano. Hanno fatto intervenire
sette auto e decine di poliziotti che hanno chiesto i documenti anche
a donne e bambini».13
Anche Pietro Borzomati, docente di Storia contemporanea ed
esperto di questioni religiose, esclude ogni forma di complicità con la
'ndrangheta. Scrive:
Non risulta niente negli atti conservati negli archivi della diocesi e
del santuario; le testimonianze attestano anzi il contrario, sia per il
secolo scorso {l'Ottocento} che per il Novecento.
È possibile che i mafiosi siano stati devoti alla Madonna della
Montagna e ciò lo si evince da alcune preghiere, ma non risulta che
all'ombra del santuario siano stati compiuti o tramati crimini.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
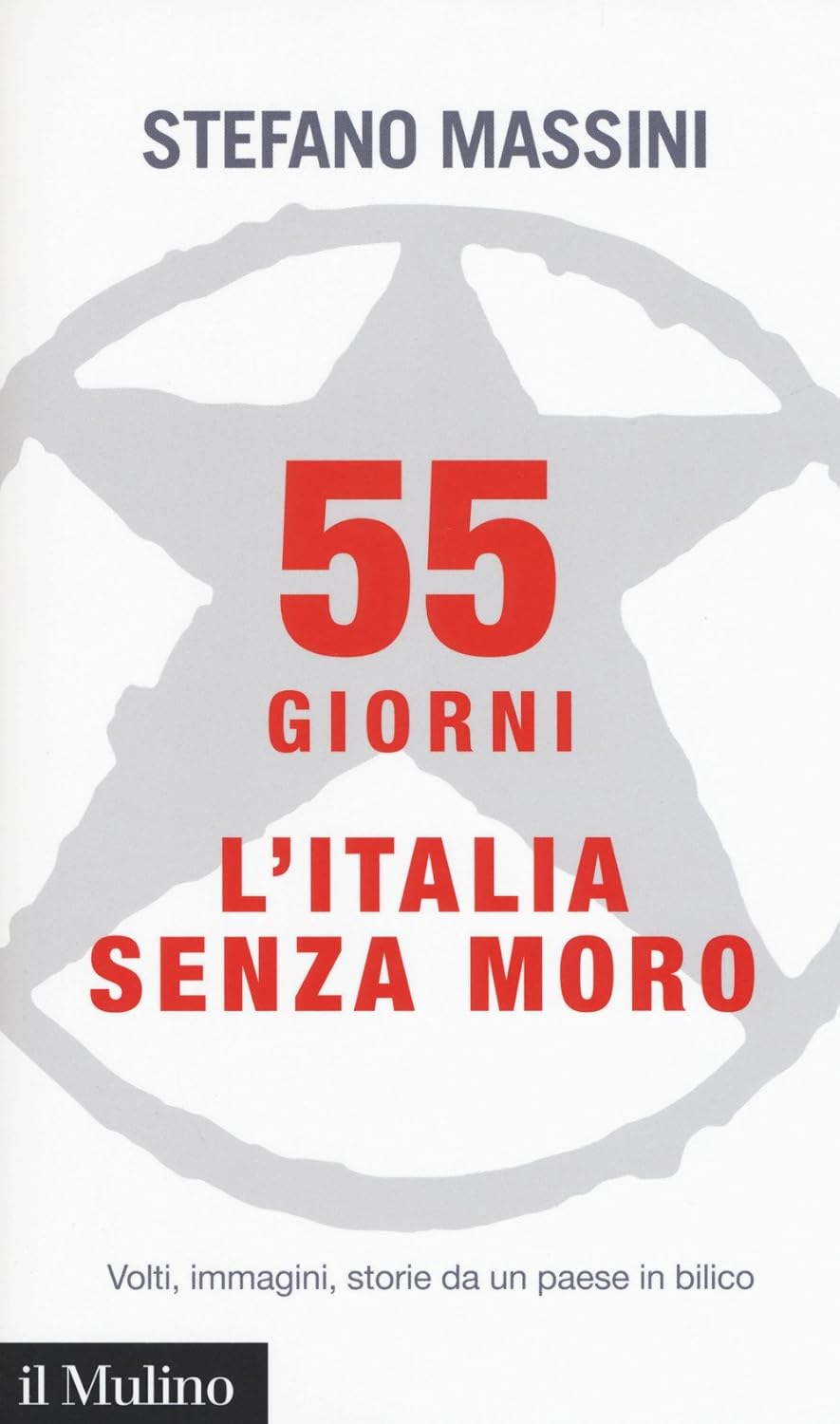






Commento all'articolo