55 giorni. L’Italia senza Moro. Volti, immagini, storie da un paese in bilico – Stefano Massini

SINTESI DEL LIBRO:
Non ho memoria dei giorni di Moro. Nella primavera del 1978
avevo due anni e mezzo, e per quanto mi raccontino come un
bambino perspicace, avevo giustamente fra peluche e macchinine
ben altre priorità che non la cronaca. Il mio primo ricordo politico
risale a un paio di estati più tardi, primissimi anni Ottanta, quando
vedo emergere dalle nebbie dell’oblio l’immagine vacanziera di un
nonno infervorato, che su un sentiero altoatesino disserta con mio
padre sulle sorti del governo Andreotti. Nel candore spensierato
dell’infanzia, ignoravo totalmente che eravamo all’indomani di un
vulnus senza precedenti, la cui gravità riesco a soppesare solo
adesso con mente fredda, rabbrividendo all’idea che un Enrico Letta
o un Paolo Gentiloni possano esser sequestrati da un commando
armato, sbarrati per due mesi in un ripostiglio di cartongesso e lì
sottoposti a un improbabile processo con pena capitale.
Eppure era accaduto proprio questo, mentre allegro scorrazzavo
su un triciclo rosso e giallo, ignaro che sul mio pedigree di italiano
nato nel ’75 sarebbe comunque rimasta una macchia indelebile,
l’equivalente laico di un peccato originale che nessun battesimo
avrebbe potuto emendare. Sembra una sciocchezza, ma in effetti
faccio parte di quella schiera di connazionali che sebbene per un
soffio non possono comunque dire «non ero neanche nato»: io c’ero
eccome, respiravo, ero un nome iscritto all’anagrafe e un numero su
un libretto sanitario, la qual cosa faceva di me un apprendista
italiano autorizzato a dipingere coi pennarelli il tricolore, storpiare in
scimmia lo Scipio di Mameli e fremere d’un embrionale istinto
patriottico all’effige non del presidente Leone bensì del commissario
tecnico Bearzot. Insomma, quel Massini sul triciclo rosso e giallo
sarà stato anche sprovvisto di tessera elettorale, ma era eccome
munito di quei diritti e doveri costituzionali che lo rendevano a tutti gli
effetti un cittadino di questo Stato, le cui istituzioni venivano
attaccate. Bizzarrie del tempo, che nell’arco della vita ti fa incrociare
o evitare certe boe della Storia: se nacqui troppo tardi per accogliere
con un pianto da neonato l’uscita di Wish you were here dei Pink
Floyd, viceversa mi risparmiai la strage dell’Italicus e la bomba di
piazza Fontana, il sangue bresciano di piazza della Loggia e il salto
nel vuoto di Pinelli dal quarto piano della Questura, nonché il rogo di
Primavalle e il Boeing della PAN AM assaltato a Fiumicino dai
terroristi palestinesi. Feci invece a tempo (ero nato da poco più di un
mese) a intercettare la fine barbara di Pier Paolo Pasolini su quello
sterrato di Ostia. E poi, appunto, Aldo Moro. Anzi, soprattutto Aldo
Moro, che in fondo sta all’Italia del dopoguerra come l’omicidio di
Kennedy agli Stati Uniti. È un po’ come accade quando noi
affezionati clienti dell’Autostrada del Sole ci troviamo dentro un
tamponamento a catena, e mentre le auto davanti a te si incastrano
l’una con l’altra, ti auguri di poter essere tu il primo a uscirne invece
intatto: con la tragedia di Moro io fui per caso l’ultima macchina del
tamponamento, quella che per un dannato attimo rientra comunque
fra i veicoli coinvolti, con tutto ciò che ne consegue. Ne prendo atto:
fui un cittadino coinvolto. Inconsapevole, ma coinvolto. E forse è
proprio per questa mancanza di lucidità che ho sempre avvertito per
quei fatti un profondo interesse, tanto da farmene addirittura
incontrare personalmente – di lì a trent’anni, chi l’avrebbe detto? –
due dei protagonisti, in quell’episodio teatrale che sto per narrarvi e
che ritengo la vera origine del libretto che state sfogliando.
Era l’inverno del 2006. Pochi mesi prima avevo portato in scena
un mio brevissimo testo dal titolo La gabbia, in uno spettacolo
dall’impianto insolito che prevedeva pochissimo pubblico assiepato
dietro un parallelepipedo di sbarre carcerarie. All’interno di questo
spazio, con realismo spietato quasi filmico, si teneva il dialogo fra
due personaggi di mia invenzione, ossia una giovane brigatista
condannata per banda armata e una logorroica madre scrittrice di
successo. La stesura del testo mi aveva impegnato per molti mesi,
richiedendomi colloqui, interviste, approfondimenti, ricerche
iconografiche e un appassionatissimo studio di infiniti materiali,
finché la strana pièce finalmente debuttò, incontrando fino da subito
un insperato consenso dall’udienza critica. Ricevemmo recensioni
importanti su tutte le maggiori testate nazionali (a partire dal temuto
Franco Quadri dalle colonne di «Repubblica»), e fummo invitati nei
più prestigiosi festival di drammaturgia, aggiudicandoci al Piccolo
Teatro di Milano il Premio Nazionale dell’Associazione Critici e
perfino l’accesso al podio dei Premi Ubu, di fatto l’Oscar teatrale
italiano. In altre parole, iniziò con insistenza a circolare la voce che
una giovane compagnia teatrale stava rappresentando qualcosa di
inconsueto sul tema degli anni di piombo, e fu a seguito di questa
attenzione della stampa che decidemmo di riproporre l’allestimento
nel minuscolo teatro dov’era nato, in quel di Calenzano,
nell’hinterland fiorentino. Fu qui, una sera come tante, che nella
ristretta cerchia del pubblico adocchiai una coppia in disparte,
visibilmente colpita. Non si mossero fino a che l’ultimo degli
spettatori non lasciò il teatro, dopodiché li vedemmo farsi avanti in
camerino. Incuriositi dall’operazione, erano venuti da Roma per
assistere al lavoro: Valerio Morucci e Adriana Faranda. Di costoro
sapevo quasi tutto. Morucci era stato non solo uno degli ideatori, ma
un’attiva forza sul campo del sequestro di Aldo Moro, preparato da
oltre un anno con appostamenti e sopralluoghi.
La mattina del 16 marzo 1978 Morucci si era fatto trovare nelle
prossimità del bar Olivetti di via Fani, travestito com’è noto in divisa
da aviere. Con lui erano Raffaele Fiore, Franco Bonisoli e il Gallinari,
pronti ad aprire il fuoco non appena la 128 bianca guidata da Mario
Moretti costringerà la vettura di Moro a fermarsi. Al momento
dell’agguato Valerio Morucci uccide con una mitragliata di colpi il
maresciallo Leonardi e l’appuntato Ricci, incaricandosi poi di
prelevare lo statista e con lui le sue borse di documenti. Fu infine
sempre Morucci a passare all’Ansa il famoso primo comunicato delle
10:10 in cui si annunciava l’esecuzione della scorta definita «teste di
cuoio di Cossiga». Quanto invece alla sua compagna, Adriana
Faranda, era stata per tutto il tempo del rapimento l’addetta
all’attività postale, salvo poi dissentire – insieme a Morucci – sul
tragico epilogo del processo popolare (e fu l’inizio del loro distacco
dal resto del gruppo, culminato poi con la dissociazione dalla lotta
armata). Mi trovavo quindi davanti due facenti parte del commando
brigatista di via Fani, due dei rapitori del covo di via Montalcini, due
dei membri del fatidico Tribunale del Popolo che aveva processato
Moro. Fu una serata di lunghi silenzi e di scambi di punti di vista,
complice l’atmosfera che si crea solo in teatro; una serata che si
protrasse per ore, e di cui conservo un geloso ricordo, perché è
un’esperienza irripetibile percepire che stai sfiorando un punto
tragico nel perimetro evanescente della Storia. Trascorsero alcuni
mesi. E quando l’annuario del teatro italiano (il leggendario Patalogo
edito da Ubulibri) mi chiese un contributo scritto sullo spettacolo,
decisi di rivolgermi a Morucci per sondarne la disponibilità. Mi
ascoltò in silenzio, sentii di là dalla cornetta sì e no dieci parole,
pronunziate con nuova diffidenza da un essere guardingo verso colui
che – fuori dall’utero fascinoso del teatro – era di fatto uno
sconosciuto. Ma evidentemente qualcosa si mosse, e credo fu
ancora una volta il graffio portentoso che il patto della scena spesso
ingenera fra platea e palco. Non passarono tre giorni che ricevetti
questoSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
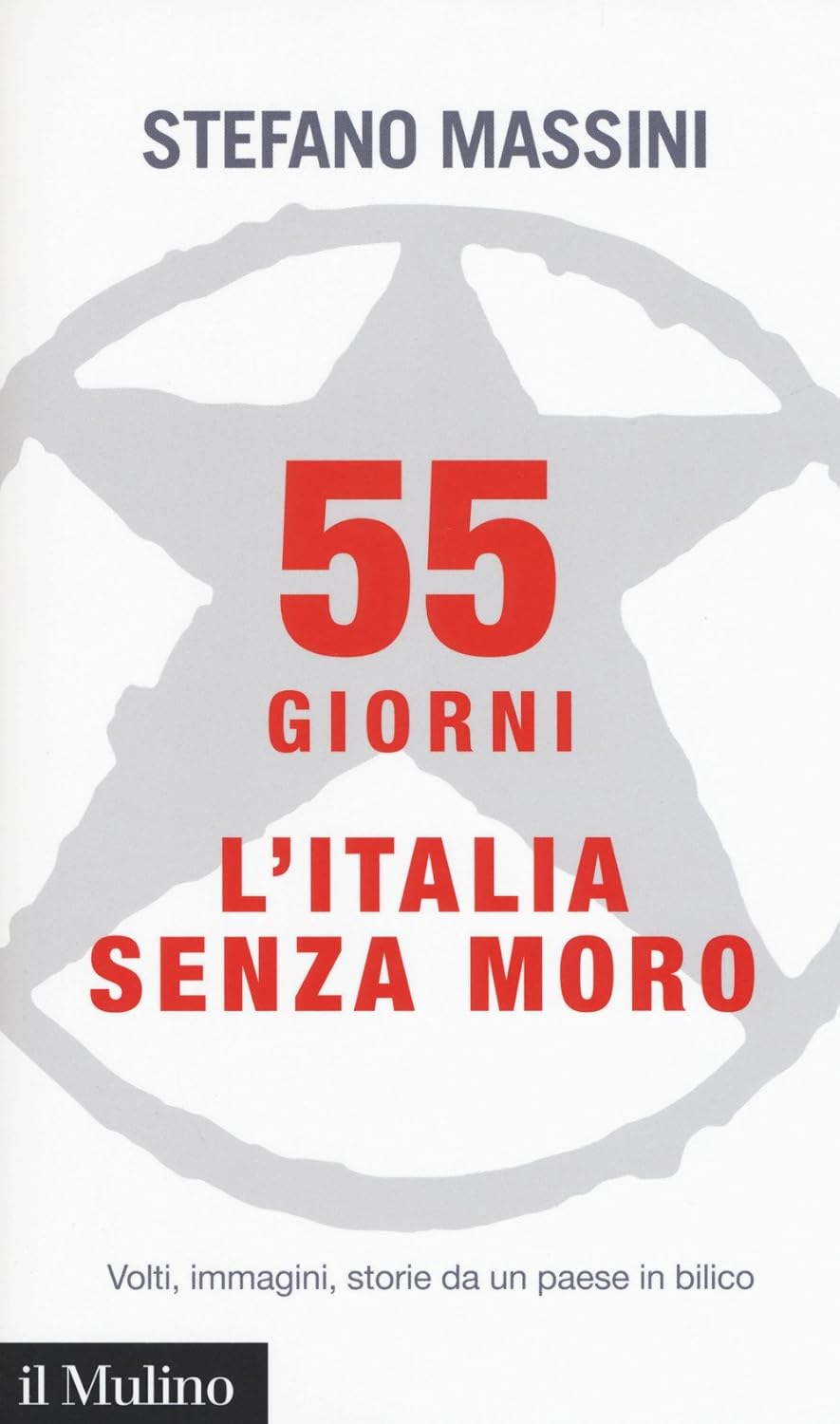






Commento all'articolo