Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica – Giuseppe Antonelli
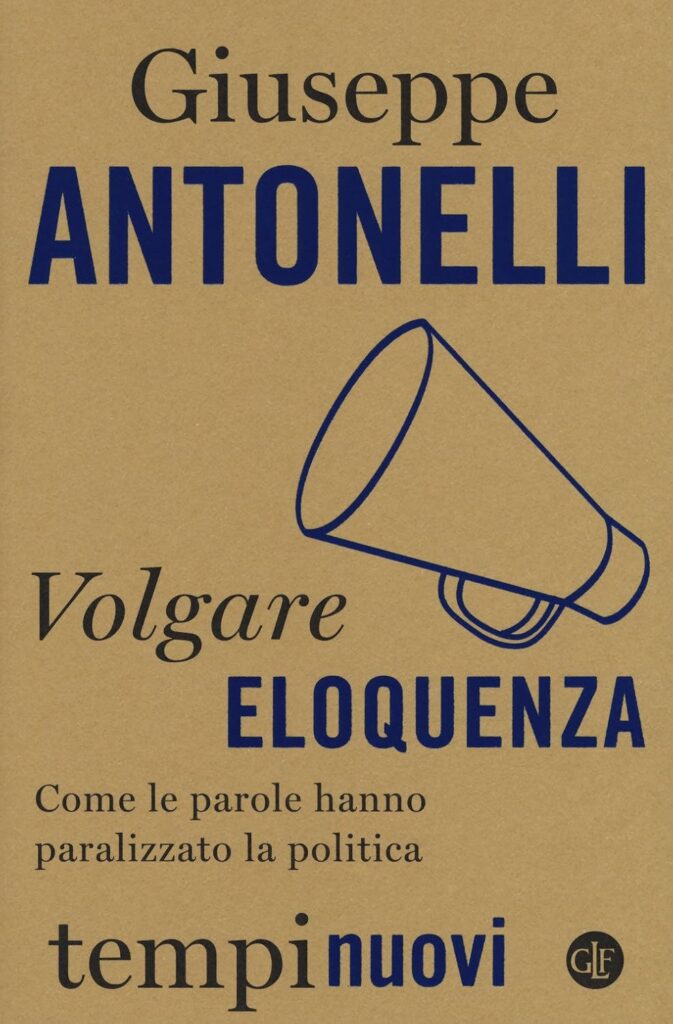
SINTESI DEL LIBRO:
Una mattina di giugno, poco meno di un anno fa, mi sono trovato a
passare con mia moglie e mia figlia per piazza del Popolo. Noi abitiamo a
Roma, per piazza del Popolo ci passiamo spesso, soprattutto nel fine
settimana. Anche perché mia figlia, che ha sei anni, ama molto le bolle di
sapone giganti che un signore fa lì in piazza proprio per attirare
l’attenzione dei bambini.
Quel giorno, però, la sua attenzione è stata attirata dal grande palco che
stavano finendo di montare su lato opposto. «Che cos’è papà, ci fanno un
concerto?». «No, amore: stanno preparando la festa di un partito
politico». La sera Virginia Raggi avrebbe chiuso la campagna elettorale
che l’avrebbe portata a essere la prima sindaca di Roma.
Neanche il tempo di finire la frase, che sentiamo una voce dal tono
aggressivo alle nostre spalle: «Non è un partito, è un movimento!». Mi
giro e vedo un ragazzo per mano a una ragazza: mi sta guardando con aria
di sfida. Capisco che è meglio lasciar perdere.
«Ti è mai venuto in mente che a forza di gridare / la rabbia della gente
non fa che aumentare? / La forza certamente deriva dall’unione / ma il
rischio è che la forza soverchi la ragione». Così cantava Daniele Silvestri
nel 1994. Un anno decisivo per la politica italiana: l’anno della cosiddetta
discesa in campo di Silvio Berlusconi. Oggi il tasso di aggressività è molto
aumentato. Basta vedere cosa succede in rete quando il capo del nuovo
Movimento lancia la sua fatwa contro qualche personaggio pubblico. Il
linguaggio rozzamente rissoso a cui i politici ricorrono sempre più spesso,
d’altronde, non può che autorizzare – anzi: incoraggiare – un uso
altrettanto scurrile e violento da parte dei seguaci. «La gente che grida
parole violente / non vede, non sente, non pensa per niente».
Non un partito, un movimento. Proprio come il «Movimento politico
Forza Italia» fondato da Berlusconi. A dispetto di tutto l’odio riversato su
di lui in questi anni, il linguaggio non-politico (anti-politico) dei Cinque
stelle è figlio proprio di Berlusconi e della rivoluzione linguistica che ha
segnato la cosiddetta seconda Repubblica. È l’esito, tutto sommato
prevedibile, di una evoluzione (involuzione) che nel giro di pochi anni ha
portato l’italiano della politica da una lingua artificialmente alta a una
lingua altrettanto artificialmente bassa. Una lingua basica, elementare,
grossolana. Apparentemente chiara, in realtà vuota, dal momento che si
limita a ignorare o banalizzare le complesse questioni a cui dovrebbe far
fronte.
Questo passaggio è stato accelerato dallo spostamento del dibattito
politico prima nell’ambito della chiacchiera televisiva (i talk show), poi di
quella telematica (i blog, i social network, le chat). E ha fatto tutt’uno con
il passaggio dall’argomentazione alla narrazione e il conseguente
abbandono di una vera dialettica. «Proliferazione di parole che cerca di
colmare il difetto di presa sul reale» la definisce Christian Salmon nel suo
La politica nell’era dello storytelling.
Lo spazio delle parole si è ampliato a dismisura, ma nella stessa misura si
è ridotto il tempo per il ragionamento e la discussione. Le uniche parole
sono rimaste, così, parole d’ordine (o di disordine) ripetute all’infinito,
riprese a voce sempre più alta per coprire la voce di chi in quelle parole
non si riconosce. Alla partecipazione si è sostituita la condivisione. Un
meccanismo che sfrutta la reticolare orizzontalità della rete, ma è in realtà
verticale e verticistico. Perché trasforma ogni attivista in un passivo
ripetitore impegnato a diffondere, rilanciandolo, un messaggio
preconfezionato.
La politica si è sempre nutrita di parole, certo. Ma adesso le parole
sembrano aver occupato tutto lo spazio: anche quello che dovrebbe essere
del pensiero. A ogni condivisione diventano più pesanti, ma intanto
perdono il loro peso specifico. La loro stessa genericità le allontana
progressivamente dalla concretezza dei fatti, fino a renderle – sempre più
spesso – parole senza le cose. Dietro all’apparenza di un falso movimento,
le parole stanno paralizzando la politica.
Come sappiamo bene, si tratta di un processo che non riguarda solo
l’Italia. Un libro recente, scritto da Mark Thompson (già direttore della
BBC, ora presidente e chief executive del «New York Times»), s’intitola La
fine del dibattito pubblico. Vale a dire di un confronto dialettico basato sulle
idee e sulle proposte, cosa ben diversa dall’aggressiva faziosità politica
sempre più simile al tifo calcistico. Proprio al tifo calcistico, d’altra parte,
rimandava nel 1994 il nome scelto da Berlusconi per il suo movimento:
Forza Italia. Per sottolineare l’analogia sportiva, gli iscritti ai «club» di
Forza Italia furono chiamati «gli azzurri», e la sua entrata in politica fu
appunto definita «discesa in campo». Berlusconi – all’epoca presidente di
un Milan che era tra le squadre più forti del mondo – aveva fatto scrivere
anche un inno, da cantare in coro per sentirsi parte di un’unica squadra.
«E Forza Italia / è tempo di credere / dai Forza Italia / che siamo
tantissimi».
Per non essere da meno, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo di inni
ne ha cambiati già tre. Prima c’è stato Ognuno vale uno, poi Non sono partito
del rapper Fedez. Infine, annunciato con grande enfasi dal blog dello
stesso Grillo, ecco – nel settembre 2015 – il nuovo inno «da imparare a
memoria»: Lo facciamo solo noi! di Max Bugani.
La struttura della canzone ricalca quella della leggendaria Siamo solo noi
di Vasco Rossi. «Lo facciamo solo noi / di salire sopra il tetto / di
pretendere rispetto / da chi proprio non ce n’ha. / Lo facciamo solo noi / di
non fare compromessi / di restar sempre noi stessi / per amore di onestà».
Per suonare ancora più rock, però, quest’inno trova il modo di usare
anche una parolaccia: «noi finanziamo le piccole imprese / loro le fottono
con la politica» (forse due: anche politica, usata così, sembra quasi una
parolaccia). E ostenta un bell’indicativo al posto del congiuntivo, che fa
sempre molto ribelle: «noi lavoriamo anche quando è Natale / a loro
sembra che è sempre domenica».
Ma la vera differenza con la canzone di Vasco Rossi sta nel fatto che qui
tutta la struttura sintattica si basa su quella che i linguisti chiamano
«dislocazione a destra». Quel costrutto per cui, ad esempio, diciamo «lo
bevo amaro, il caffè», invece di «bevo il caffè amaro». In questo caso: lo
facciamo solo noi di X. «Lo facciamo solo noi / di difendere l’ambiente / di
arrestare il delinquente / che avvelena la città. / Lo facciamo solo noi / di non
prendere i rimborsi / di far fatti e non discorsi / per la nostra Italia».
Un caso? Forse sì. Però, a proposito di destra, colpisce che la nostra Italià
suoni – accento a parte – un po’ come Forza Italia. Senza contare che il
«per fortuna che qui prima o poi / governiamo noi» su cui si chiude l’inno
dei Cinque stelle riporta dritti dritti a un altro inno di Forza Italia: Meno
male che Silvio c’è. (E quel «governiamo noi» ricalca l’hashtag #Vinciamonoi
lanciato dal movimento di Grillo durante la campagna per le europee
2014: quello che – dopo la clamorosa vittoria del PD – qualcuno
trasformò in un ironico #Vinciamopoi).
Nel testo scelto da Grillo c’è tutto il lessico classico del qualunquismo
populista. Se i buoni siamo noi, i cattivi sono loro. Ma loro chi? Le tre
marionette, ad esempio («accidenti a ’ste tre marionette / fan più danni
delle sigarette»): un’espressione che rimanda al berlusconiano teatrino della
politica. O, meglio ancora, la casta: «le autoblu le lasciamo alla casta». Con
quel riferimento alle auto blu che non può non farci venire in mente il
compianto Rino Gaetano: «auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu...
nuntereggae più... PCI PSI nuntereggae più / DC DC nuntereggae più /
PCI PSI PLI PRI DC DC DC DC nuntereggae più».
Un movimento, non un partito. Anzi: un anti-partito. Proprio come il
Movimento Sociale fondato da Giorgio Almirante. Già Mussolini,
d’altronde, metteva tra i tanti -ismi da combattere anche il partitismo. «Il
partitismo nella storia è il più grande nemico della verità e della giustizia»,
si legge nel Manuale di metodologia storica di Domenico Battaini, pubblicato
la prima volta nel 1904, ma ripubblicato e adottato nelle scuole superiori
nel 1934, anno XII dell’era fascista. «Non mi devi giudicare male /
anch’io ho tanta voglia di gridare / ma è del tuo coro che ho paura /
perché lo slogan è fascista di natura».
Che dire di un movimento il cui leader, durante la prima campagna per
le elezioni politiche, esclamò a muso duro: «apriremo il Parlamento come
una scatola di tonno»? Tanto valeva, allora, farne un «bivacco di
manipoli». Affermare che in democrazia non c’è bisogno di istituzioni
rappresentative – perché i politici devono rispondere solo al popolo –
implica automaticamente (ed etimologicamente) il passaggio dalla
democrazia alla demagogia, ovvero al populismo.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






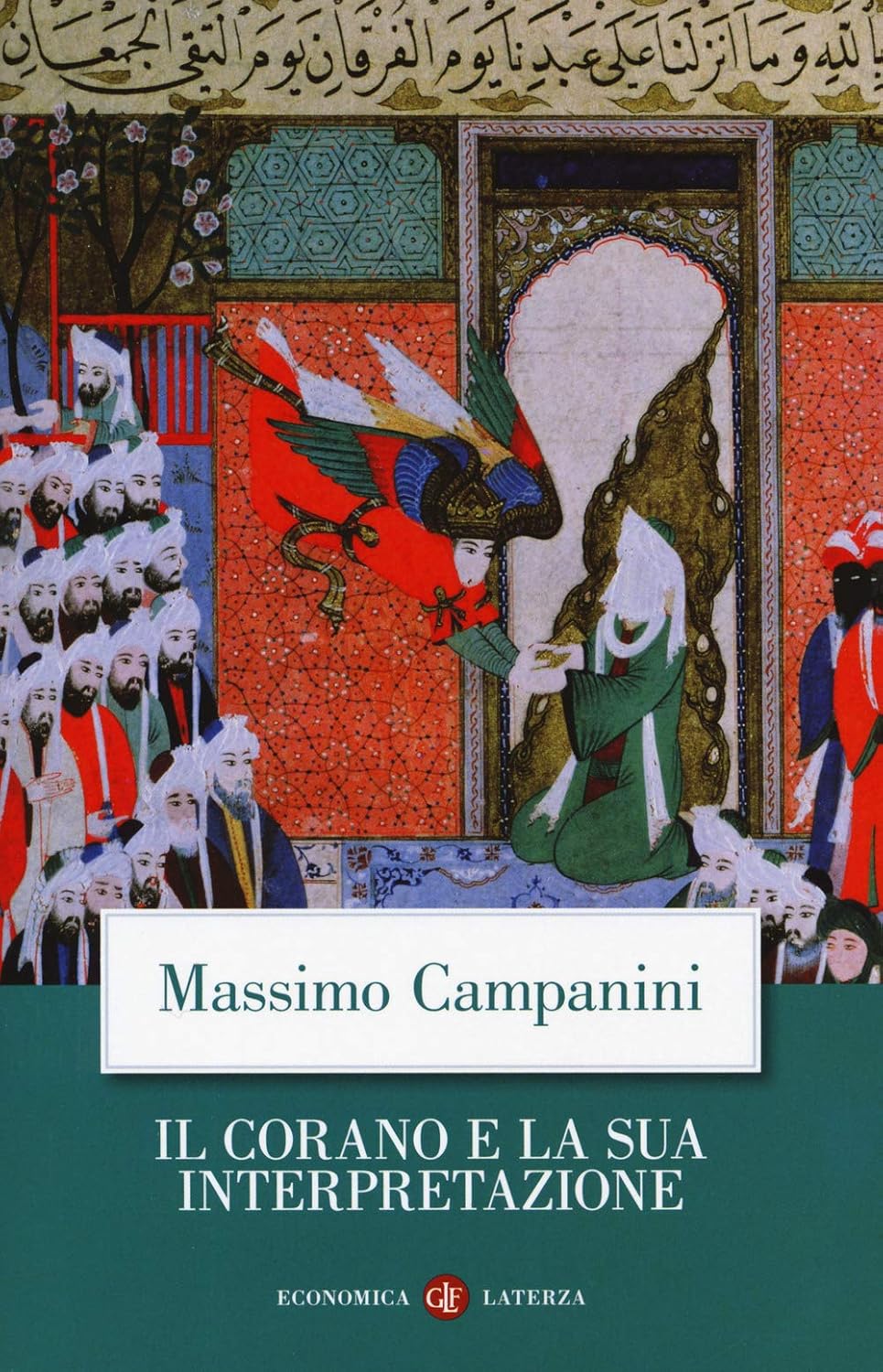
Commento all'articolo