Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla – Claudio Bartocci
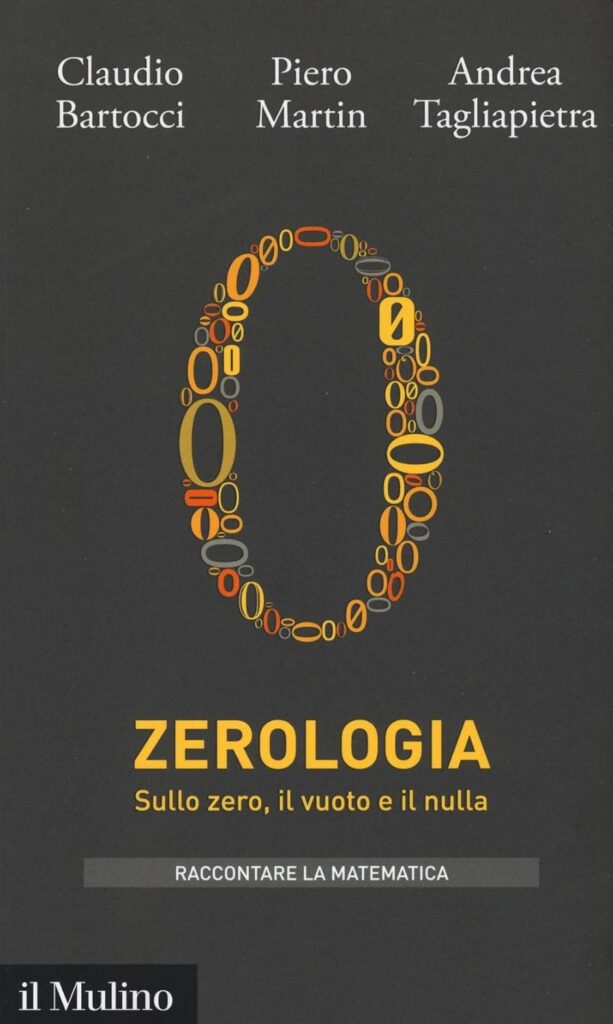
SINTESI DEL LIBRO:
Qual è il problema?
Il «significato di zero» – avverte Bertrand Russell nei Principles of
Mathematics (1903) – «rappresenta una questione di grande
difficoltà, da trattare con estrema cura, se si vuole evitare di
incorrere in contraddizioni».
Dobbiamo prendere sul serio questo monito? Di primo acchito si
potrebbe pensare di no. Ogni bambino, fin dalla scuola elementare,
impara senza apparente difficoltà che, oltre ai numeri che si usano
per contare (uno, due, tre, ...), esiste un «numero speciale», lo zero,
che è alla base del sistema di rappresentazione decimale. Mentre i
primi nove numeri si indicano con simboli tutti diversi (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9), per il decimo si introduce una notazione composta: 10, una
«decina». I numeri seguenti si scrivono, nell’ordine, 11, ..., 19, fino
ad arrivare a due decine (20), e così via fino a 99, il nono numero
successivo a nove decine. Per procedere oltre si ricorre alle
convenzioni linguistiche e simboliche che tutti conosciamo: una
decina di decine è un centinaio (100), una decina di decine di
decine, ossia una decina di centinaia (o un centinaio di decine), è un
migliaio (1.000), un migliaio di migliaia è un milione (1.000.000), un
migliaio di milioni è un miliardo (1.000.000.000), e avanti di questo
passo, come nella «Gara mondiale di matematica» descritta da
Cesare Zavattini in Parliamo tanto di me.
In questo sistema di rappresentazione, tuttavia, il simbolo 0 non
può essere considerato un «numero naturale» alla stessa stregua di
tutti gli altri (un concetto, quello di «numero naturale», che non
abbiamo ancora tentato di definire, ma che, nella sua accezione
ingenua, è strettamente collegato alle operazioni di contare e di
mettere in sequenza). Lo zero serve soltanto a denotare,
ricorsivamente e in dipendenza del numero complessivo di cifre, il
numero di decine, di decine di decine, ecc. indicato dalle cifre che lo
precedono (30 = «tre decine»; 300 = «trenta decine» = «tre decine di
decine»; 1.003 = «il terzo numero dopo una decina di decine di
decine»). Per quanto riguarda l’operazione di addizione eseguita in
colonna (anche questa una procedura ben nota a tutti gli scolari), le
regole 0 + 1 = 1 = 1 + 0 e 9 + 1 = 10 = 1 + 9 sono puramente formali
e derivano dell’assioma che stabilisce che il «successore» di ogni
numero naturale n è uguale a n + 1 = 1 + n.
Se adottassimo il sistema di numerazione binaria, avremmo
bisogno di due soli simboli, 1 e 0. Il secondo numero si indica con 10
(un «paio»), il terzo con 11 (il primo numero dopo un paio), il quarto
con 100 (un paio di paia), il quinto con 101 e così via. Usando
questo metodo di rappresentazione, lo zero denota, ricorsivamente e
in dipendenza del numero complessivo di cifre, il numero di paia, di
paia di paia, ecc. indicato dalle cifre che lo precedono (per esempio,
con 1001 si indica il primo numero dopo un paio di paia di paia, cioè
nove). Nell’addizione in colonna, la regola 1 + 0 = 1 = 0 + 1 rimane
invariata, mentre si deve introdurre – in conseguenza dell’assioma
enunciato prima – la regola 1 + 1 = 10. Nel sistema di numerazione
unario – estremamente poco pratico perché a ogni numero si
dovrebbe assegnare un nome diverso (come per il protagonista del
racconto di Luis Borges Funes, o della memoria: «In luogo di
settemilatredici diceva (per esempio) “Máximo Perez”; in luogo di
settemilaquattordici, “La Ferrovia”; altri numeri erano “Luis Melián
Lafinur, Olimar, zolfo, il trifoglio, la balena, il gas, la caldaia,
Napoleone, Agustín de Vedia”») – è sufficiente un solo simbolo, 1,
un’unità: il secondo numero si indica con 11, il terzo con 111 e così di
seguito. La regola di addizione è semplicemente 1 + 1 = 11. Dello
zero, in questo sistema, non c’è traccia.
Si potrebbe obiettare che lo zero diventa invece essenziale non
appena si cerchi di definire l’operazione inversa dell’addizione: la
sottrazione. Il procedimento formale, e più rapido, da seguire si trova
descritto in qualsiasi manuale di algebra. Sull’«insieme» dei numeri
naturali 1, 2, 3, ... è definita, come abbiamo ricordato, l’«operazione»
(commutativa e associativa) di addizione, basata sulla nozione di
«successore»; si introduce dunque un nuovo elemento, indicato con
il simbolo 0 e caratterizzato in modo univoco dalla proprietà
seguente: per ogni numero naturale n, deve valere l’uguaglianza n +
0 = n. In altre parole, si definisce lo zero come «elemento neutro»
dell’addizione. Dato che 0 + 1 = 1, è naturale immaginare che 1 sia il
successore di 0. A questo punto, si associa a ogni numero n il suo
«opposto», vale a dire l’elemento denotato convenzionalmente con –
n tale che n + (–n) = 0; si osservi che, poiché 0 + 0 = 0 (il che segue
dalla definizione e dalle proprietà dell’addizione), l’opposto di 0 è
ancora 0. Sul nuovo insieme che risulta così formato – quello dei
«numeri interi» (triplicemente suddivisi in positivi, negativi e lo zero)
– devono valere le regole: – (–n) = n e (–n) + (–m) = – (n + m). Per
semplificare la notazione, si conviene infine di scrivere n – m in
luogo di n + (–m), un’operazione che ha sempre senso qualunque
siano i numeri interi n e m.
Come si vede, la costruzione algebrica che abbiamo brevemente
ricapitolato è abbastanza semplice, per quanto noiosa, ma di certo
non dissipa la nebbia che circonda il «significato» dello zero. Troppi
sono i termini non definiti (o solo vagamente definiti) che concorrono
a offuscare la visione – numero naturale, insieme, operazione,
elemento neutro, opposto –, dei quali, per sopraggiunta, non
risultano affatto perspicui i legami di interdipendenza logica. Quali
sono i concetti «primitivi», sempre che sia possibile stabilire una
qualche sorta di gerarchia epistemologica? L’idea di numero naturale
precede, in qualche senso da chiarire, quella di insieme, oppure è
subordinata a quest’ultima? E, a livello più fondamentale, il fatto che
un qualche «termine» soddisfi certe proprietà logiche ci dice forse
qualcosa a proposito della sua esistenza? Dall’asserzione esente da
contraddizioni che l’ippogrifo appartiene all’insieme degli esseri
mitologici consegue che l’ippogrifo esiste?
D’altra parte, chi preferisse non rompersi la testa con le astrusità
dell’algebra e decidesse di limitare i propri ragionamenti ai numeri
naturali (la cui definizione – ripetiamolo ancora – è assai
problematica, e la cui esistenza è quantomeno opinabile), si
troverebbe in seria difficoltà a definire lo zero sulla base di
ragionamenti di aritmetica elementare. Un enunciato quale «se ho
ventisei ciliegie e ne mangio ventisei, mi rimangono zero ciliegie» è
privo di senso, e fa venire in mente le assurdità del dialogo tra il
professore e l’allieva nella Lezione di Ionesco: «Se lei avesse avuto
due nasi e io gliene avessi strappato uno, quanti gliene resterebbero
adesso?». L’operazione di sottrazione, come abbiamo accennato,
non è definita sull’insieme dei numeri naturali: l’espressione 8 – 3 =
5 è soltanto una comoda riformulazione dell’espressione 5 + 3 = 8,
così come scrivere che 26 – 26 = 0, nell’ambito matematico nel
quale abbiamo deciso di confinarci, significa soltanto che 26 = 26.
Eppure, sulla base dell’esperienza comune, sembra difficile
dubitare del fatto che, se mangio tutte le ciliegie del mio cestino, non
me ne rimane «nessuna». Le paroline «nessuno», «niente», «nulla»
e la stessa negazione «non» sono notoriamente insidiose e fonte di
inesauribili paradossi, sui quali i filosofi e i logici si arrovellano da
oltre duemilacinquecento anni. Per quel che riguarda il nostro
problema, nel Sofista di Platone lo straniero afferma come principio
che «il non essere [τὸ μὴ ὄν] non deve participare né dell’uno né dei
molti» (239 e) e, proprio nel fare asserzioni di questo genere, non
può evitare di cadere in contraddizione: «poco fa e anche ora l’ho
detto “uno”, poiché uso l’espressione “il non essere”» (ibidem).
Come ha scritto Willard Van Orman Quine nel saggio On what there
is (1948):
Questo è il vecchio rompicapo platonico del non essere [nonbeing]. Il
non essere deve, in un certo senso, essere, altrimenti che cos’è quello che
non è? A questa intricata dottrina si potrebbe affibbiare il nomignolo di
«barba di Platone»; nel corso della storia, si è dimostrata dura da radere,
riuscendo spesso a smussare il filo del rasoio di Occam.
Anche senza avventurarsi nella temeraria impresa di scrutare gli
abissi del non essere, si potrebbe provare a dare una spuntatina alla
«barba di Platone» osservando che l’idea matematica di zero, ignota
al pensiero greco, sembra suggerire qualche obiezione alle sottili
argomentazioni dello straniero. Il «non essere non deve partecipare
né dell’uno né dei molti», d’accordo; ma non potrebbe avere
qualcosa a che fare con lo zero? In altre parole – e limitatamente
alla questione specifica che stiamo tentando di sbrogliare –, così
come associamo il numero uno a tutti gli «insiemi» (che
supponiamo) costituiti da un singolo elemento, il due a tutti gli
insiemi (che supponiamo) costituiti da un paio di elementi, eccetera,
non sarebbe possibile associare lo zero a tutti gli insiemi (che
supponiamo) costituiti da nessun elemento?
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
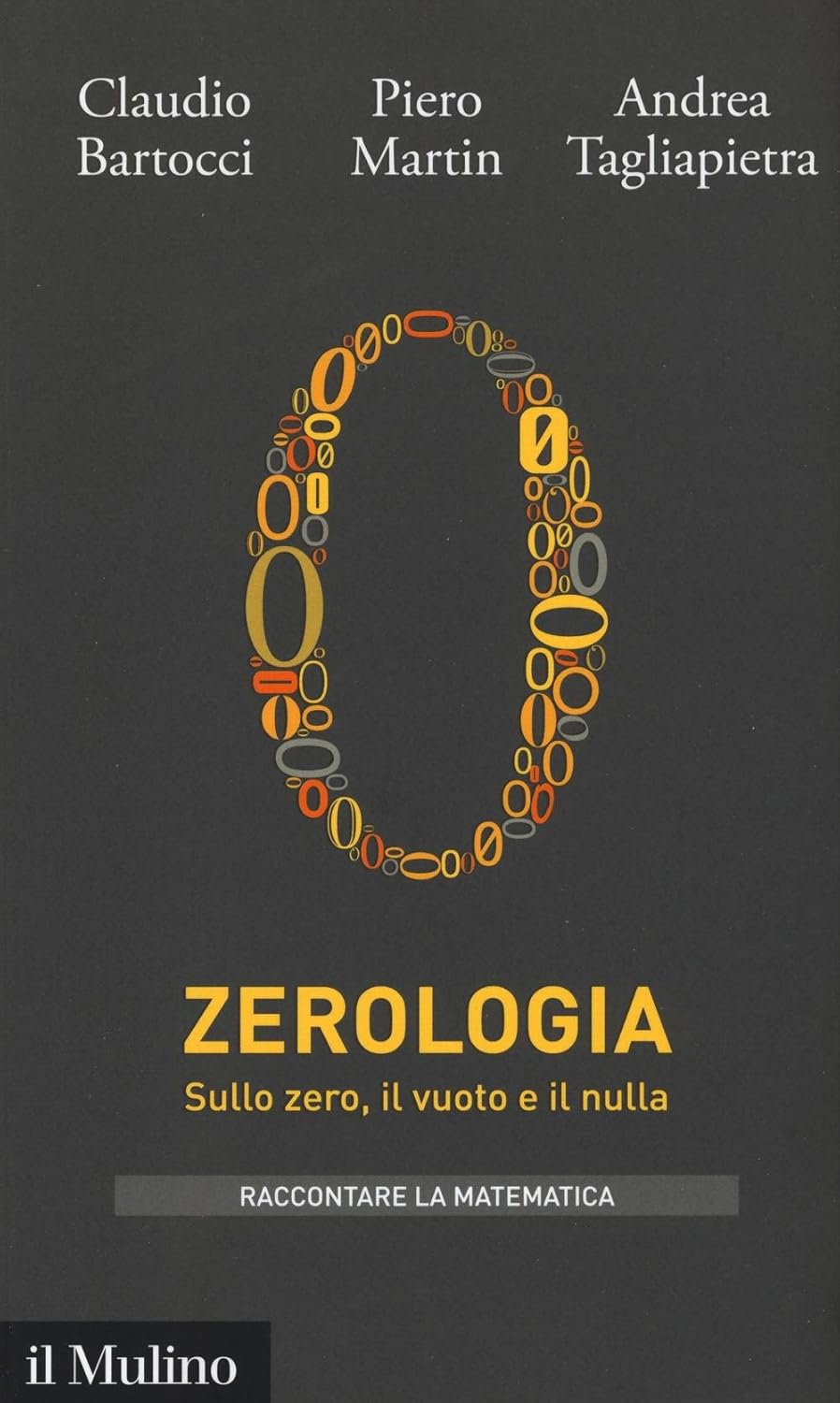



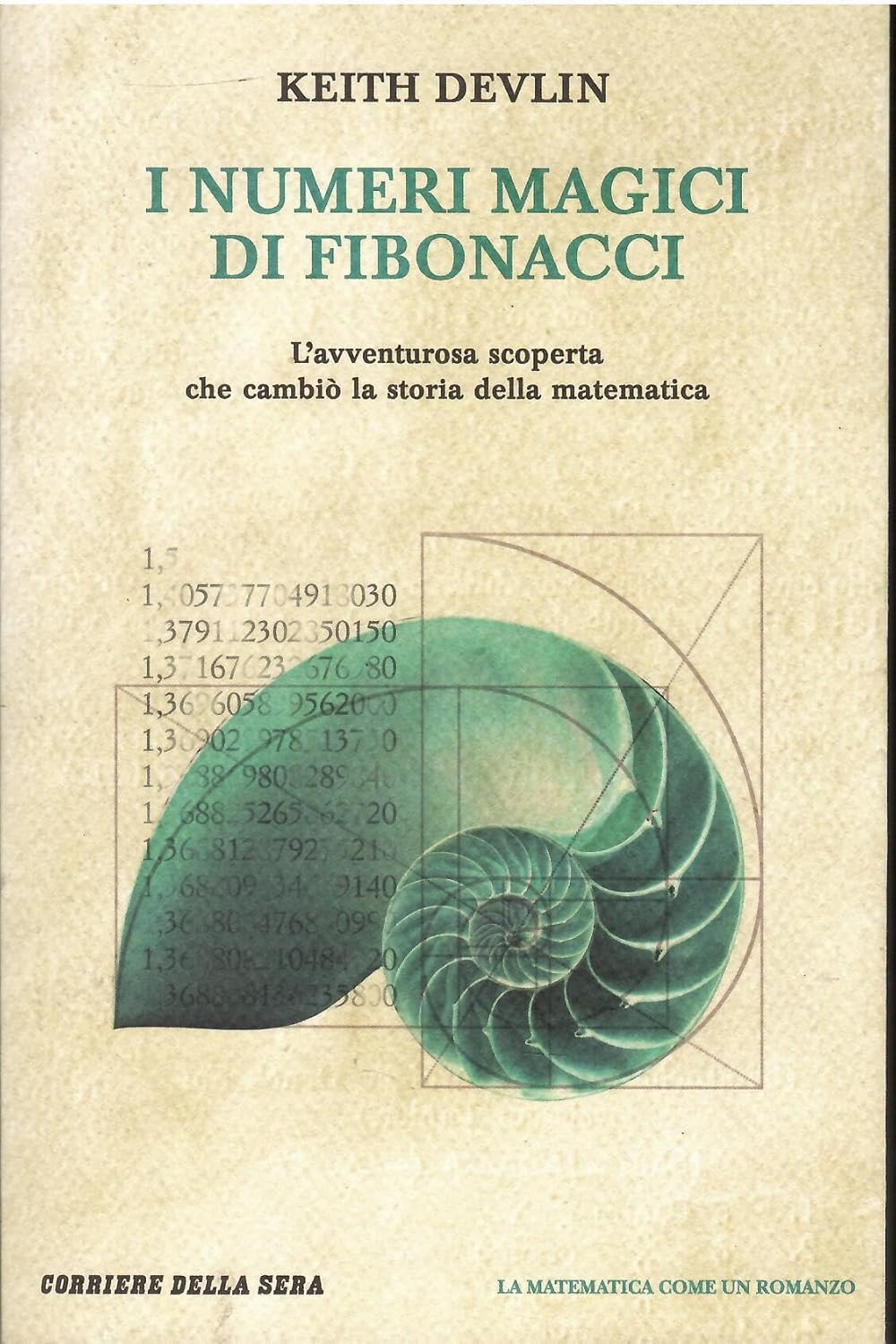
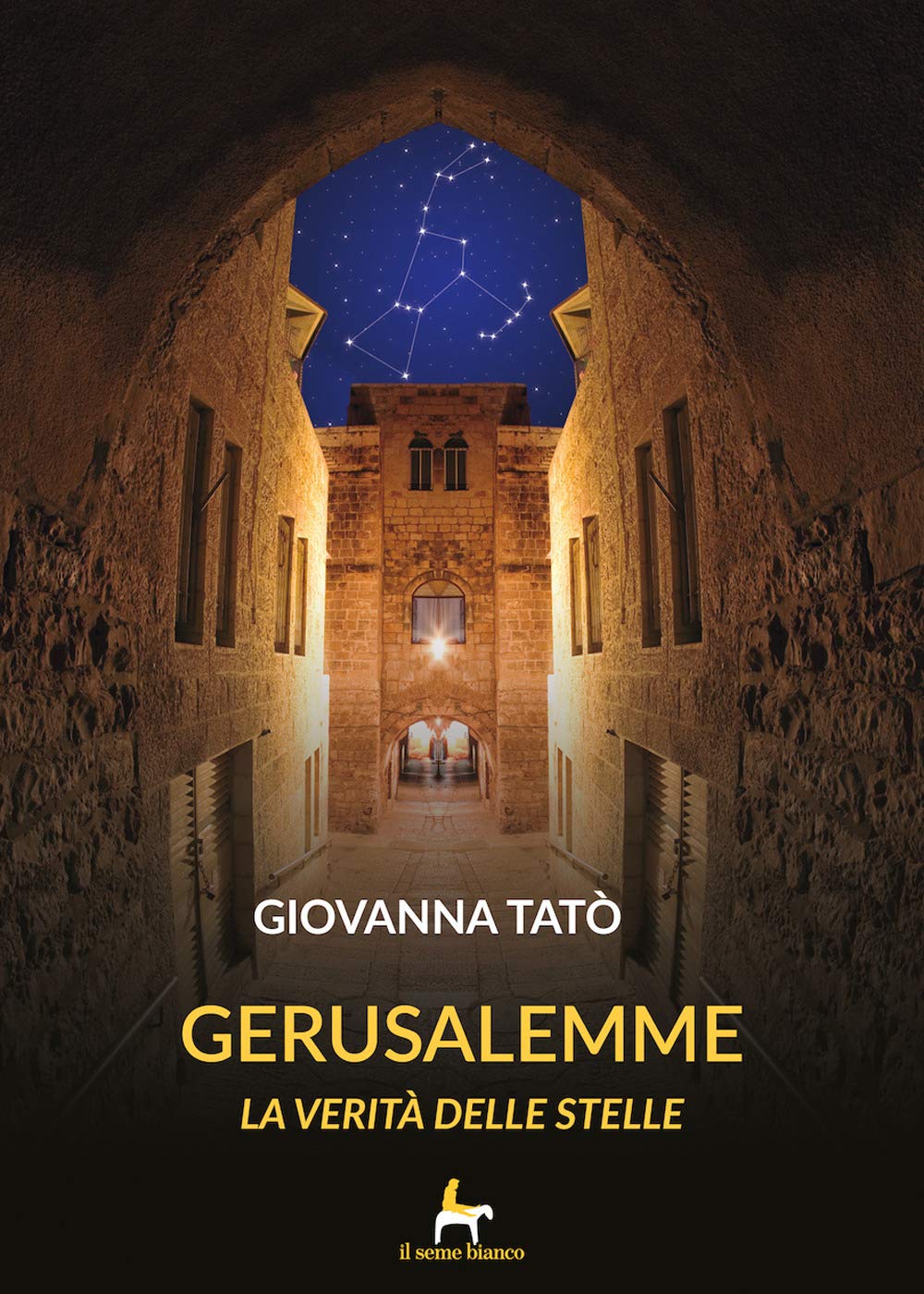
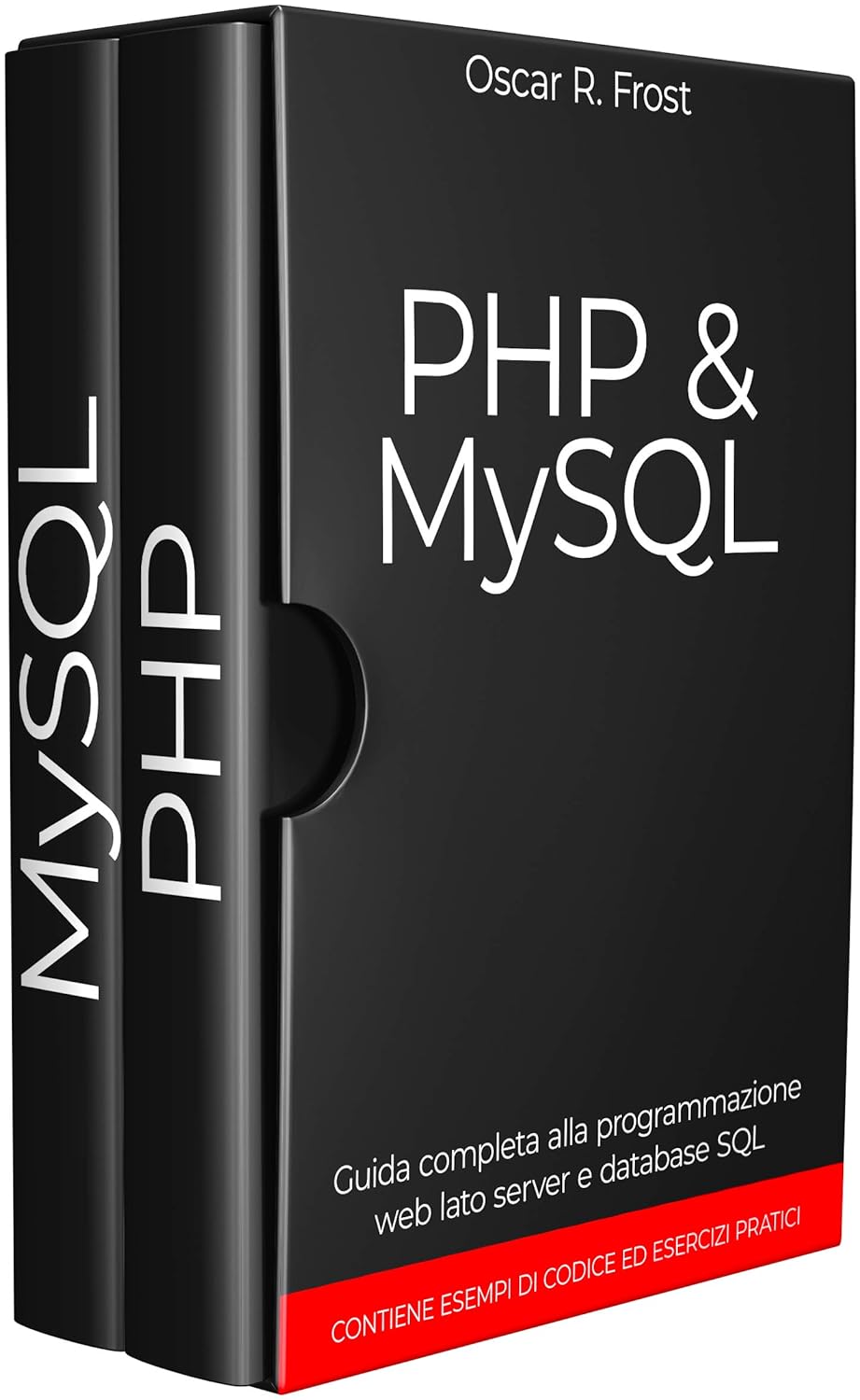
Commento all'articolo