E se poi prende il vizio?: Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini- Alessandra Bortolotti

SINTESI DEL LIBRO:
I
CULTURA, CONFORMISMO E RUOLI GENITORIALI A
CONFRONTO
Introduzione: fisiologia, normalità e consumi
“Io passo per una mamma che non intende far crescere il proprio bambino perché dorme con noi, allatto,
rispondo sempre e con infinita pazienza a qualsiasi suo richiamo e quando lui comincia ad aver attacchi di
rabbia, al posto di innervosirmi, lo tranquillizzo e cerco di capire dove sta il problema. Dicono che lo vizio,
che non crescerà mai... per colpa miai Chiaramente a me non importa ciò che possono pensare ‘gli altri’,
ma ci si sente spesso tanto soli a leggere certi articoli. Vedere che esiste gente come me, che non sono un
E.T., è davvero confortante.”
Rossella, mamma di Francesco
Questo libro nasce per fare chiarezza e diffondere informazioni su ciò che è
normale, sano e universale per tutti i bambini.
Nell’immaginario collettivo occidentale i bambini dovrebbero essere sempre
tranquilli, sereni, non disturbare, dormire tutta la notte prima possibile, finire
tutto quello che hanno nel piatto, stare fermi. Questi bambini sono quelli
rappresentati dalle pubblicità e da una certa cultura dell’immagine, non certo dei
sentimenti. Nella nostra mentalità non c’è chiarezza su quali siano i bisogni
oggettivi di ogni bambino, in qualsiasi angolo della Terra nasca e cresca. Inoltre,
si scambiano questi bisogni per vizi, poiché si ignora che i luoghi comuni relativi
al rischio di viziare i bambini non hanno alcuna base biologica ma sono
unicamente frutto di pregiudizi ideologici. Sfuggono a molti esperti alcuni
aspetti di base della fisiologia, cioè di ciò che è normale per ogni appartenente
alla specie umana in un buon stato di salute
1
.
L’etimologia della parola fisiologia ci rimanda alla lingua greca in cui physis e
logos significano rispettivamente natura e insegnamento. È, quindi, una
disciplina che studia ciò che è naturale e normale per ogni persona in una
prospettiva transculturale, che va cioè oltre i modelli e le credenze dettate dalla
cultura.
Conoscere a fondo questa materia può aiutare i genitori a capire meglio i
propri figli e i loro bisogni, considerando normale, per esempio, dormire con
loro, allattarli a lungo o portarli nelle fasce. Nella nostra società queste pratiche
sembrano, invece, strane o addirittura da evitare: piuttosto che dare valore a un
“pacchetto di cure” che prevedano semplicemente il contatto fra genitori e figli,
pare normale delegare tutto agli esperti o ancora sembra che le varie scienze
debbano aiutare a vivere meglio e “insegnare” l’impegnativo mestiere del
genitore.
In realtà, molto ci è suggerito dallo svolgersi quotidiano della relazione che
instauriamo con i nostri figli, soprattutto se questa è basata su princìpi di non
violenza, di valorizzazione dei sentimenti e sul rispetto dei bisogni di tutti. Tutti i
bambini piangono per segnalare qualcosa di importante; tutti i bambini hanno
bisogno di stare in braccio per sentirsi avvolti e contenuti; tutti i bambini hanno
esigenze simili, indipendentemente dal paese in cui nascono e vivono. Si tratta di
bisogni e di comportamenti adattivi, cioè che rendono migliore l’adattamento del
soggetto all’ambiente in cui vive. Ma c’è di più. Riconoscere e rispondere
adeguatamente ai bisogni dei bambini li aiuterà a crescere psicologicamente sani
ed equilibrati, aumenterà la loro autostima e li agevolerà verso la conquista
dell’indipendenza.
Le culture orientali, per tradizione, considerano l’uomo in maniera “olistica”,
cioè nella sua interezza di mente e corpo. In occidente, invece, l’influenza dei
fattori emotivi, affettivi e relazionali implicati nella nascita e nella crescita dei
bambini è materia di studio da pochi decenni. È più usuale considerare la salute
del bambino soltanto come “assenza di malattia”, anziché come un insieme di
fattori psichici e rìsici in stretta correlazione fra loro nel determinare uno stato di
benessere.
Spesso, da noi, si condivide l’opinione secondo cui un bambino che piange o
reclama attenzione è soltanto un bambino viziato, capriccioso, furbo o noioso
che vuole distrarre l’adulto senza un motivo valido; come se i bisogni emotivi
dei bambini fossero trascurabili o, addirittura, come se ignorarli servisse al bebè
da palestra di vita per diventare grande, forte e indipendente. Nella nostra cultura
si sottovaluta la possibilità che il bimbo sia competente tanto nel sentire quanto
nel comunicare i propri bisogni; sembra cioè che i bambini siano “tabulae
rasae” su cui i genitori devono scrivere regole e princìpi educativi. Ormai ci
sono numerose prove del fatto che, già alla nascita, i neonati hanno competenze
chiare “in termini di comunicazione, di conoscenza dei loro limiti e delle loro
necessità, anche se spesso hanno bisogno di aiuto per tradurle in frasi
comprensibili. Ma anche se sanno esprimere le loro necessità e i loro limiti, non
sono in grado di difenderli da manipolazioni e violazioni da parte degli adulti.
Perciò dipendono dalla capacità e dalla disponibilità di chi si prende cura di loro
per riconoscere le proprie competenze e il diritto di prendersi le proprie
responsabilità personali”
2
.
Se i genitori si aspettano di trovare “manuali di istruzioni” per l’educazione
dei propri bambini, rischiano di entrare in un vortice che li distrarrà
dall’importanza della relazione con loro. Non c’è così tanto da imparare
dall’esterno, né alcun esperto o libro che si possa sostituire al ruolo genitoriale.
A questo proposito il pediatra e psicoanalista inglese Donald Winnicott afferma:
“La madre non può imparare a fare ciò di cui il bambino ha bisogno dai libri, né
dalle infermiere, né dai medici. Può darsi che abbia imparato molto dall’essere
stata a sua volta una bambina e anche dall’aver visto i genitori occuparsi di
bambini piccoli e dall’avere essa stessa preso parte alla cura dei fratellini minori
e, soprattutto, avrà imparato molte cose di importanza vitale giocando, in tenera
età, a papà e mamma. [La madre] deve sapere queste cose a un livello più
profondo e non necessariamente con quella parte della mente che dispone di
parole per tutto. Le cose fondamentali che una madre fa con il suo bambino non
si possono fare con le parole”
3
.
Oggi la normalità è invece quella di ricorrere all’esperto per qualsiasi cosa
riguardi i bambini. Non viene incoraggiata l’autonomia del genitore. Ci sono
libri, format televisivi, associazioni e siti web che promuovono la delega del
ruolo genitoriale tout court, come a dire: “Non vi preoccupate, vi insegniamo noi
un metodo per ogni cosa! Abbiamo la soluzione perfetta ai vostri problemi! Voi
non dovete fare nulla, ci pensiamo noi”. Per esempio, in un inquietante e
diffusissimo libro sul sonno dei bambini si ordina ai genitori: “Non fate nulla che
non sia scritto in questo libro”
4
. Affermazione che toglie al lettore ogni libertà di
scelta e di pensiero. Se i bambini imparano qualcosa da un metodo o da un
esperto, lo fanno grazie ad altri e non grazie ai propri genitori. Sembra che il
rapporto fra genitori e figli debba essere sempre mediato da qualcuno più
competente e autorevole di loro stessi.
Genitori e bambini, invece, sono competenti per portare avanti una sana
relazione reciproca nel rispetto dell’individualità di ognuno. Come potrebbe
essere altrimenti? Come è possibile che esistano metodi uguali per tutti che
riducono i bambini a oggetti? Jesper Juul, terapeuta familiare, afferma a questo
proposito: “Secondo i medici e i ricercatori è ormai tempo di cambiare il nostro
tipo di relazione nei confronti dei bambini, modificando il rapporto da
soggetto/oggetto a soggetto/soggetto”
5
.
Quindi, se partiamo dal presupposto che genitori e figli sono persone a tutti gli
effetti con diritti, bisogni e competenze, tutto sta nel trovare modalità di
educazione e convivenza che rispettino il più possibile ogni membro della
famiglia, indipendentemente dall’età. I genitori poi, attraverso il riconoscimento
delle proprie capacità e potenzialità, potranno avere più fiducia in se stessi e
meno necessità di ricorrere ai consigli degli esperti. Rivolgersi all’esterno non è
certo un problema o un segno di debolezza, ma credo che oggi sia diventato
necessario recuperare una cultura dell’individualità e dell’unicità di ogni
famiglia, per contrastare la tendenza dei genitori a delegare il proprio ruolo agli
esperti e a diventarne quindi dipendenti. Il problema nasce, per esempio, quando
un pediatra esce dal suo ruolo di medico che cura o previene le malattie e
comincia a dare indicazioni rigide al genitore circa le modalità di relazione e di
accudimento del bambino.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
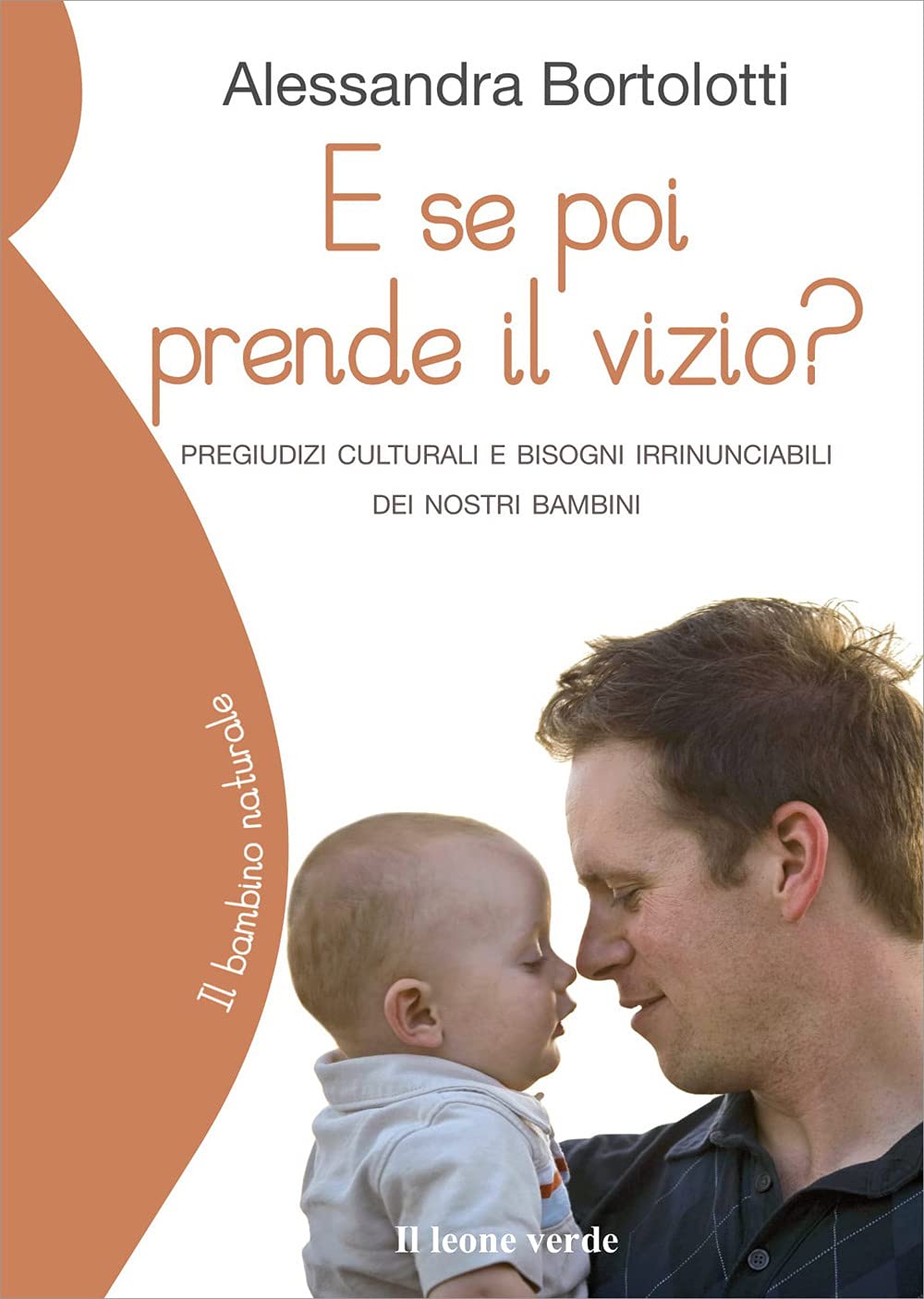






Commento all'articolo