Prima gli idioti – Bernard Malamud
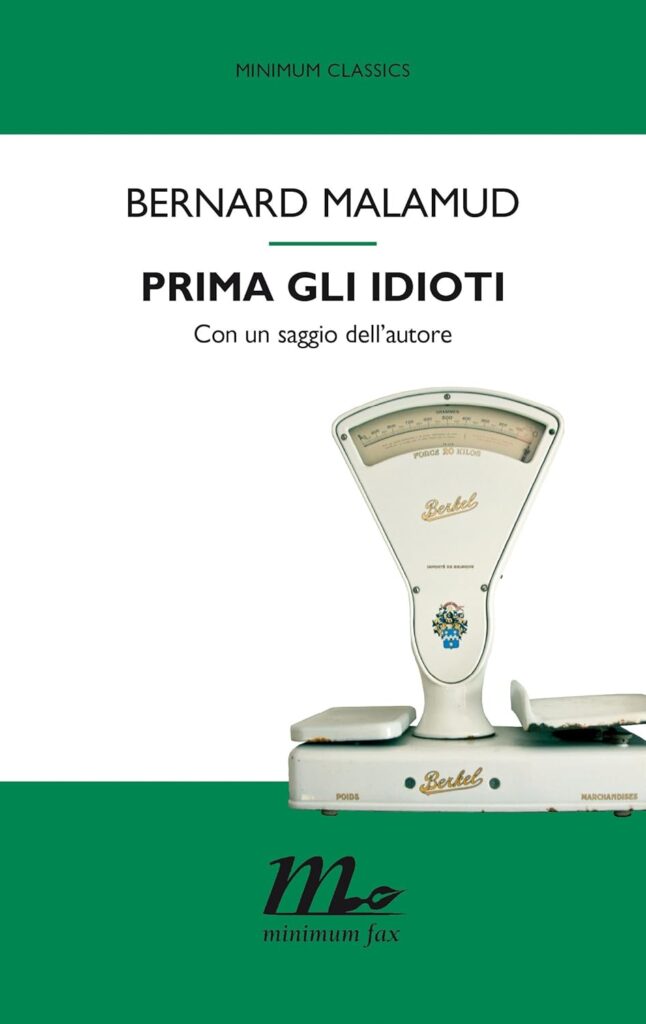
SINTESI DEL LIBRO:
Vorrei dire due parole a proposito della mia vita di scrittore. Visto
però che non posso certo riproporla per intero, quello che segue
sarà più una sorta di diario per sommi capi.
L’inizio fu lento, e forse non fu nemmeno un inizio. Alcuni inizi
promettono una partenza che poi può richiedere anni per dimostrarsi
tale. Prima che la tua prima parola finisca sulla pagina, o che ti
venga la prima idea decente, c’è un aspetto complicato: infrangere il
silenzio. C’è chi vomita prima di poter respirare. Non tutti riescono a
correre alla porta, quando bussa l’occasione... sempre che la
sentano bussare. Non tutti capiscono cosa significa. Semplicemente,
non sempre il dono del talento viene concesso in modo gratuito e
ben chiaro; c’è anche chi, pur appassionato alla scrittura con tutta
l’anima, magari deve passare metà della propria vita a scoprire
quale sia l’argomento più adatto per lui.
Io ho cominciato a scrivere da piccolissimo, eppure mi ci sono
voluti anni per cominciare a scrivere davvero. C’erano molte cose
che mi distraevano. Da bambino raccontavo storie per essere
apprezzato e andavo a cercare ispirazione al cinema. Ricordo che
mia madre, una domenica di pioggia, mi scaricò di malavoglia in una
sala cinematografica per vedere Charlie Chaplin, i cui film comici mi
pervadevano l’anima. Dopo essere stato al cinema raccontavo la
trama dei film ai compagni di scuola, che mi ascoltavano per un
tempo infinito, intanto che li ripercorrevo per filo e per segno. Il
piacere, all’inizio, era riraccontare storie impossibili.
A volte esageravo oppure al contrario svilivo una trama,
sostituendola con una mia. E sapevo essere un bugiardello di prima
classe, che ogni tanto trovava faticoso dire la verità. Una volta mio
padre mi disse che ero un imbroglione, facendomi arrabbiare molto
perché io ero partito per raccontargli una storia semplice, che poi si
era complicata da sola fino a diventare una bugia.
Alle elementari, periodo in cui vivevo uno stato esaltante di
scoperta continua, trasformavo i compiti in racconti. Una volta feci
sposare il teologo abolizionista Roger Williams del Rhode Island con
una ragazza indiana, principalmente perché avevo sviluppato un
precoce senso del romantico. A dieci anni, scrissi una storia su una
nave perduta nel Mar dei Sargassi. Il vascello compariva in sogno,
pronto a intraprendere un lungo viaggio in quei mari dalla calma
piatta. Era questa, per cominciare, la natura del mio «dono» da
bambino – me n’ero accorto un giorno – e rimase così per molti anni,
prima che cominciassi a saperlo usare bene. Per tutta la vita ho
lottato per raffinare quel dono, e per scrivere in maniera originale.
D’altro canto, una volta che mi aveva indicato e segnalato la via, mi
ha continuato a far avanzare anche quando non scrivevo. Per anni
quel dono fu una benedizione capace di sanguinare come una ferita.
Iniziò così un’epoca di lunga attesa. Avevo sperato di iniziare a
scrivere racconti dopo la laurea al City College, durante la
Depressione, ma faticavano a prender forma. Le idee le avevo, e mi
sembrava di essere pronto per iniziare a lavorarci tutto il tempo
necessario. Ma a quell’epoca non avevo mezzi regolari per
guadagnarmi da vivere; figlio di poveri (mio padre era un droghiere
che guadagnava poco), non sopportavo l’idea di vivere alle spalle di
una persona come lui, generosa e altruista. Pensavo però che la
scrittura sarebbe venuta da sé, una volta trovato un lavoro
continuativo. Mi servivano abiti decenti; sognavo completi di vestiti
nuovi. Ogni lavoro che avrei trovato poteva cambiarmi la vita,
pensavo, e avrei potuto iniziare a scrivere di giorno o di notte.
Eppure, rifiutavo recisamente, per un eccesso di orgoglio, di fare
domanda alla Works Progress Administration (il progetto
antidisoccupazione del New Deal rooseveltiano). Anni dopo, lo
considerai un atto – o meglio un atto mancato – sciocco.
Ho letto di recente la biografia di Kafka scritta da Ernst Pawel, in
cui l’autore parla dell’«obiettivo globale [di Kafka]: l’autore va in
cerca della propria verità». Verità o meno, mi sembrava che gli anni
passassero senza risultati. Di tanto in tanto scrivevo un racconto che
nessuno voleva acquistare. Mi definivo scrittore, anche se non avevo
un autentico argomento. Di tanto in tanto, però, sedevo a un tavolo e
scrivevo, anche se mi ci vollero anni perché i miei scritti mi
impressionassero favorevolmente.
A quel punto mi ero iscritto alla Columbia University, per seguire il
corso di Lettere, grazie a un prestito statale. Non era impegnativo.
Mi continuavo a ripetere che facevo qualcosa di valido: infatti,
nessuno che passi giorni e notti a dedicarsi ai grandi classici della
letteratura sta sprecando tempo come scrittore, se ha la passione
della scrittura. Ma quando pensavo di cominciare a scrivere? La mia
risposta era sempre la stessa: una volta trovato un lavoro che mi
permettesse di alimentare il mio vizio, soddisfacendo i bisogni
permanenti della persona. Mi iscrissi al concorso per diventare
insegnante e in seguito lavorai per un anno come tirocinante in un
liceo di Brooklyn, a 4 dollari e mezzo al giorno. Mi iscrissi anche, e
partecipai, a diversi concorsi statali, compresi quelli per un posto da
sportellista o portalettere. È una follia, pensai, oppure sono matto io.
In ogni caso mi ripetevo che non importava quale lavoro avrei
trovato, a patto che lavorassi per avere il tempo di scrivere. Per tutti
quegli anni grami, scrivere era ancora il mio dono e la mia
convinzione.
Erano passati quattro anni dalla laurea, ma a soffermarcisi
sembravano cinquanta. In ogni caso, nella primavera del 1940 mi
offrirono un posto a Washington, come impiegato dell’Anagrafe
Federale. Accettai subito, anche se scoprii ben presto che il «lavoro»
era una bazzecola. Ogni mattina controllavo minuziosamente le
stime sulle statistiche relative ai canali di scolo, i cui dati si riferivano
a diverse contee degli Stati Uniti. Anche se non era certo un lavoro
entusiasmante, lo svolgevo con diligenza e alla fine dei primi tre
mesi venni promosso, con uno stipendio di 1800 dollari l’anno. A
quell’epoca, erano «bei soldi». La parte migliore era che avevo
iniziato a scrivere seriamente negli orari di lavoro. A nessuno
sembrava importare cosa facessi, bastava che i registri mostrassero
che avevo svolto un’intera giornata di lavoro; perciò, dopo pranzo, mi
mettevo alla scrivania a testa china, e scrivevo racconti.
Una notte, dopo aver faticato invano per ore nel tentativo di dar
vita a un racconto, mi misi a sedere sul letto con la finestra aperta e
guardai le stelle dopo un temporale. Provai un’ondata di sensazioni,
di emozioni provenienti dal cuore, prova di una dedizione alla vita e
all’arte così profonda che mi fece salire le lacrime agli occhi. Per la
centesima volta mi ripromisi che un giorno sarei diventato uno
scrittore davvero bravo. Questo rinnovato entusiasmo, e altri episodi
simili, mi tennero vivo nell’arte negli anni prima che riuscissi a
realizzare qualcosa. Dovevo averne circa venticinque allora, e
aspettavo ancora, a modo mio, che la mia vera vita di scrittore
cominciasse. Mi ricordavo dell’affermazione di Kafka, all’incirca alla
stessa età: «Dio non vuole che io scriva, ma io devo scrivere».
C’erano altri aspetti da considerare. Il matrimonio, per esempio:
dovevo, non dovevo? A volte mi sembrava che i giovani scrittori miei
conoscenti fossero troppo preoccupati di evitare il matrimonio,
mentre avrebbero potuto usarlo, tra le altre cose, per mettere ordine
nella vita e procedere con il lavoro. Mi chiesi se non potevo renderlo
un’appendice necessaria della mia scrittura. Ma la vita matrimoniale
non era facile: non avrebbe nociuto alla mia carriera se mi fossi
avviato in un percorso di cui non potevo essere del tutto sicuro? Chi
ha un dono – chi l’ha ricevuto – farebbe bene a proteggerlo da chi
sembra non avere uno scopo impellente nella vita. Molte giovani
donne che incontravo non avevano un’idea chiara di cosa fare nella
vita. Se una donna del genere diventava la moglie di uno scrittore,
sarebbe stata in grado, per esempio, di capire cosa succedeva nei
suoi pensieri mentre lavorava nel sonno? Avrebbe fatto la sua parte
per mandare avanti la famiglia?
Mi ponevo spesso queste domande e altre simili, anche se non
sapevo esattamente chi potesse darmi una risposta. E passavo
troppo tempo a essere innamorato, come modo scomodo di stare
bene quando non scrivevo. Avevo bisogno di una donna da amare e
con cui vivere, ma non facevo sforzi immani per trovarla.
Nel frattempo, mi trovai un lavoro in una scuola serale, nel
settembre del 1940. Poi completai la tesi di laurea di secondo livello
e cominciai a pensare a un romanzo. Fino a quel momento avevo
ultimato una dozzina di racconti, alcuni dei quali cominciavano a
comparire sulle riviste trimestrali dell’università. Uno di questi, «The
Place Is Different Now», fu il precursore del Commesso. E il
romanzo che avevo iniziato a scrivere mentre insegnavo alla scuola
superiore serale Erasmus Hall di Brooklyn si intitolava The Light
Sleeper. Lo terminai ma non riuscii a venderlo. In seguito, una notte
nell’Oregon, lo bruciai perché mi sembrava di poter fare di meglio.
Mio figlio, che all’epoca aveva quattro anni, mi guardò bruciare il
libro. Mentre osservavamo le scintille salire verso l’alto, gli parlavo
della morte; ma lui rifiutava l’idea. Diversi anni prima, non molto
dopo Pearl Harbor, mentre insegnavo di sera e scrivevo il romanzo,
a una festa avevo incontrato una ragazza carina e calorosa. Mi
dissero che era di origine italiana, e viveva in un albergo con la
madre e il patrigno, un musicista. Osservai la mia futura moglie per
un po’, prima che iniziassimo a parlare.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
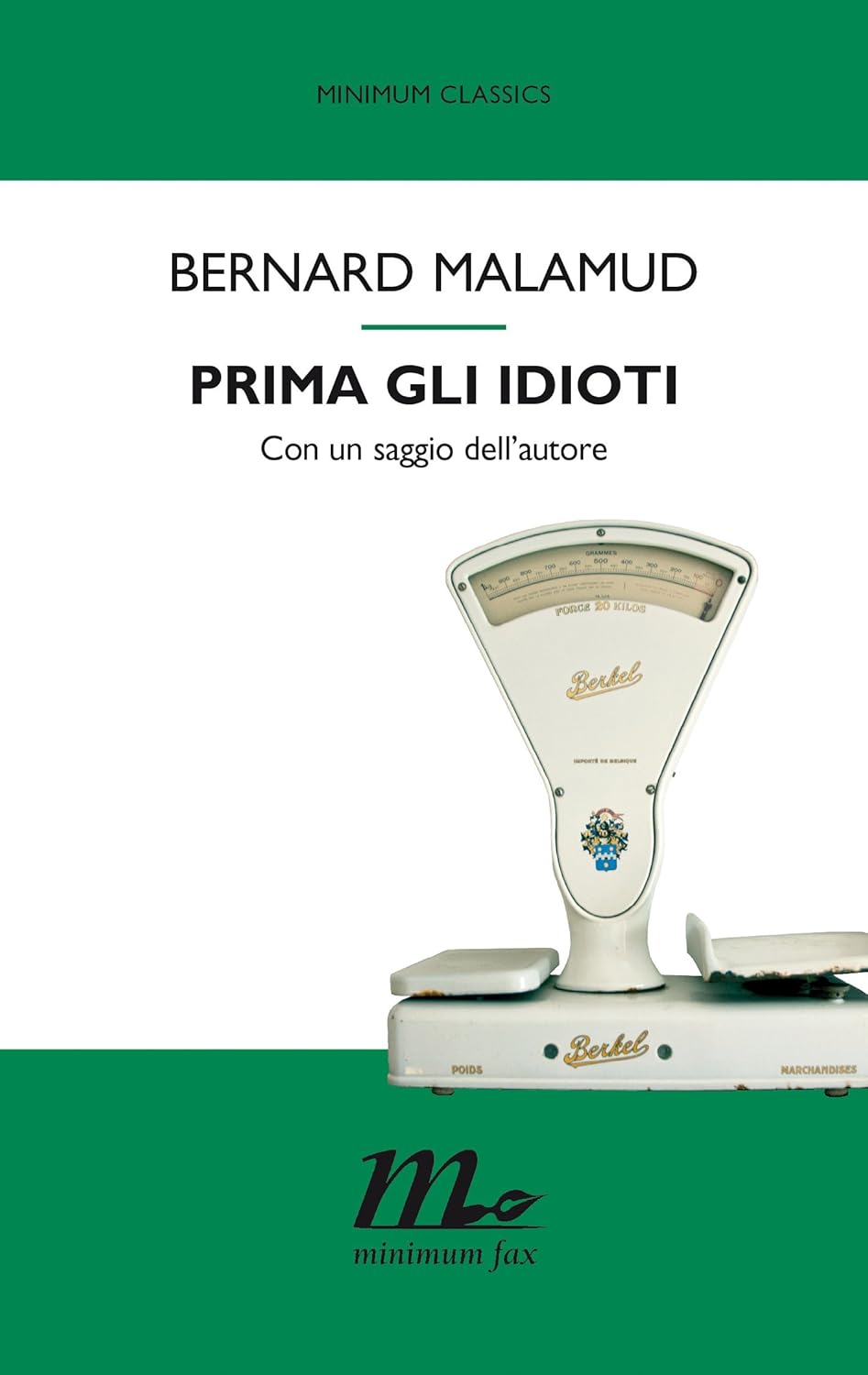





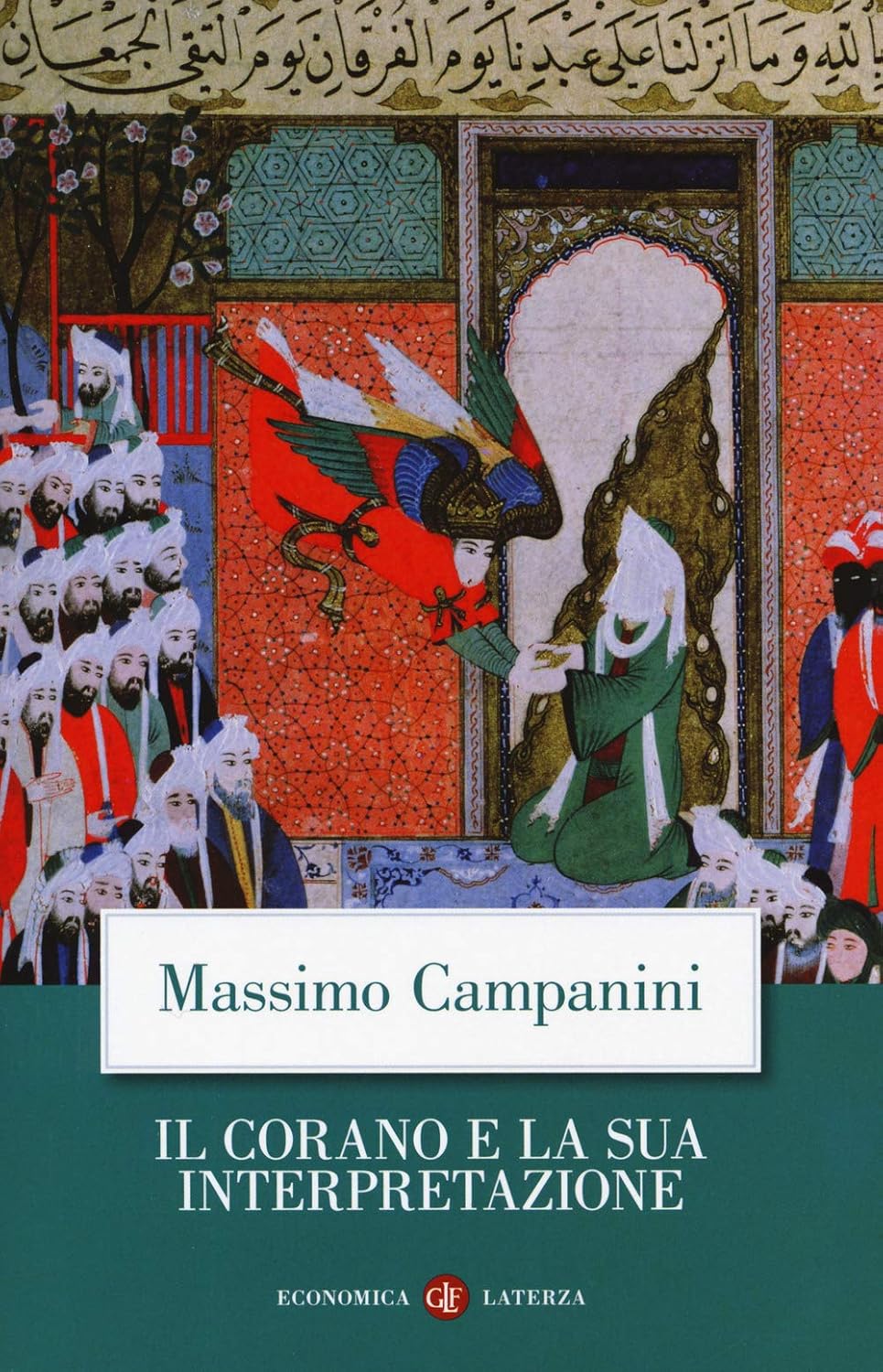
Commento all'articolo