Noi terroristi- Giorgio Bocca
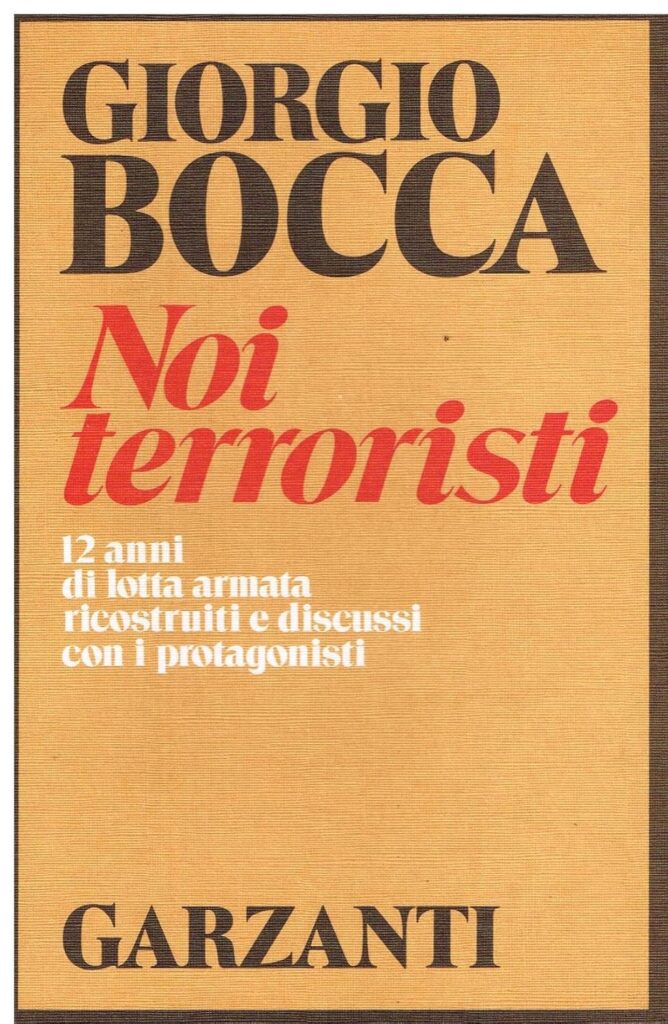
SINTESI DEL LIBRO:
La lotta armata. Ma perché negli anni Settanta?
Un quando preciso, una dichiarazione di guerra datata, non
esistono.
Esiste il fiume carsico della violenza che riemerge questa volta
contro il potere statuale, della borghesia d'ordine.
«Noi, figli del Pci», dice Alberto Franceschini, «la lotta armata
l'avevamo ripresa già negli anni Sessanta: irruzioni notturne nelle
fabbriche in serrata, scritte spray sui muri, qualche rivoltella, qualche
molotov, il canto di guerra per i morti di Reggio Emilia. Il convegno di
Chiavari alla Stella Maris, del novembre '69, non è decisivo. Si parla
anche di lotta armata, ma senza formalizzarla. Se proprio vuoi un
nome, una data, andiamo ai primi del '70, al convegno di Pugliarello,
vicino a Reggio Emilia. Semeria dice Pecorile? Sono due frazioni
vicinissime: c'eravamo noi di Nuova resistenza, anticamera delle BR,
quelli del Superclan di Berio e di Simioni, alcuni superstiti dei
gruppi». Tonino Paroli, altro BR «storico», conferma e spiega: «Sì, il
convegno di Pugliarello ci fu, ma alla lotta armata arrivammo in
progressione. Nel Collettivo politico metropolitano si parla già di
clandestinità, poi con Nuova resistenza discutiamo di illegalità
organizzata e di autodifesa armata. Insomma chi aveva alzato la mano
al Collettivo politico metropolitano per approvare la clandestinità
passa alla lotta armata».
Sì, ma perché negli anni Settanta e non prima? Perché non nei
giorni tesi della guerra fredda, della dura migrazione, della repressione
vallettiana, dell'umiliazione operaia, della arroganza clericale? I
protagonisti né sanno né vogliono dare una risposta unica, schematica.
Procediamo, assieme, per riflessioni, illuminazioni improvvise, trame
che emergono dalle acque torbide delle memorie e della delusione.
Enrico Fenzi, professore di letteratura italiana, è uno dei rari
intellettuali arrivati alle Brigate rosse. Gli chiedo di affrontare l'ipotesi
della doppiezza e del radicalismo, e dice: «Potremmo tornare ai famosi
"limiti" del risorgimento e poi della resistenza e del Pci, diciamo della
nazione e della rivoluzione mancate, della convivenza del vecchio con
il nuovo. Ma per la lotta armata mi viene un'immagine attuale, fisica,
da scissione nucleare: la doppiezza del Partito comunista che si spezza
negli anni Settanta sotto il peso della grande trasformazione e libera
energie radicali, estremiste.
Negli anni Settanta il Pci non può più coprire con la sua doppiezza
le due anime del partito, la riformista e la rivoluzionaria, deve farsi
stato, diventare difensore delle istituzioni, stare dalla parte dei
carabinieri, dare via libera all'estremismo. A questo punto la domanda
"perché hai scelto la lotta armata?" può avere questa semplice
risposta: "perché io ero quella scelta" o anche "perché in quella scelta
ho riconosciuto chi ero, da sempre". C'è qualcuno che sappia davvero
spiegare quel che si è e perché lo si è? Le BR sono lotta armata, non
hanno cercato altra formula, altra ragion d'essere.
La lotta armata per le BR non era una forma della politica, ma la
politica. Anzi il solo modo per uscire dalla non politica del Pci e della
sinistra ufficiale, il solo modo per spezzare la paralisi partitocratica.
Vedi, l'esamino di ingresso delle BR si basava su questo: ti
avvicinavano, ti conoscevano e ti mettevano alla prova della lotta
armata».
Non è che tutti i protagonisti riescano a pensare la scelta estremista
come qualcosa che attendeva nel profondo di ciascuno di essi e della
nostra storia politica, ma l'inspiegabile e il misterioso della sua
rivelazione ancora li insegue.
«Io», dice Alberto Franceschini, «non ho ancora risolto il mistero
della lotta armata così come l'abbiamo pensata nel '70, cioè
rivoluzione o guerriglia di lunga e lunghissima durata. Un giorno ne
parlavo a Lazagna, lui mi ascoltava paziente poi alla fine diceva:
"Va bene, fate pure, io intanto vado a pesca. Mi sembrate dei matti.
Noi partigiani abbiamo resistito a stento un anno ed era una guerra
dichiarata, popolare, con scadenze prevedibili. E voi volete andare
avanti venti anni?»». La ragionevolezza, il buon senso! Ma in che
misura li possiede chi li pretende da una miscela esplosiva? E che altro
era, per i giovani, quella stagione? Dice Lapo Berti, lo studioso: «In
quegli anni c'è stata una politica che non era la politica, ma una sua
negazione radicale. Un serpeggiare di aspirazioni deluse, di bisogni
compressi, di soggettività ingabbiate, che di colpo confluiscono
nell'onda di piena».
Torna l'immagine di Fenzi, la scissione dirompente, la lotta armata
come un effetto quasi fisico di temperature sociali non più sopportabili
dall'ordinaria amministrazione parlamentare e sindacale.
Sì, forse. Ma poi si cerca di capire meglio, di trovare le ragioni
ragionevoli, a cominciare dalla violenza che chiama violenza. «Quegli
anni», dice ancora Franceschini, «furono oggettivamente violenti,
furono gli anni della criminalità di massa. Noi non siamo nati come
risposta al golpismo più o meno velleitario dei Sogno e dei Miceli, anzi
abbiamo criticato l'ossessione antigolpista di Feltrinelli. Ciò non toglie
che quel periodo era caratterizzato dalla cultura della violenza. Non
eravamo solo noi a pensare a una conquista violenta dello stato, ci
pensava anche una parte della borghesia, della classe dirigente». Il più
attento, fra i brigatisti «storici» o fondatori, alle ragioni ragionevoli è
certamente Renato Curcio. «Tu mi chiedi», dice, «perché la lotta
armata negli anni Settanta e non prima. Io partirei un po' da lontano,
dalle molte correnti che confluirono nella nostra scelta. Erano gli anni
del Vietnam del "vince chi spara", delle megamanifestazioni in cui si
incontravano compagni rivoluzionari di tutti i continenti; del Che e
della sua paradossale sconfitta militare, da cui il ripensamento
strategico che sfocia nella guerriglia urbana, brasiliana prima,
tupamara poi. Il tempo della rivoluzione culturale delle guardie rosse.
Chi, giovane, restò insensibile a tutto ciò, non può far testo per quegli
anni. Veniamo all'Italia. La classe operaia lottava per uscire da una
"ricostruzione" impastata di fatiche, discriminazioni politiche, bassi
salari. L'operaio massa andava allo scontro. Era il suo canto del cigno,
ma allora chi lo sapeva?».
Il punto chiave, la cerniera di questa storia, così come andiamo
scrivendola, è il confronto continuo fra ciò che abbiamo capito con la
scienza di poi e ciò che si pensava e si faceva allora: fra l'angoscia della
transizione che oggi sembra dominante e il giorno per giorno della
sovversione giovanile che crede, si sforza di credere nella rivoluzione
in marcia. In quel giorno per giorno la necessità della lotta armata
diventa ragionamento elementare, conseguenza inevitabile della
pratica dei «passaggi». I giovani che cercano di fare, di cambiare, di
incidere alla loro maniera vagante e sperimentale - oggi l'occupazione
delle case, domani una manifestazione di piazza o uno scontro con i
fascisti o un'autoriduzione - si rendono conto che la concorrenza con il
Pci e con il sindacato sul terreno delle riforme è perduta in partenza.
Ma Pci e sindacato sono perdenti, tagliati fuori dalla lotta armata. E
allora quale altro progetto se non quello di cui parla il piellino
Massimo Libardi, «proporsi come strutture di servizio, militari e
organizzative della rivoluzione operaia»?SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
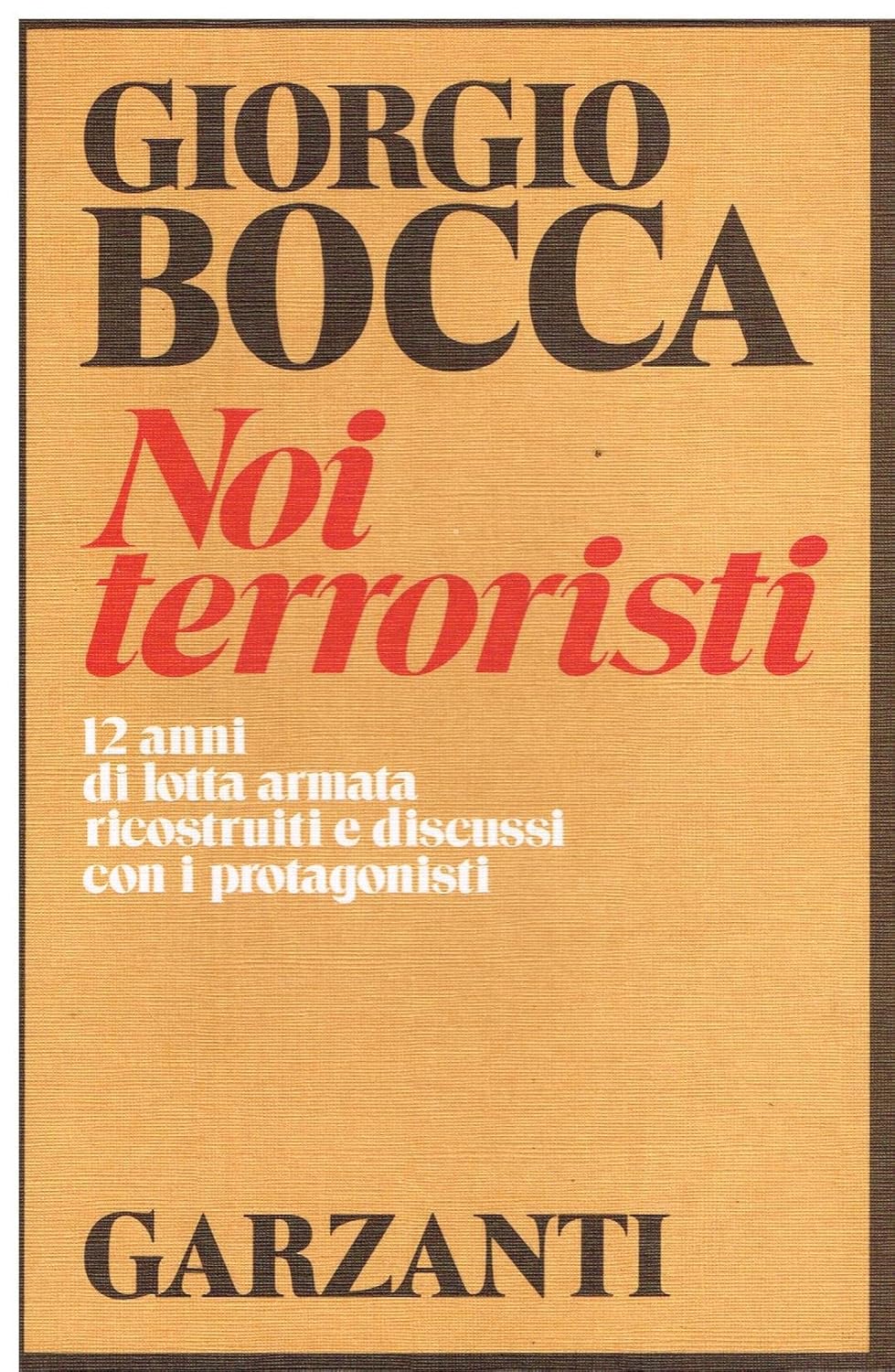






Commento all'articolo