Eroi: Lo scudo di Talos – Le paludi di Hesperia – L’armata perduta – Massimo Manfredi

SINTESI DEL LIBRO:
PARTE PRIMA
Ospite, quello che deve accadere per volere del dio, difficile è per
l’uomo stornarlo e la peggiore delle pene umane è proprio questa: prevedere
molte cose e non avere su di esse alcun potere.
ERODOTO
I
TAIGETO
Con il cuore pieno di amarezza sedeva il grande Aristarchos e guardava il
figlioletto Kleidemos dormire tranquillo nel grande scudo paterno che gli
fungeva da culla. E dormiva poco distante, in un lettino appeso al soffitto il
maggiore, Brithos.
Il silenzio che avvolgeva l’antica casa dei Kleomenidi era rotto d’un
tratto dallo stormire delle querce nel bosco vicino. Un lungo, profondo
sospiro del vento.
Sparta, l’invincibile, era avvolta dalla notte e solo il fuoco che ardeva
sull’acropoli mandava bagliori rossastri verso il cielo percorso da nubi nere.
Aristarchos si scosse con un brivido e andò ad aprire l’impannata gettando
uno sguardo nella campagna addormentata e scura.
Pensò che era giunto il momento di compiere ciò che doveva se gli dei
nascondevano la luna e oscuravano la terra, se le nubi nel cielo erano gonfie
di pianto.
Staccò il mantello dalla parete gettandoselo sulle spalle poi si chinò sul
figlioletto, lo sollevò, lo serrò piano al petto e si avviò con passo leggero
mentre la nutrice del piccolo si girava nel sonno tra le coperte.
Aristarchos si fermò restando immobile per un attimo, sperando in cuor
suo che qualcosa gli consentisse di rimandare ancora quell’azione tremenda
poi, udito di nuovo il pesante respiro della donna, si fece forza, uscì dalla
camera attraversando l’atrio appena rischiarato da una lucerna di coccio. Si
affacciò sul cortile investito da una folata di vento freddo che quasi spense la
fiammella già fioca e mentre si girava per richiudere la pesante porta di
rovere vide ritta davanti a sé, come una divinità della notte, sua moglie
Ismene, pallida, gli occhi scuri lucidi e sbarrati.
Un’angoscia mortale era dipinta sul suo volto: la bocca, contratta come
una piaga dolente, sembrava serrare una pena disumana.
Aristarchos si sentì gelare il sangue nelle vene; le gambe possenti come
pilastri si fecero di giunco.
«Non per noi...» mormorò con la voce rotta. «Non per noi l’abbiamo
generato... Doveva essere questa notte o non avrei più trovato la forza...»
Ismene protese la mano verso il piccolo involto mentre i suoi occhi
cercavano quelli del marito... Il piccolo si svegliò e si mise a piangere e
Aristarchos si slanciò allora all’esterno fuggendo nella campagna. Ismene,
ritta sulla soglia restò a guardare per qualche tempo l’uomo che correva,
ascoltando il pianto sempre più debole di suo figlio: il piccolo Kleidemos che
gli dei avevano colpito quando era ancora nel suo ventre facendolo nascere
storpio, condannandolo a morte, secondo le leggi implacabili di Sparta.
Richiuse la porta e si diresse lentamente verso il centro dell’atrio
fermandosi a guardare le immagini degli dei a cui aveva portato offerte
generose per tutto il tempo della sua attesa e che aveva tanto pregato, per
lunghi mesi, perché infondessero vigore in quel piedino rattrappito, invano.
Si sedette sul focolare al centro della grande camera spoglia, sciolse le
trecce nere tirandosi i capelli sulle spalle e sul petto poi, raccolta la cenere
alla base del tripode di rame, se la versò sul capo. Alla luce tremolante della
lucerna le statue degli dei e degli eroi kleomenidi la fissavano con
l’immutabile sorriso scolpito nel legno di cipresso. Ismene sporcava di cenere
i bei capelli, si graffiava il volto fino a farlo sanguinare mentre il suo cuore si
chiudeva in una morsa di gelo.
Aristarchos correva intanto nella campagna, le braccia strette al petto, il
mantello che gli vorticava intorno sferzato dal fiato di Borea.
Arrancava su per la montagna aprendosi la via tra i rovi e i cespugli del
bosco mentre forme spaventose si animavano sul terreno al balenare
improvviso dei lampi. Gli dei di Sparta erano lontani in quel momento di
amarezza suprema: ora egli doveva avanzare solo tra le presenze oscure della
notte, tra le creature maligne del bosco che insidiano il passo ai viandanti e
portano gli incubi dal ventre cavo della terra.
Trovò il sentiero all’uscita di un macchione, si fermò un momento,
ansante, a riprendere fiato. Il piccolo non piangeva più, si sentiva solo agitare
le piccole membra dentro l’involto, come un cucciolo, chiuso in un sacco, che
sta per essere gettato nel fiume.
Il guerriero alzò lo sguardo al cielo pieno di nubi gigantesche, forme
scarmigliate, minacciose... Mormorò tra i denti antiche formule di scongiuro
e si avviò per il sentiero erto mentre le prime gocce di pioggia si spegnevano
nella polvere con piccoli tonfi sordi. Attraversata la radura si immerse di
nuovo nella macchia. I rami e gli sterpi gli graffiavano il volto che le mani
non potevano proteggere; la pioggia era ormai fitta, pesante, cominciava a
penetrare tra le frasche rendendo molle e scivoloso il terreno. Aristarchos
cadeva sulle ginocchia e sui gomiti sporcandosi di fango e del marciume
delle foglie morte o lacerandosi sui ciottoli appuntiti che sporgevano qua e là
dal sentiero sempre più erto e stretto. Con un ultimo sforzo raggiunse il primo
dei cocuzzoli boscosi della montagna e si addentrò in un boschetto di querce
che si ergeva in mezzo a uno spiazzo invaso da una vegetazione fitta e bassa
di cornioli, di razze, di ginestre.
La pioggia era diventata scrosciante; Aristarchos, coi capelli incollati
sulla fronte, gli abiti fradici, camminava ora lento e sicuro sul muschio molle
e odoroso. Si arrestò davanti a un leccio secolare dal gran tronco cavo, si
inginocchiò fra le radici e depose il suo fardello nella cavità. Stette un attimo
a guardare il figlio che agitava le piccole mani fuori dalla coperta,
mordendosi a sangue il labbro inferiore, sentì l’acqua scorrergli lungo la
spina dorsale, a fiotti, ma la bocca era secca, la lingua, come un pezzo di
cuoio, attaccata al palato. Ciò che si doveva fare era fatto, gli dei avrebbero
compiuto il destino. L’ora di tornare era giunta, era giunto il momento di
soffocare per sempre la voce del sangue e il grido del cuore. Si alzò
lentamente, faticosamente, come se tutto il dolore del mondo gli gravasse sul
petto e se ne andò donde era venuto.
Il temporale sembrava placarsi mentre Aristarchos scendeva le balze del
Taigeto e una nebbia leggera emanava dalle viscere della montagna,
diffondendosi fra i tronchi secolari, sommergendo i cespugli grondanti,
strisciando sui sentieri e sulle radure. Il vento soffiava ancora a tratti, con
brevi raffiche facendo scrosciare l’acqua dalle fronde. Finalmente, lasciata la
foresta, Aristarchos riuscì nella pianura e si fermò un momento volgendo lo
sguardo alle cime della montagna. Davanti a sé, nella campagna umida, vide
scintillare le acque dell’Eurota illuminato a tratti dai raggi freddi della luna
che ora si mostrava in uno squarcio tra le nubi. Mentre stava per imboccare il
ponticello di legno sul fiume sentì un rumore provenire dalla sua sinistra: si
volse di scatto e al chiarore incerto della luna vide davanti a sé un cavaliere, il
volto nascosto dalla celata, ritto sull’animale madido e fumante. Sulla corazza
brunita balenò per un istante l’insegna della guardia reale: “Sparta... Sparta
già sapeva...”. Un colpo di talloni, un’impennata e il galoppo si perse col
vento lontano, nei campiSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
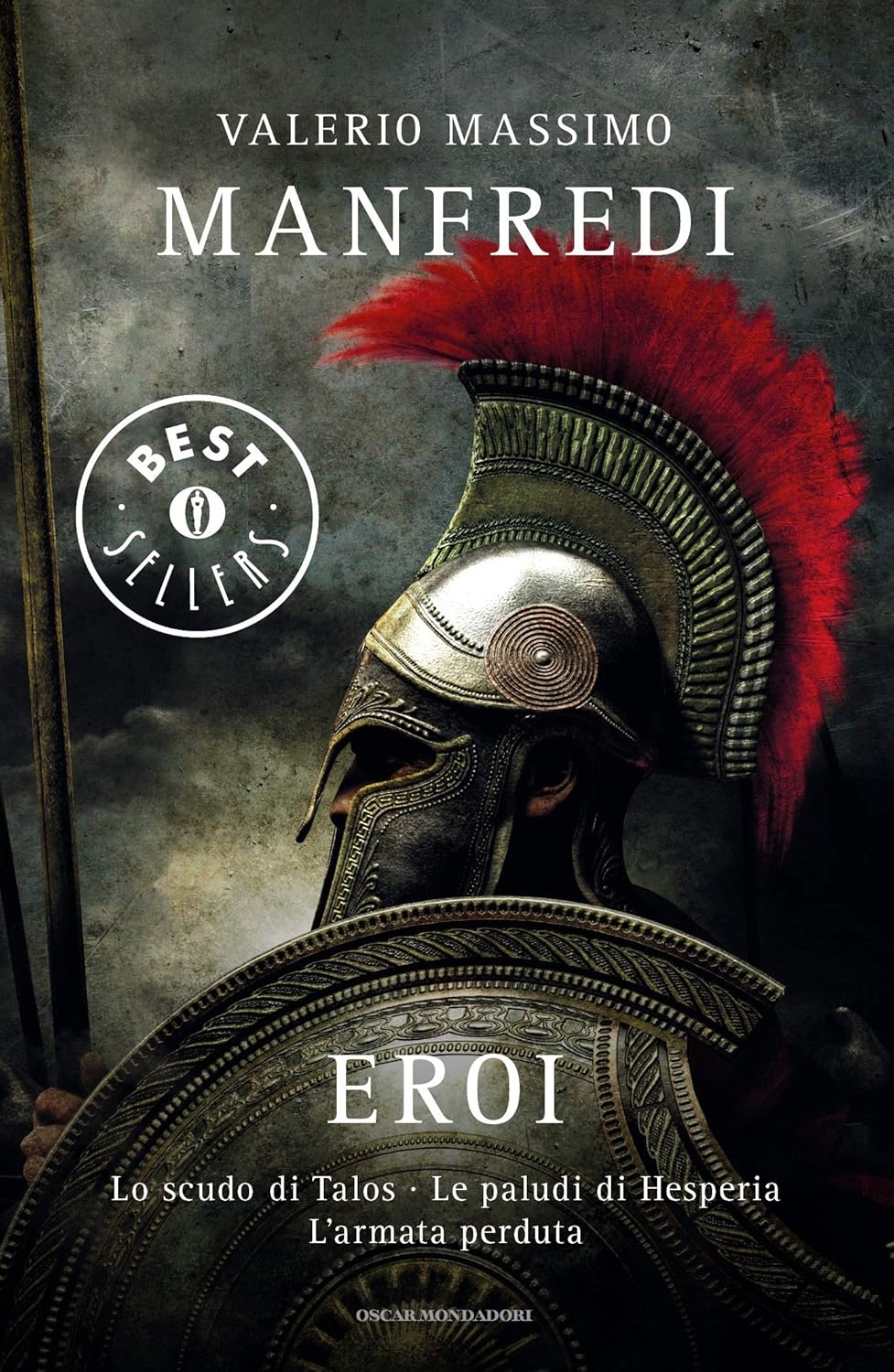






Commento all'articolo