Fascimo storia ed interpretrazione – Emilio Gentile

SINTESI DEL LIBRO:
Introduzione.
È esistito il fascismo?
Forse il fascismo non è mai esistito.
Anonimo del XXI secolo
È una storia strana e singolare, la storia del fascismo.
Dopo quasi novanta anni dalla sua comparsa nella storia e dopo oltre mezzo
secolo dalla sua scomparsa come protagonista dell’attualità politica, il
fascismo sembra essere ancora un oggetto alquanto misterioso, che sfugge
alla cattura di una chiara e razionale definizione storica, nonostante le decine
di migliaia di libri e di articoli e di dibattiti, che sono stati, e tuttora
continuano a essere dedicati a questo movimento politico del XX secolo.
Strana e singolare è anche la storia delle interpretazioni del fascismo. Infatti,
queste interpretazioni oscillano fra visioni tanto opposte e inconciliabili fra
loro, da far ritenere talvolta vana la speranza che si possa mai giungere a
definire la natura del fascismo in termini che siano largamente condivisi.
«Alla fine del XX secolo – scriveva nel 1995 Stanley G. Payne, uno dei
maggiori studiosi del fenomeno fascista – fascismo rimane probabilmente il
più vago tra i termini politici più importanti»
1
.
Mussolini e il Partito fascista conquistarono il potere con la “marcia su
Roma” il 28 ottobre 1922: da ottanta anni, dunque, si continua a discutere
ancora animatamente su questioni che riguardano la natura del fascismo e il
suo significato nella storia contemporanea: se fu un movimento autonomo o
uno strumento di altre forze, se ebbe una ideologia e una cultura, se fu
moderno o antimoderno, se fu rivoluzionario o reazionario, autoritario o
totalitario. Non c’è accordo neppure sulla collocazione del fascismo nel
tempo e nello spazio: si discute ancora su dove e quando è nato; se è stato un
fatto unicamente italiano oppure universale; se si deve parlare di “fascismo”,
cioè di un unico fenomeno con tante varianti, come rami di uno stesso albero,
oppure di “fascismi”, come di alberi differenti con alcune caratteristiche in
comune; se c’è stata una “epoca del fascismo”, cronologicamente definita,
oppure se c’è un “fascismo eterno”, le cui tracce potrebbero risalire fino a
Caino, e che tuttora incombe sull’esistenza umana, come un pericolo
imminente e reale.
Attorno al fascismo, insomma, si è formata una sorta di “questione
omerica”, espressione con la quale si suole definire «il complesso dei
problemi che riguardano l’esistenza storica di un poeta Omero». Come per il
poeta greco, infatti, anche per il fascismo non solo ci sono pareri contrastanti
sul luogo e sulla data di nascita, ma si mette in dubbio anche la sua stessa
esistenza. Questa viene di fatto contestata da chi afferma che il fascismo non
è stato un movimento politico autonomo, con una sua ideologia, una sua
cultura, un suo sistema politico, come il liberalismo o il comunismo, ma è
stato solo un epifenomeno, cioè la secrezione contingente ed estrema di altri
fenomeni, come la reazione antiproletaria della borghesia, la malattia morale
della coscienza europea, la degenerazione patologica della società di massa,
l’esplosione di difetti secolari di popoli ancora immaturi per la democrazia
liberale. Di conseguenza, il fascismo, secondo questo modo di vedere,
sarebbe una totale negatività storica, e quindi privo di una propria realtà
autonoma e specifica, che possa essere definita concettualmente. Qualche
studioso ha proposto di mettere al bando dalla comunità scientifica il concetto
di “fascismo”, perché non avrebbe alcun significato preciso, corrispondente a
un fenomeno storico reale. Con lo stesso argomento, altri studiosi hanno
chiesto l’adozione di un eguale provvedimento per il concetto di
“totalitarismo”.
L’abbinamento del totalitarismo al fascismo in una comune richiesta di
messa al bando dalla comunità degli studiosi non è casuale. Infatti, il concetto
del “totalitarismo” è nato storicamente all’indomani della “marcia su Roma”
in simbiosi con il fascismo e in riferimento al fascismo, quando i termini
“totalitario” e “totalitarismo” furono inventati dagli antifascisti per definire la
vocazione dittatoriale e integralista del Partito fascista e il sistema di dominio
terroristico e demagogico che il fascismo aveva messo in pratica, subito dopo
la conquista del potere, per affermare il suo predominio assoluto. Con questo
significato, il termine “totalitarismo” venne poi applicato dagli antifascisti,
prima che dai fascisti, per definire il regime fascista. Contro questa
interpretazione, sulla base di successive teorie del totalitarismo, costruite da
alcuni politologi esclusivamente sul modello del nazismo e dello stalinismo, è
stato perentoriamente sentenziato che il totalitarismo fascista non è mai
esistito. E ancor più drasticamente, qualche altro studioso ha affermato che
storicamente non è esistito nessun totalitarismo. Non è da escludere, se
dovesse diffondersi questa tendenza, che in un futuro prossimo sentiremo
qualche storico o politologo revisionista, postmodernista o decostruzionista,
venirci a dire che neppure il fascismo è mai esistito.
L’ipotesi ora avanzata è solo apparentemente paradossale. Essa, infatti,
sembra già avviata a concretizzarsi nel caso del fascismo italiano. Nei
confronti di quest’ultimo, infatti, è da tempo in corso una tendenza alla
“defascistizzazione” retroattiva: essa consiste nel togliere al fascismo gli
attributi che gli furono propri e che ne caratterizzarono l’individualità storica.
La “defascistizzazione” del fascismo si manifesta in varie forme: negando,
per esempio, che vi sia stata un’ideologia fascista, una cultura fascista, una
classe dirigente fascista, un’adesione di massa al fascismo, un totalitarismo
fascista e perfino un regime fascista. Qualche studioso, infatti, ha affermato
che il regime di Mussolini non fu veramente fascista ma “semifascista”. Dalla
tendenza alla “defascistizzazione” del fascismo, viene emergendo una
rappresentazione alquanto indulgente, se non proprio benevola,
dell’esperienza fascista: una vicenda più comica che tragica, una sorta di
istrionica farsa di simulazione collettiva, recitata per venti anni dagli italiani,
sotto una dittatura personale, blandamente autoritaria, che tutto sommato non
avrebbe fatto gran danno all’Italia, fino a quando non fu traviata dalla
Germania nazista, che le inoculò il razzismo e l’antisemitismo, e la condusse
sulla via della perdizione.
La forma più diffusa di “defascistizzazione” del fascismo si manifesta con
la riduzione del fascismo al mussolinismo, cioè alla vicenda politica del duce.
Ad essa si affianca la tendenza a “svuotare” il fascismo degli stessi fascisti,
sostenendo che la massima parte di coloro che furono iscritti al Partito
fascista, si dichiararono pubblicamente fascisti, occuparono posti di potere e
di prestigio nelle istituzioni politiche, culturali ed economiche del regime,
non era in realtà veramente fascista, come non lo era la massa degli italiani
che affollavano le piazze per acclamare il duce e le sue gesta. Secondo questa
tendenza, non sarebbero stati veramente fascisti neppure un Giuseppe Bottai,
un Dino Grandi, un Luigi Federzoni, un Alberto De Stefani, cioè personaggi
che furono ai vertici del regime fascista dall’inizio alla fine, e che sempre
pubblicamente professarono la loro fede nel fascismo e nel suo duce.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
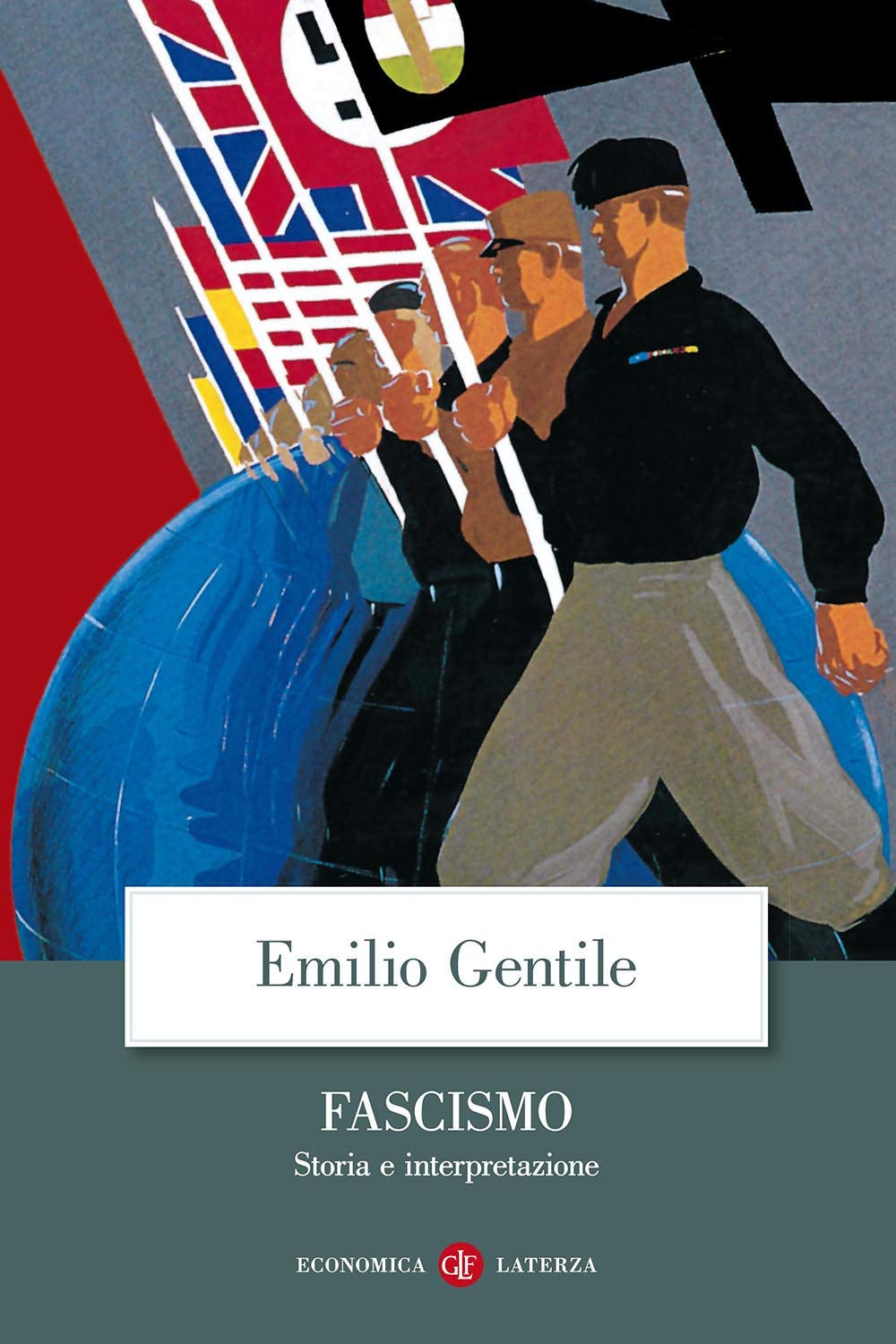






Commento all'articolo