Il lupo e il filosofo: Lezioni di vita dalla natura selvaggia – Mark Rowlands
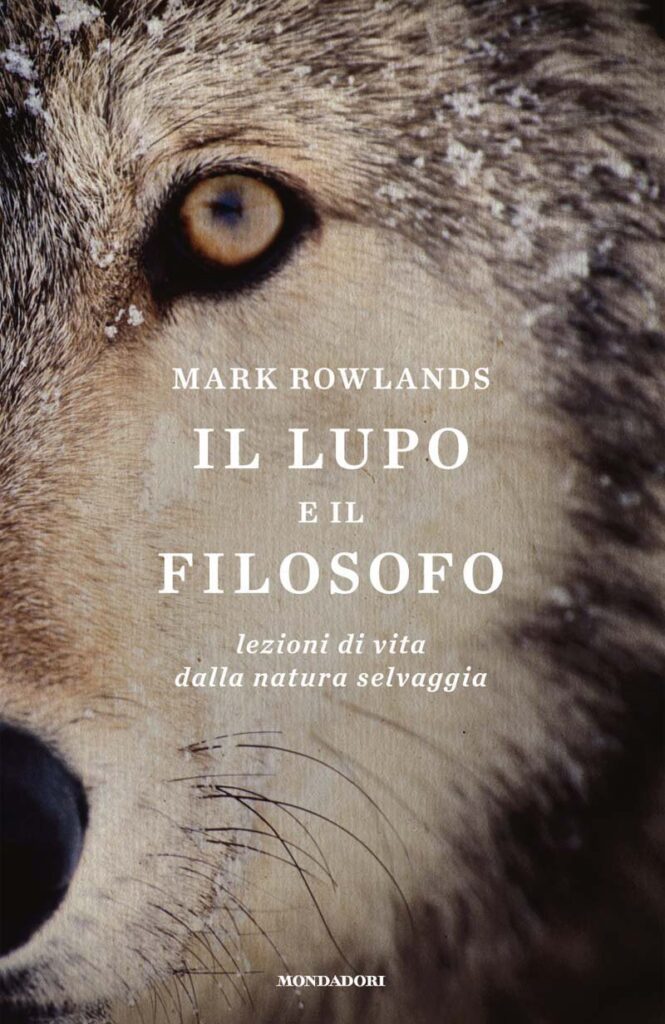
SINTESI DEL LIBRO:
Questo libro racconta la storia di un lupo di nome Brenin. Per
oltre un decennio - buona parte degli anni Novanta e i primi anni del
Duemila - ha vissuto con me. Costretto a convivere con un
intellettuale irrequieto e giramondo, è diventato uno straordinario
viaggiatore, essendo stato negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in
Irlanda e infine in Francia. Ha anche ricevuto, in gran parte
involontariamente, più istruzione universitaria gratuita di qualsiasi
lupo mai esistito. Come vedrete, lasciarlo solo comportava terribili
conseguenze per la mia casa e le mie proprietà, per cui ho dovuto
portarlo al lavoro con me e, dato che sono professore di filosofia, ciò
ha significato portarlo alle mie lezioni. Lui se ne stava acciambellato
sotto la cattedra o disteso in un angolo dell'aula a sonnecchiare,
come molti dei miei studenti, mentre io pontificavo monotono su
questo o quel filosofo. A volte, quando la lezione risultava
particolarmente noiosa, Brenin si tirava su a sedere e ululava,
un'abitudine che gli aveva assicurato le simpatie dei miei studenti, i
quali con ogni probabilità lo avrebbero imitato volentieri.
Ma questo è anche un libro su ciò che significa essere un uomo,
non come entità biologica bensì come creatura in grado di fare cose
che nessun'altra creatura può fare. Nelle storie che raccontiamo su
noi stessi, la nostra unicità è un ritornello abituale. Secondo alcuni,
tale unicità consiste nella capacità di creare cultura e di proteggerci
così dalla natura, «rossa di zanne e di artigli». Altri sottolineano il
fatto che siamo le uniche creature in grado di capire la differenza tra
il bene e il male, e di conseguenza siamo le uniche creature davvero
in grado di essere buone o cattive. Alcuni affermano che siamo unici
perché abbiamo la ragione: siamo animali razionali, i soli in un
mondo di bestie irrazionali. Altri ritengono che sia l'uso del
linguaggio a distinguerci nettamente dagli animali, privi della parola.
C'è chi sostiene che siamo unici perché siamo i soli dotati di libero
arbitrio e di libertà d'azione. Altri credono che l'unicità umana si basi
sul fatto che siamo i soli capaci di amare. Alcuni dicono che soltanto
noi sappiamo comprendere la natura e l'essenza della vera felicità.
Altri, infine, ritengono che siamo unici perché siamo i soli
consapevoli del fatto che moriremo.
Io non accredito nessuna di queste tesi come la testimonianza di
un profondo abisso tra noi e le altre creature. Loro fanno alcune cose
che noi pensiamo non siano in grado di fare. E noi non siamo in
grado di fare alcune cose che pensiamo di poter fare. Per il resto, bè,
è soprattutto una questione di livello, piuttosto che di genere. La
nostra unicità sta invece, e semplicemente, nel fatto che noi ci
raccontiamo tali storie e, soprattutto, possiamo davvero indurre noi
stessi a crederci. Se volessi definire gli esseri umani con una frase,
direi: gli uomini sono quegli animali che credono alle storie che
raccontano su se stessi. In altri termini, gli esseri umani sono animali
creduloni.
In questi tempi oscuri non vale certo la pena sottolineare che le
storie che raccontiamo su noi stessi possono essere la più importante
causa di divisione tra un essere umano e l'altro. Tra la credulità e
l'ostilità, spesso il passo è breve. Ciò che mi interessa, tuttavia, sono
le storie che ci raccontiamo per distinguerci non l'uno dall'altro, ma
dagli altri animali: le storie su ciò che ci rende umani. Ogni storia
possiede quello che potremmo definire un lato oscuro, cioè getta
un'ombra. E tale ombra dev'essere cercata dietro quello che la storia
dice: è lì che troveremo ciò che la storia dimostra e che
probabilmente risulterà oscuro sotto almeno due punti di vista. In
primo luogo, ciò che la storia dimostra è spesso un lato poco
lusinghiero, addirittura sgradevole, della natura umana. In secondo
luogo, quello che la storia dimostra è in genere difficile da vedere.
Questi due aspetti non sono disgiunti. Noi uomini abbiamo una
spiccata abilità a sorvolare sugli aspetti di noi stessi che troviamo
spiacevoli. E ciò si estende alle storie che raccontiamo per spiegare
noi stessi a noi stessi.
Il lupo è, naturalmente anche se ingiustamente, il tradizionale
emblema della faccia oscura dell'umanità. Il che è paradossale sotto
molti punti di vista, non ultimo quello etimologico. In greco, «lupo»
si dice lykos, una parola così simile all'aggettivo leukos, «bianco»,
«splendente» (e quindi tale da evocare la luce), che i due termini
sono stati spesso associati. Può darsi, quindi, che tale associazione
sia derivata semplicemente da errori di traduzione, oppure che fra le
due parole ci fosse un nesso etimologico più profondo. Ma, quale che
fosse la ragione, Apollo veniva considerato il dio sia del sole sia dei
lupi. E in questo libro è proprio il collegamento tra il lupo e la luce
l'elemento importante. Pensate al lupo come a una radura nella
foresta. Nelle viscere della foresta ci può essere troppo buio per
riuscire a vedere gli alberi, mentre la radura è il luogo che consente a
ciò che era nascosto di essere svelato. Il lupo, come cercherò di
dimostrare, è la radura nell'anima umana. Il lupo svela ciò che
rimane nascosto nelle storie che raccontiamo su noi stessi, ovvero ciò
che quelle storie dimostrano ma non dicono.
Noi siamo nell'ombra del lupo. Una cosa può gettare un'ombra in
due modi: ostacolando la luce o essendo la fonte di luce che altre cose
ostacolano. Ci sono le ombre proiettate da un uomo e quelle create
da un fuoco. Con l'espressione «ombra del lupo» intendo non
l'ombra proiettata dal lupo stesso, ma quella che noi creiamo
ostacolando la sua luce. E guardarci di nuovo a partire da questa
ombra è proprio quello che non vogliamo conoscere di noi stessi.
Brenin è morto qualche anno fa. Mi trovo ancora a pensare a lui
tutti i giorni. A molti questo potrà sembrare una manifestazione di
affetto eccessiva: dopotutto, era solo un animale. Ma sebbene adesso
la mia vita sia, sotto tutti i punti di vista più importanti, migliore che
mai, io mi sento più povero. È davvero difficile spiegare perché, e per
molto tempo io stesso non l'ho capito. Ora credo di avere trovato la
risposta: Brenin mi ha insegnato qualcosa che nel mio lungo
percorso nelle istituzioni scolastiche ufficiali nessuno mi aveva mai
insegnato, né avrebbe potuto insegnarmi. E si tratta di una lezione
difficile da tenere a mente con il giusto grado di chiarezza ed
entusiasmo adesso che Brenin non c'è più. Il tempo guarisce, ma lo fa
attraverso la cancellazione. Questo libro è il tentativo di fissare sulla
carta quella lezione prima che svanisca per sempre.
Un mito irochese narra di una scelta che una volta quel popolo
dovette compiere. Ne esistono diverse versioni. Propongo la più
semplice. Venne convocato il consiglio delle tribù per decidere dove
trasferirsi per la nuova stagione della caccia, ma nessuno sapeva che
il luogo alla fine prescelto era abitato dai lupi. Secondo la leggenda,
gli irochesi vennero ripetutamente attaccati e via via decimati dai
branchi. Si trovarono così di fronte a un dilemma: spostarsi altrove o
uccidere i lupi. Ma si resero subito conto che la seconda opzione li
avrebbe disonorati e li avrebbe resi quel tipo di persone che non
volevano essere. E così si spostarono. Per non ripetere lo stesso
errore, decisero che in occasione di tutte le successive riunioni del
consiglio si sarebbe nominato un rappresentante del lupo, il cui
intervento sarebbe stato sollecitato dalla domanda: «Chi parla per il
lupo?».
Questa, naturalmente, è la versione irochese del mito. Se ci fosse
una versione «lupesca», sono sicuro che sarebbe molto diversa.
Eppure, nel racconto c'è del vero. Cercherò di dimostrare che, in
generale, ciascuno di noi ha l'anima di una scimmia. Non investirò
troppo nella parola «anima». Con «anima» non intendo
necessariamente una parte di noi, immortale e incorruttibile, che
sopravvive alla morte del corpo. Può darsi che l'anima sia questo, ma
ne dubito. Oppure può darsi che l'anima sia semplicemente la mente,
e che la mente sia semplicemente il cervello. Ma dubito anche di
questo. Nell'accezione in cui uso tale termine, l'anima degli esseri
umani si rivela nelle storie che raccontano su se stessi: storie sul
perché sono unici; storie che noi uomini possiamo davvero indurci a
credere, a dispetto di tutte le prove contrarie. Ciò che ho intenzione
di dimostrare è che si tratta di storie raccontate da scimmie: storie in
cui struttura, tema e contenuto sono palesemente scimmieschi.
In questo contesto uso la scimmia come metafora di una tendenza
che esiste, in misura maggiore o minore, in ognuno di noi. In tal
senso, alcuni esseri umani sono più scimmie di altri. Anzi, alcune
scimmie sono più scimmie di altre. La scimmia è la tendenza a
comprendere il mondo in termini strumentali: il valore di ogni cosa è
in funzione di ciò che quella cosa può fare per la scimmia. La
scimmia è la tendenza a vedere la vita come un processo di
valutazione delle possibilità e di calcolo delle probabilità, per poi
sfruttare i risultati di quei calcoli a proprio favore. È la tendenza a
vedere il mondo come una serie di risorse, di cose da usare per i
propri scopi. La scimmia applica questo principio tanto alle altre
scimmie quanto - se non di più - al resto del mondo naturale. La
scimmia è la tendenza ad avere non amici, ma alleati. La scimmia
non guarda i suoi simili, li tiene d'occhio. E intanto aspetta
l'occasione giusta per ottenere qualche vantaggio. Vivere, per la
scimmia, è attendere di colpire. La scimmia è la tendenza a basare i
rapporti con gli altri su un unico principio, immutabile e inesorabile:
che cosa puoi fare per me, e quanto mi costerà fartelo fare?
Inevitabilmente, questa consapevolezza che anche le altre scimmie
hanno la stessa natura avrà un effetto boomerang, permeando e
infettando la visione che la scimmia ha di se stessa. E così essa pensa
alla propria felicità come a qualcosa che può essere misurato, pesato,
quantificato e calcolato. «.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
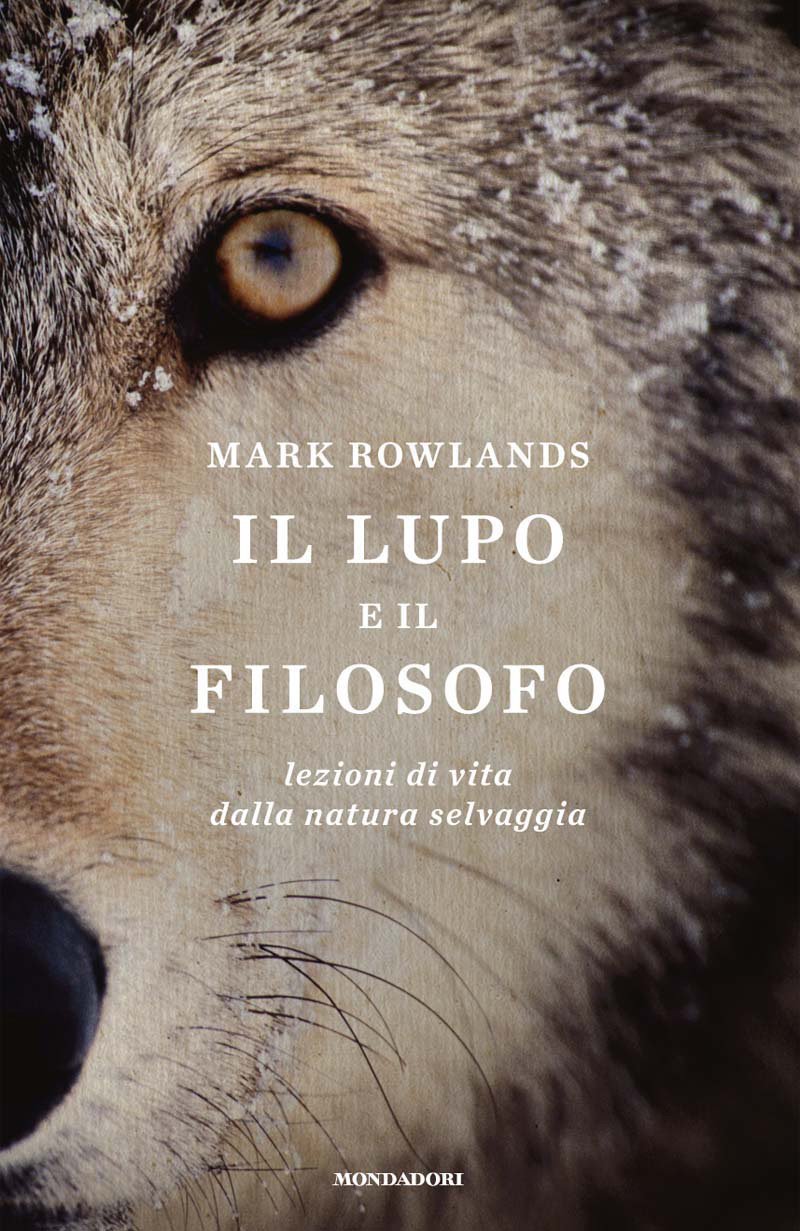





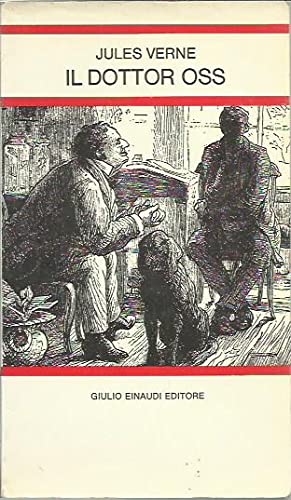
Commento all'articolo