Il fondamentalista riluttante – Mohsin Hamid
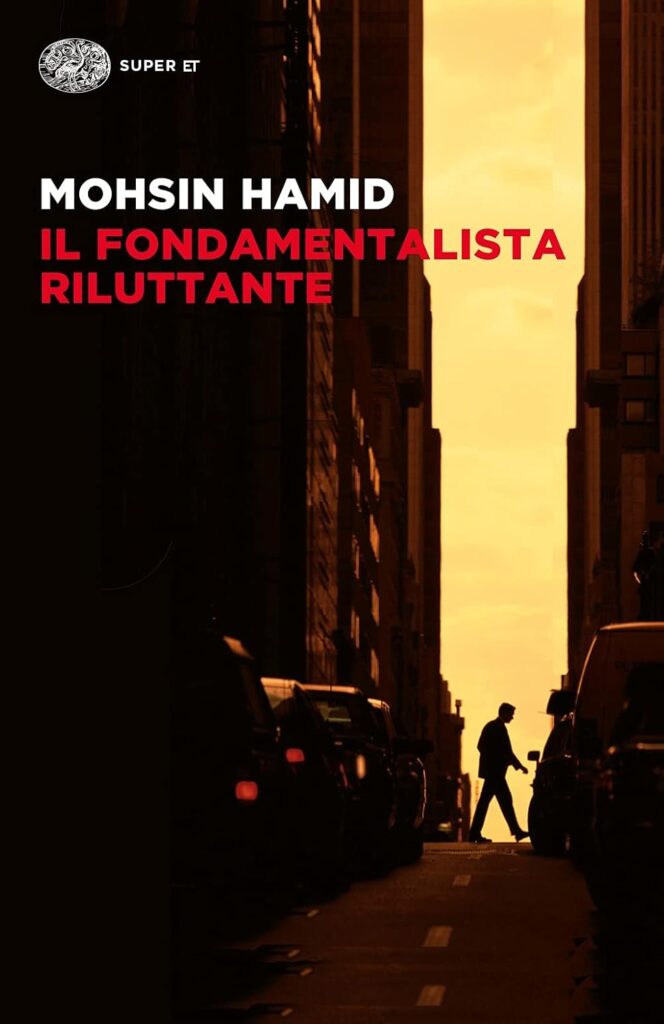
SINTESI DEL LIBRO:
Chiedo scusa, signore, posso esserle d’aiuto? Ah, vedo che l’ho allarmata.
Non si faccia spaventare dalla mia barba: io amo l’America. Mi sembrava che
lei stesse cercando qualcosa; anzi, piú che cercando, lei pareva in missione, e
dato che io sono nativo di questa città e parlo la sua lingua, ho pensato di
offrirle i miei servigi.
Come ho fatto a capire che lei è americano? No, non dal colore della
pelle; in questo paese abbiamo un ampio spettro di coloriti, e il suo non è raro
tra le popolazioni alla nostra frontiera nordoccidentale. E non è stato
nemmeno l’abito a tradirla; un turista europeo avrebbe potuto facilmente
acquistare a Des Moines il suo stesso abito con lo spacco singolo e la sua
camicia button-down. Certo, i capelli rasati e l’ampio torace – il torace, direi,
di un uomo che fa regolarmente palestra, e ai manubri solleva senza sforzo
duecento chili – sono tipici di un certo tipo di americano; ma di nuovo, gli
sportivi e i soldati di ogni dove tendono a somigliarsi tutti. È stato piuttosto il
suo contegno a permettermi di identificarla, e non lo prenda come un insulto– vedo che la sua espressione si è indurita – ma come una semplice
osservazione.
Allora, mi dica, cosa stava cercando? Di certo a quest’ora del giorno solo
una cosa può averla condotta al vecchio bazar di Anarkali – cosí chiamato,
come forse sa, in onore di una cortigiana murata viva per aver amato un
principe – ed è la ricerca della perfetta tazza di tè. Ho indovinato? Mi
permetta dunque, signore, di consigliarle il mio locale preferito. Ecco, è
questo. Le sedie di metallo non sono granché imbottite, i tavoli di legno sono
altrettanto grezzi, ed è, al pari degli altri, a cielo aperto. Ma le assicuro che la
qualità del tè è ineguagliabile.
Preferisce sedersi qui, con le spalle rivolte al muro? Benissimo, anche se
cosí trarrà meno beneficio dalla brezza intermittente che, quando soffia, rende
piú gradevoli questi pomeriggi caldi. Non si toglie la giacca? Cosí formale?
Be’, questo non è tipico degli americani, almeno non nella mia esperienza. E
la mia esperienza è notevole: ho trascorso quattro anni e mezzo nel vostro
paese. Dove? Ho lavorato a New York, e prima ho frequentato il college in
New Jersey. Sí, ha indovinato: a Princeton. Che intuito!
Cosa pensavo di Princeton? Be’, per rispondere a questa domanda devo
raccontarle una storia. Appena arrivato mi guardai intorno e osservando gli
edifici gotici – piú recenti, scoprii in seguito, di molte moschee di questa
città, ma antichizzati dai trattamenti a base di acidi e dal sapiente lavoro degli
scalpellini – pensai, questo è un sogno diventato realtà. Princeton mi dava la
sensazione che la mia vita fosse un film di cui io ero la star, e che tutto fosse
possibile. Ho accesso a questo splendido campus, pensavo, a professori che
sono titani nel proprio campo e a studenti che sono principi della filosofia in
gestazione.
Ero stato, devo ammetterlo, esageratamente generoso nelle mie idee sullo
standard degli studenti. Erano quasi tutti intelligenti, questo sí, e molti erano
anche brillanti, ma mentre io ero uno dei due soli pakistani del mio corso, due
su una popolazione di piú di cento milioni di anime, badi bene, gli americani
erano il frutto di una scrematura condotta su percentuali molto meno
clamorose. Erano un migliaio i suoi compatrioti le cui iscrizioni erano state
accettate, cinquecento volte i miei, pur essendo la popolazione del vostro
paese soltanto il doppio di quella del mio. Di conseguenza i non americani tra
noi tendevano in media a far meglio degli americani, e nel mio caso giunsi
all’ultimo anno senza aver ricevuto un solo voto al di sotto del massimo.
Col senno di poi capisco bene la potenza di quel sistema, pragmatico ed
efficace come molte altre cose negli Stati Uniti. Noi studenti internazionali
venivamo da ogni angolo del globo, ed eravamo vagliati non solo attraverso i
severi test standardizzati, ma anche attraverso ulteriori selezioni
minuziosamente personalizzate: colloqui, prove scritte, raccomandazioni, che
permettevano di identificare i migliori e i piú promettenti tra noi. Agli esami
in Pakistan ero stato tra i migliori, inoltre ero un giocatore di calcio
abbastanza bravo da competere nella squadra universitaria, cosa che feci
prima di infortunarmi al ginocchio nel corso del secondo anno. Agli studenti
come me venivano concessi visti e borse di studio, un totale sostegno
finanziario, ed eravamo, badi bene, ammessi nei ranghi della meritocrazia. In
cambio ci si aspettava che ponessimo i nostri talenti al servizio della vostra
società, la società di cui entravamo a far parte. E perlopiú eravamo ben lieti di
farlo. Io certamente, almeno all’inizio.
Ogni autunno Princeton si sollevava la gonna per i reclutatori delle grandi
aziende che arrivavano al campus e, come dite voi negli Stati Uniti, mostrava
un po’ di pelle. La pelle mostrata da Princeton era una bella pelle,
naturalmente, giovane, eloquente e quanto mai invitante, ma anche in mezzo
a tutta quella pelle, nel corso dell’ultimo anno mi resi conto di essere
qualcosa di speciale. Ero un seno perfetto, se vuole, un seno abbronzato,
succulento, apparentemente ignaro della forza di gravità, e confidavo di poter
ottenere qualunque lavoro desiderassi.
Eccetto uno: Underwood Samson & Company. Mai sentiti nominare?
Erano una società di consulenza. Stabilivano per i loro clienti il valore di
un’azienda da acquisire, e lo facevano, si diceva, con una precisione
inquietante. Erano piccoli, in pratica una bottega che impiegava un numero
ristrettissimo di persone, e pagavano bene, offrivano al neolaureato un salario
di partenza di piú di ottantamila dollari. Ma soprattutto garantivano a chi ci
lavorava un robusto set di competenze e un’esperienza lavorativa di
prim’ordine, tanto che dopo due o tre anni trascorsi lí come analista, ti era
praticamente garantita l’ammissione alla Harvard Business School. Per
questo nel 2001 piú di cento tra i laureati di Princeton avevano mandato i
propri voti e curriculum alla Underwood Samson. Otto vennero selezionati
per un colloquio, ovviamente, non per un lavoro – e uno di loro ero io.
Lei mi sembra preoccupato. Non tema; questo tipo corpulento è solo il
nostro cameriere, e non c’è bisogno di armeggiare sotto la giacca, immagino
per tirar fuori il portafoglio; pagheremo dopo, quando avremo finito.
Preferisce tè normale, con latte e zucchero, o tè verde, o magari la loro piú
squisita specialità, il tè del Kashmir? Ottima scelta. Prendo anch’io lo stesso,
magari insieme a un piatto di jalebi. Ecco. Se n’è andato. Devo ammettere
che ha un’aria un po’ minacciosa. Ma è di una cortesia irreprensibile:
resterebbe sorpreso dal suo linguaggio forbito, se solo lei capisse l’urdu.
Dove eravamo? Ah sí, Underwood Samson. Il giorno del mio colloquio
ero insolitamente nervoso. Avevano mandato un’unica persona, che ci
ricevette in una stanza del Nassau Inn, una stanza normale, badi bene, non
una suite; sapevano che eravamo già abbastanza impressionati dalla loro
fama. Quando venne il mio turno, entrai e trovai un uomo fisicamente non
molto diverso da lei; anche lui aveva l’aspetto di uno stagionato ufficiale
dell’esercito. «Changez? – disse, e io annuii, perché in effetti è il mio nome.
Venga, si accomodi».
Lui si chiamava Jim, mi disse, e io avevo a disposizione esattamente
cinquanta minuti per convincerlo a offrire a me il lavoro. «Si venda. Cos’è
che la rende speciale?» Cominciai dal mio libretto universitario,
sottolineando che ero in procinto di laurearmi summa cum laude, e che, come
ho già accennato, non avevo mai preso un voto al di sotto del massimo. «Non
dubito della sua intelligenza, – disse lui, – ma nessuna delle persone che vedo
oggi ha mai preso meno del massimo». Quella per me fu una rivelazione
disturbante. Gli dissi che ero tenace, che dopo essermi fatto male al ginocchio
avevo finito la fisioterapia in metà del tempo previsto dai medici, e anche se
non potevo piú giocare a calcio, riuscivo ancora a correre un miglio in meno
di sei minuti. «Bene, – disse lui, e mi sembrava di avergli finalmente fatto
una qualche impressione, quando aggiunse: – E poi?»
Ammutolii. Di solito, come lei può vedere, parlo volentieri, ma in quel
momento non sapevo cosa dire. Lo guardai guardarmi, tentando di capire
cosa stava cercando. Lui abbassò gli occhi sul mio libretto, posato sul tavolo
tra noi, e poi alzò di nuovo lo sguardo. I suoi occhi erano freddi, azzurri e
sentenziosi, non nel senso in cui viene solitamente usata la parola, ma nel
senso di qualcuno abituato per mestiere a giudicare, come un gioielliere
quando esamina per curiosità un diamante che non intende né comprare né
vendere. Infine, dopo un certo lasso di tempo, non poteva essere stato piú di
un minuto, ma era sembrato piú lungo, insistette: «Mi dica qualcosa. Da dove
viene?»
Dissi che ero di Lahore, la seconda maggiore città del Pakistan, l’antica
capitale del Punjab, abitata da quasi altrettante persone di New York,
stratificata come una pianura sedimentaria dalla storia accumulata dei suoi
invasori, dagli ariani ai mongoli ai britannici. Lui si limitò ad annuire. Poi
disse: «E riceve un sostegno finanziario?»
Non risposi subito. Sapevo che c’erano argomenti che nei colloqui non
era lecito affrontare, la religione, ad esempio, o l’orientamento sessuale, e
sospettavo che il sostegno finanziario fosse uno di quelli. Ma non è questa la
ragione per cui esitai; esitai perché la sua domanda mi aveva messo a disagio.
Poi dissi: «Sí». E lui: «E non è piú difficile, per gli studenti internazionali,
essere ammessi se richiedono una borsa?» Dissi di nuovo: «Sí». E lui:
«Perciò deve aver avuto davvero bisogno di quei soldi». E per la terza volta
io dissi: «Sí».
Jim si appoggiò allo schienale e accavallò le gambe, proprio come sta
facendo lei adesso. Poi disse: «Lei è distinto, ben vestito. Ha questo accento
sofisticato. Immagino che la gente pensi che lei sia ricco, a casa sua». Non
era una domanda, perciò non replicai. «I suoi amici qui sanno – continuò
che la sua famiglia non avrebbe potuto mandarla a Princeton senza una borsa
di studio?»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :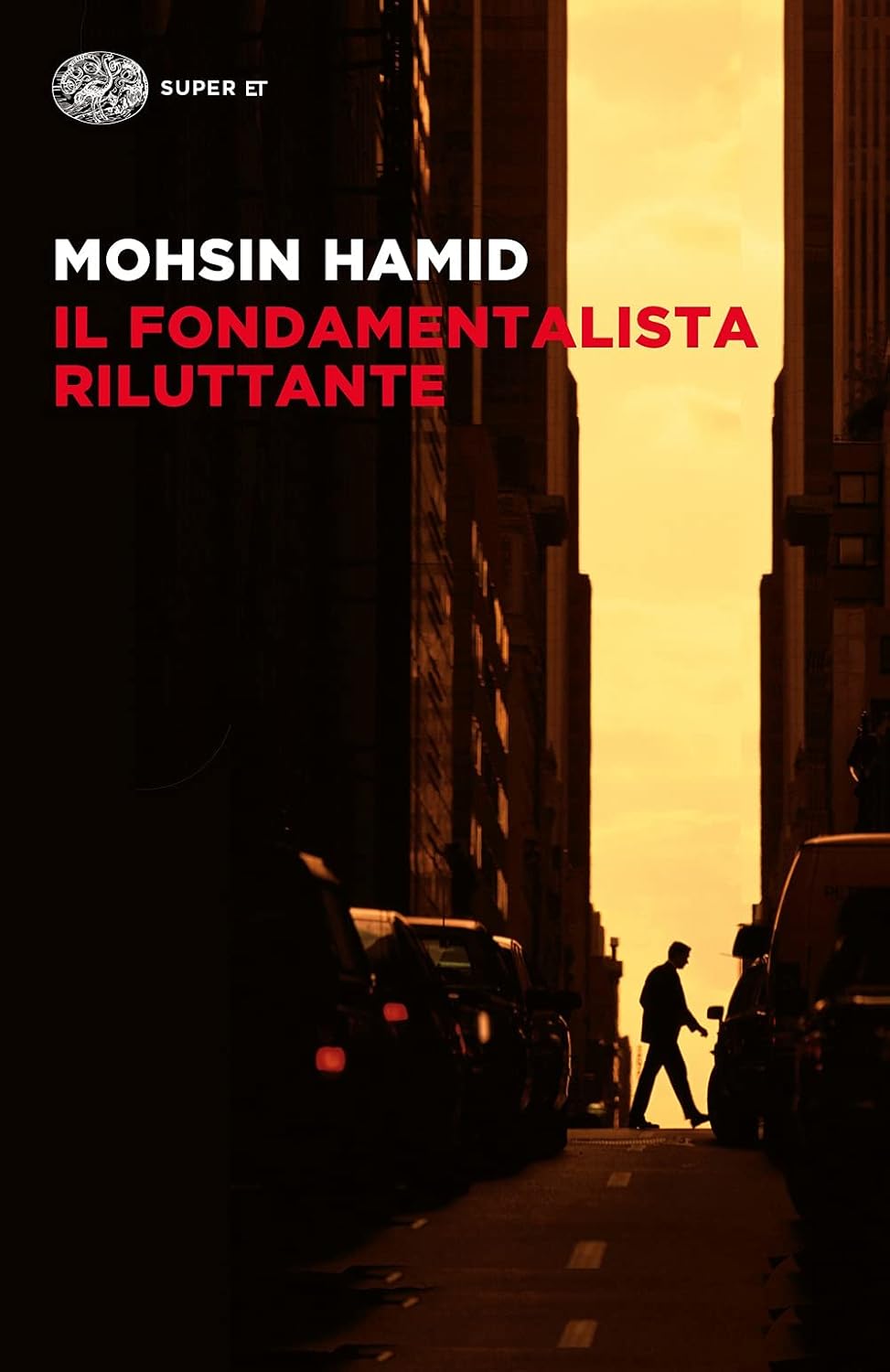






Commento all'articolo