Diario di un curato di campagna – George Bernanos
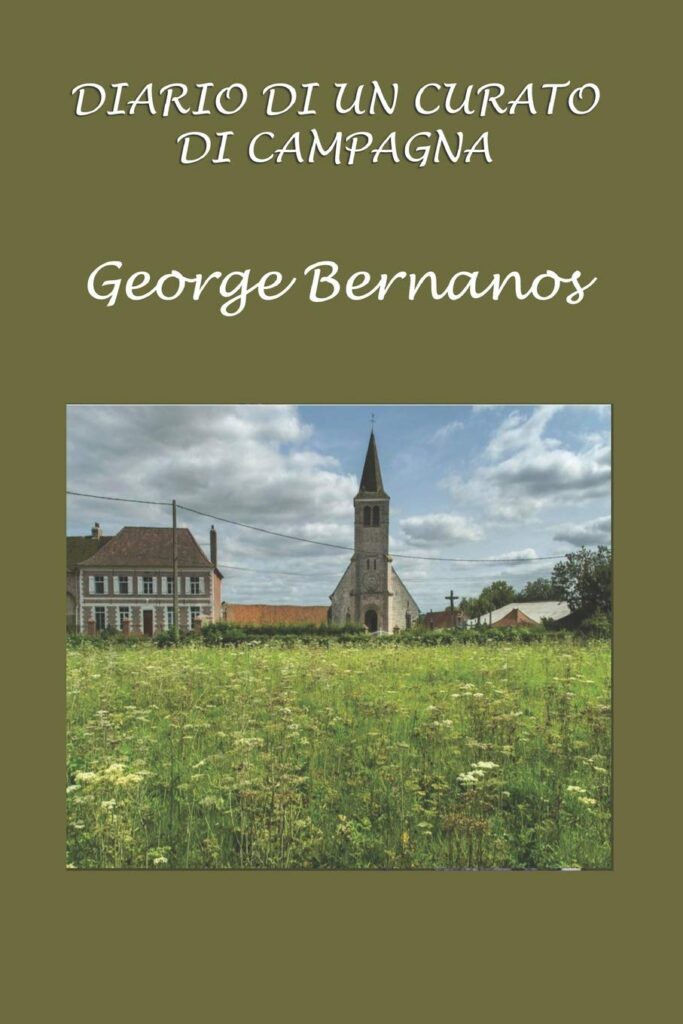
SINTESI DEL LIBRO:
La mia parrocchia è una parrocchia come tutte le altre. Si rassomigliano tutte.
Le parrocchie d'oggi, naturalmente. Lo dicevo ieri al curato di Norenfontes:
«Il bene e il male debbono equilibrarsi: senonché, il centro di gravità è
collocato in basso, molto in basso. O, se lo preferite, si sovrappongono l'uno
all'altro senza mescolarsi, come due liquidi di diversa densità». Il curato m'ha
riso in faccia. È un buon prete, affabilissimo, molto paterno, che
all'arcivescovado passa addirittura per un ingegno forte, un po' pericoloso. I
suoi motti di spirito formano la gioia dei presbitèri, ed egli li sottolinea con
uno sguardo che vorrebbe essere vivacissimo e che in fondo io trovo cosí
frusto, cosí stanco da mettermi voglia di piangere.
La mia parrocchia è divorata dalla noia, ecco la parola. Come tante altre
parrocchie! La noia le divora sotto i nostri occhi e noi non possiamo farci
nulla. Qualche giorno forse saremo vinti dal contagio, scopriremo in noi un
simile cancro. Si può vivere molto a lungo con questo in corpo.
L'idea m'è venuta ieri, sulla strada. Cadeva una di quelle piogge sottili che
si inghiottono a pieni polmoni e che vi scendono sino al ventre. Il villaggio
m'è apparso bruscamente dalla parte di Saint-Vaast, cosí ammucchiato, tanto
miserabile sotto l'odioso cielo di novembre. L'acqua gli fumava sopra da tutte
le parti. Sembrava essersi coricato là, nell'erba ruscellante, come una povera
bestia stracca. Com'è piccolo, un villaggio! E quel villaggio era la mia
parrocchia. Era la mia parrocchia, ma io non potevo far nulla per essa; la
guardavo affondare tristemente nella notte, scomparire... Ancora qualche
momento, poi non l'avrei piú vista. Non avevo mai sentito tanto crudelmente
la sua solitudine e la mia. Pensavo a quel bestiame che sentivo tossire nella
nebbia e che il piccolo vaccaro, tornando dalla scuola con la sua cartella sotto
il braccio, tra poco avrebbe menato, attraverso le pasture imbevute d'acqua,
verso la stalla calda, odorante... E lui, il villaggio, sembrava aspettare
anch'esso - senza grande speranza - dopo tante notti passate nel fango, un
padrone da seguire verso qualche improbabile, qualche inimmaginabile asilo.
Oh! So bene che queste sono idee pazze, che non posso nemmeno
prenderle del tutto sul serio, sogni... I villaggi non si levan su, alla voce d'uno
scolaretto, come le bestie. Che importa? Ieri sera, credo che un santo l'avesse
chiamato.
Mi dicevo dunque che il mondo è divorato dalla noia. Naturalmente
bisogna riflettervi un po' sopra per rendersene conto; la cosa non si sente
subito. È una specie di polvere. Andate e venite senza vederla, la respirate, la
mangiate, la bevete: è cosí sottile, cosí tenue che sotto i denti non scricchiola
nemmeno. Ma basta che vi fermiate un secondo, ecco che vi copre il viso, le
mani. Dovete agitarvi continuamente, per scuotere questa pioggia di ceneri.
Perciò, il mondo s'agita molto.
Si dirà forse che il mondo con la noia ha familiarità da molto tempo, che la
noia è la vera condizione dell'uomo. È possibile che il suo seme sia stato
sparso dappertutto e che essa sia germinata qua e là, sul terreno favorevole.
Ma quel che io mi chiedo è se gli uomini hanno mai conosciuto questo
contagio della noia, questa lebbra: una disperazione abortita, una forma turpe
della disperazione, che è senza dubbio come la fermentazione d'un
cristianesimo decomposto.
Evidentemente, questi son pensieri che serbo per me stesso. Tuttavia non
me ne vergogno. Credo persino che mi farei capire benissimo, troppo bene,
forse, per la mia quiete: voglio dire, per la quiete della mia coscienza.
L'ottimismo dei superiori è davvero morto. Coloro che lo professano ancora,
l'insegnano per abitudine, senza credervi. Alla minima obiezione vi prodigan
sorrisi d'intesa, chiedono grazia. I vecchi preti non s'ingannano, in proposito.
A dispetto delle apparenze e se si resta fedeli a un certo vocabolario,
immutabile d'altronde, i temi dell'eloquenza ufficiale non sono piú gli stessi: i
nostri vecchi non li riconoscono piú. Un tempo, per esempio, una tradizione
secolare voleva che un discorso episcopale non terminasse mai senza una
prudente allusione - convinta, certo, ma prudente - alla prossima persecuzione
e al sangue dei martiri. Oggi queste predizioni si fanno molto piú rare.
Probabilmente perché la realizzazione ne appare meno incerta.
Ahimé! C'è una frase che comincia a correre per i presbitèri, una di quelle
frasi spaventose, definite “da fante”, che non so come né perché ai nostri
anziani son parse assai lepide, ma che i ragazzi della mia età trovano brutte,
tristissime. (È stupefacente, d'altronde, quante idee sordide il gergo delle
trincee è riuscito a esprimere in immagini lugubri; ma era veramente il gergo
delle trincee?...) Si ripete dunque volentieri che “non bisogna cercar di
capire”. Mio Dio! Eppure noi siamo qui proprio per questo! Mi rendo conto
che vi sono i superiori. Senonché, chi li informa, i superiori? Noi. E allora
quando ci vantano l'ubbidienza e la semplicità dei monaci, l'argomento non
mi commuove molto...
Siamo capaci tutti di pelare patate o di curare i porci, purché un maestro
dei novizi ce ne dia l'ordine. Ma in una parrocchia non è cosí facile come in
una semplice comunità, offrire atti di virtú! Tanto piú che essi li
ignorerebbero sempre; e d'altra parte non vi capirebbero nulla.
L'arciprete di Bailloeil, dopo che è andato a riposo, frequenta assiduamente
i RR. PP. Certosini di Verchocq. Quel che ho visto a Verchocq è il titolo
d'una sua conferenza alla quale il signor decano ci ha quasi fatto obbligo
d'assistere. In essa abbiamo sentito cose interessantissime, persino
appassionanti, quanto al tono, poiché quell'incantevole vecchio ha conservato
le piccole innocenti manie dell'antico professore di lettere, e cura la propria
dizione come le proprie mani. Si direbbe che spera e teme nello stesso tempo
l'improbabile presenza, tra i suoi ascoltatori in sottana, di Anatole France, e
che gli domandi grazia per il buon Dio, in nome dell'umanesimo, con sguardi
sottili, sorrisi di complicità e contorcimenti del dito mignolo. Sembra
insomma che quella specie di civetteria ecclesiastica nel 1900 fosse di moda.
Noi abbiamo cercato di far buona accoglienza a delle frasi “taglienti”, che
non tagliavano un bel nulla. (Probabilmente, ho una natura troppo grossolana,
troppo frusta; ma confesso che il prete letterato m'ha sempre fatto orrore.
Frequentare i begli spiriti, insomma, è come pranzare in città, ma non si va a
pranzo in città in barba a quelli che muoiono di fame.)
Breve: il signor arciprete ci ha raccontato molti aneddoti che, secondo
l'uso, egli definisce “tratti”. Credo d'aver compreso. Per disgrazia, non mi
sentivo commosso quanto avrei desiderato. I monaci sono incomparabili
maestri di vita interiore, nessuno ne dubita, ma per la maggior parte succede
di quei “tratti” come per i vini locali: bisogna berli sul posto. Non sopportano
il viaggio.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :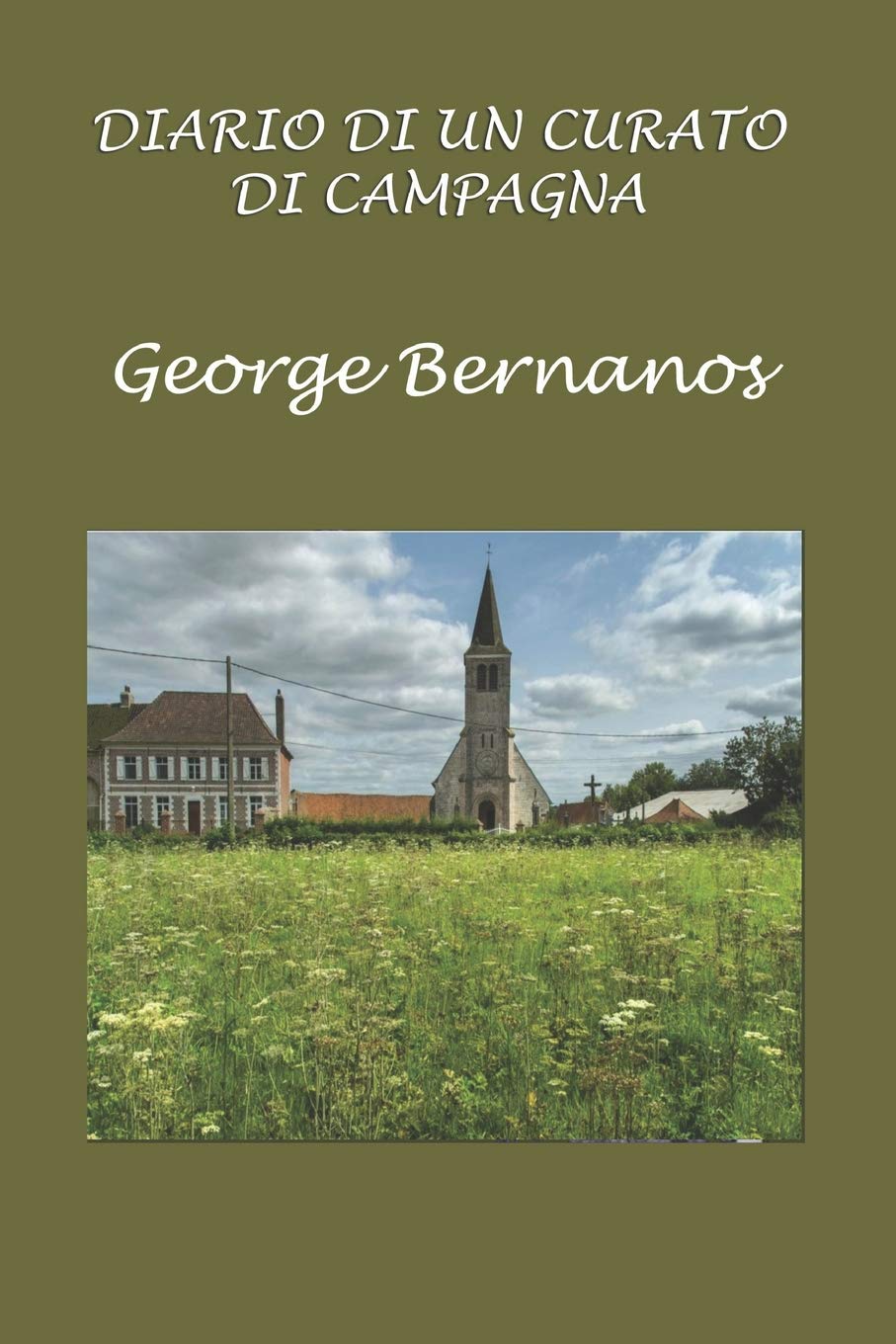






Commento all'articolo