Cioran – Ritratto di uno scettico estremo – Bernd Mattheus
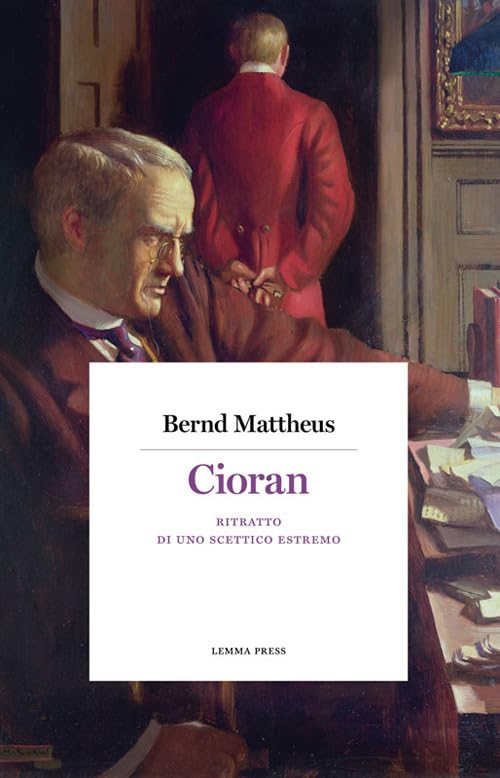
SINTESI DEL LIBRO:
Quanti di noi possono affermare di aver avuto un’infanzia felice? Di
certo Cioran, proprio lui, nato l’8 aprile 1911 nel villaggio transilvano
di Răşinari, nel cuore dei Carpazi. Basta osservare quel paesaggio
montuoso per comprendere l’enfasi nelle sue parole: «Se la parola
‘paradiso’ ha un senso, si applica a quel periodo della mia vita».
14
Emil è il secondo figlio di Emilian Cioran (1884-1957) ed Elvirei
(1888-1966), nata Comaniciu. La scelta di dare ai figli nomi latini è
frutto di un’intenzionale protesta contro il dominio ungherese
dell’epoca,
15 quando i rumeni non costituivano altro che la più
grande minoranza nel principato di Transilvania, sotto dominazione
asburgica. Per questo la sorella maggiore di Emil si chiamava
Virginia (1908-1966), soprannominata Gica, e il fratello minore, che
nascerà nel 1914, si chiamerà Aurel (soprannominato Aureliu, o
Relu). Il padre di Emil è pope della comunità ortodossa di Sf.
Paraschiva, nel villaggio di Răşinari, abitato da 6.000 anime e
distante circa 10 km dalla città di Sibiu (in tedesco Hermannstadt).
Quando può, il giovane Emil abbandona la canonica – l’edificio più
grande della zona – per girovagare nella natura:
Metà del villaggio viveva sulle montagne, i Carpazi. Io ero amico
dei pastori, che mi piacevano molto. Rappresentavano per me un
altro mondo, al di là della civiltà. Forse perché vivevano in un
Paese di nessuno, sempre di buon umore, come se ogni giorno
fosse un giorno di festa. A guardar loro, gli albori dell’umanità non
devono essere stati così male. […] Lo stile primitivo vissuto laggiù
mi sembrava l’unico possibile. Quel che conta è la preistoria, il
momento antecedente la presa di coscienza e l’inizio della storia,
la vita nell’inconscio».
16
Perfino il trasferimento coatto dei genitori durante la Prima guerra
mondiale – il padre a Sopron (oggi in Ungheria) e la madre a Cluj
non riduce la felicità del fanciullo:
Dopo la colazione potevo sparire fino a mezzogiorno, poi tornavo
a casa, e un’ora dopo sparivo di nuovo in giro per i monti […]. Più
tardi c’è stato un altro ‘vantaggio’ ad abitare lassù: durante la
guerra del ’14 i miei genitori furono deportati dagli ungheresi – in
quanto rumeni –, mentre mio fratello, mia sorella e io siamo
rimasti lì con la nonna, insomma eravamo totalmente liberi! È
stato un periodo ideale! Amavo molto i contadini, e ancora di più i
pastori: avevo una sorta di culto per loro. […] In fondo l’unico
mondo vero è quello primitivo, in cui tutto è possibile e niente si
concretizza.
17
Un altro luogo magico è per Cioran il cimitero, che confina
direttamente con il giardino della casa paterna: «Fu così che da
bambino divenni amico di un becchino di una cinquantina d’anni.
Procedeva con gioia quando doveva scavare una tomba e giocare a
calcio con i teschi. Mi sono sempre chiesto come potesse essere
ogni giorno così soddisfatto. […] Mi chiedevo perché dobbiamo
vivere tutto quello che viviamo. Soltanto per finire cadaveri? Queste
impressioni rimasero come segni indelebili».
18
Cioran tornerà su queste esperienze d’infanzia nei suoi Sillogismi
dell’amarezza, dove aggiungerà che anche lui, con i suoi compagni
di giochi, usava i teschi come palle da calcio: «Era per noi una gioia
che nessun pensiero funereo veniva a offuscare. Per molti anni ho
vissuto in mezzo a preti che al loro attivo avevano migliaia e migliaia
di estreme unzioni, eppure non ne ho conosciuto nessuno che fosse
incuriosito dalla Morte».
19
Nei suoi viaggi, Cioran avrebbe conservato l’abitudine di cercare
sempre il cimitero del posto: un esercizio per raffreddare il proprio
temperamento e per dare, a fronte del grande numero di morti,
proporzioni nuove ai suoi problemi. Nei suoi Quaderni ricorda ad
esempio di una vacanza fatta nel 1930 nel villaggio di Rîul-Sadului,
poco distante da Sibiu, quando all’indomani di una notte insonne
andò a visitare il piccolo cimitero ricoperto di erbacce. La
vegetazione si era rimpossessata perfino delle croci di legno. Su una
di queste, per quanto non riuscisse a leggere il nome del defunto, lo
colpì il motto «La vita è speranza, la morte è oblio».
20 L’incuria in cui
versava il cimitero era in un certo senso l’illustrazione di quella
massima. Quando, più avanti negli anni, vivrà una fase di profonda
delusione in cui il senso di disincanto per l’antica Transilvania (o
Ardeal, o Erdély) abitata un tempo da traci, slavi, romani, ungari e
zingari si trasformerà addirittura in odio, Cioran definirà i cimiteri in
abbandono il simbolo parlante della propria patria: «croci di legno
storte, che vegliano su morti privi di orgoglio. Nei cimiteri dei villaggi
puoi cogliere i simboli profondi del Paese, perché non c’è angolo di
mondo in cui una tale quantità di erbacce abbia ricoperto il ricordo di
chi è stato con una così generosa manifestazione dell’oblio».
21
Appare irricucibile la frattura che si apre tra un’infanzia paradisiaca,
trascorsa nella ‘natura selvaggia’, e l’esclamazione apodittica:
«Nessuno si rimette dal male di nascere, piaga capitale se mai ve ne
furono».
22 Nel 1924 lo psicoanalista Otto Rank aveva dedicato al
‘trauma della nascita’ una teoria piuttosto speculativa (addirittura in
una monografia). Diremmo quasi che Cioran andrà a riproporre, di
opera in opera, la tesi dell’«inconveniente di essere nati», idea già
diffusa nella Stoa e presente anche nel buddismo. «Vengo dalla
terra abitata un tempo da quei traci che piangevano alla nascita degli
uomini e si rallegravano alla loro morte».
23 L’impossibilità di una
conciliazione perfino oltre la morte è dimostrata dal poeta e filosofo
cieco Abū l-‘Alā’ al-Ma‘arrī (١٠٥٧-٩٧٣), che nel suo epitaffio scelse di
maledire la propria vita e, conseguentemente, chi l’ha generata:
«Questo torto che mio padre mi fece io non lo commisi con alcuno».
24 Se ne ritrovano echi in Cioran, quando definisce l’infanzia «un
periodo imbecille che mi vergogno di aver vissuto»,
25 oppure
quando afferma: «Eppure la nascita è proprio un abisso, un
baratro».
26
«Da bambino non riuscivi a star fermo. Cercavi la lontananza. Volevi
essere al di fuori, lontano da casa, lontano dai tuoi».
27 Cioran
menziona molto raramente genitori e fratelli, perché si vergogna
della mediocrità della famiglia d’origine: «Quando non si è avuta la
fortuna di avere dei genitori alcolizzati, bisogna intossicarsi tutta la
vita per compensare la pesante eredità delle loro virtù»,
28 dichiara
sarcastico. In realtà nessuna delle fotografie arrivate fino a noi
tradisce nulla di quell’atmosfera infelice evocata da Emil, anzi esse
sembrano ritrarre una famiglia serena, per non dire allegra – ad
esempio durante le scampagnate o le colazioni in mezzo alla natura.
Emil a cavallo, Emil sugli sci: non ci dà l’impressione di essere
particolarmente malinconico. Eppure, a distanza di tempo,
affermerà: «La stanchezza è la specialità della mia famiglia!»,
29 o
ancora: «Nella nostra famiglia il nenoroc [sventura, disgrazia] non è
un concetto vuoto, ma quanto mai concreto».
30 Un altro male che
affliggeva la famiglia era l’insoddisfazione, «un male di cui abbiamo
sempre sofferto nella nostra famiglia, tormentata, inquieta».
31 Il
padre di Emil avrebbe potuto incarnare l’inefficacia della preghiera,
mentre la madre, irreligiosa, rimpiangeva forse di aver contratto un
matrimonio al di sotto del proprio rango sociale, visto che il padre
notaio aveva ricevuto dal governo imperial-regio il titolo di barone.
Elvirei, i cui morbidi tratti del viso si riconoscono nel giovane Emil,
viene ricordata dal figlio come una persona straordinaria, ma anche
vanitosa. Il pensiero di Cioran va però soprattutto «alla sua
malinconia, di cui ci ha trasmesso il gusto e il veleno».
32 Si tratta, a
mio avviso, di un’affermazione capitale, perché dà nome a qualcosa
che, come per una sorta di trasfusione materna, va oltre l’eredità
emotiva nazionale (quella che potrebbe essere ad esempio la
saudade portoghese, la nostalgia triste che viene tramandata dalla
collettività). Allo stesso tempo, Cioran rimane affettivamente legato
alla madre e la considera il membro della famiglia meno orientato
alle convenzioni borghesi. Subito dopo la sua morte annoterà: «Tutto
quello che ho di buono e di cattivo, tutto quello che sono, l’ho preso
da mia madre. Ho ereditato i suoi malanni, la sua malinconia, le sue
contraddizioni, tutto. Fisicamente, sono identico a lei. Ma in me ogni
suo carattere si è aggravato ed esasperato. Sono il suo successo e
la sua sconfitta».
33 In queste considerazioni Cioran riprende le teorie
del biologismo in voga a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, ma
giunge al cuore della questione. Come in un bilancio, avrà a
scrivere: «L’ansia — è stata l’Unterton [la nota caratteristica, N.d.T.]
della mia vita».
34 Solo la letteratura può essere grata al ‘veleno’
delle madri nevrotiche, perché ci concede le opere di un Beckett, di
un Bataille o di un Duras. Lo fa tuttavia senza dirci nulla della felicità
interiore degli autori, per non parlare delle tante figure senza nome
in cui la trasfusione di malinconia non ha generato creatività ma una
predisposizione al fallimento, se non addirittura una deriva mortale,
autolesionista, di tale intossicazione. Deriva che è ben presente a
Cioran quando scrive della sorella maggiore, Virginia: «[…] una
pazza, un’infelice, un essere insostenibile».
35 «Mia sorella, con la
pressione a 25,
36 fumava cento sigarette al giorno: quasi un suicidio.
Suo figlio invece si è suicidato per davvero, mentre io, dall’altra parte
dell’Europa, mi limitavo al modesto ruolo di teorico del suicidio».
37
Del fratello Aurel scrive invece: «Entrambi soffriamo dello stesso
male, solo che lui, taciturno dalla nascita, non ha accesso alla
parola, mentre io, di una loquacità instancabile, sfoggio le mie
sofferenze e le converto, come per comprometterle, in capricci».
38
A rendere Cioran filosofo precoce è però l’esperienza della noia: «Il
primo attacco di noia di cui mi ricordi perfettamente fu a Drăgăşani,
durante la prima guerra mondiale. Dovevo avere sui cinque anni; un
pomeriggio in uno strazio vuoto ma incancellabile. Forse la mia noia
coincide con la paura del mondo, con il mio arretrare davanti a tutto
ciò che vi è di connesso».
39 Per la sua prossimità all’angoscia, il
sentimento di noia descritto da Cioran si distingue dall’ennui di un
Baudelaire, elemento di stile del dandy o dell’aristocratico. (Cioran,
che scriveva in francese, non ha trovato un’alternativa valida al
termine ennui, ma come vedremo lo usa quasi come sinonimo di
cafard). C’è da chiedersi quanto di quella noia – dal romanticismo
andando a ritroso fino all’illuminismo – fosse moda, invenzione e
fonte di energia creativa, e quanto fosse invece mal du siècle. È
possibile che la noia espressa da Rousseau passando per
Chateaubriand (Atala), Benjamin Constant, Maine de Biran, fino a
Taine e Flaubert fosse da intendersi come fenomeno concomitante
alle lumières e alla rivoluzione, vale a dire al radicale isolamento
dell’individuo moderno?
40 Di certo la tormentosa «noia che mi rende
la vita impossibile»
tutt’altre
41 di una Maria von Herbert doveva avere
motivazioni
dall’ennui
di
Madame du Beffand,
contemporanea di Voltaire, che nelle sue lettere lamentava una
condizione di noia – «il tempo che non scorre» – che la condannava
a «vegetare». Già a una Madame du Deffand doveva essere
estranea la preoccupazione di Maria von Herbert di non condurre
una vita pia. La definizione più concisa che Cioran ci dà della noia è
la seguente: «L’esperienza della noia è la coscienza del tempo
esasperata».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo