Chi ha paura del lupo? – Karin Fossum
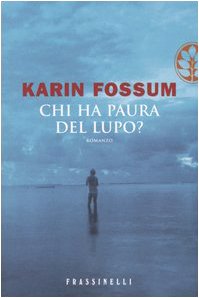
SINTESI DEL LIBRO:
Un raggio abbagliante irruppe improvviso tra gli alberi.
A Kan
Colto di sorpresa, egli si fermò bruscamente. Si era alzato dal letto e
lentamente aveva attraversato, ancora insonnolito, la casa buia ed era uscito
sulla scala esterna. E il sole lo aveva colpito.
Fu come se gli avessero trafitto gli occhi con una lesina.
Istintivamente portò le mani al viso, ma la luce avanzò inesorabile
facendosi strada attraverso la cartilagine e le ossa, per penetrare infine nelle
tenebre del cranio. Tutto, dentro quella testa, diventò di un bianco lacerante.
I pensieri presero a vagare disordinatamente, frammentandosi in atomi.
Avrebbe voluto gridare con tutte le sue forze, ma non lo aveva mai fatto in
vita sua, ritenendolo al di sotto della sua dignità. Stringendo invece i denti
si impose di restare il più possibile fermo e silenzioso sulla scala. Qualcosa
stava accadendo. Il cuoio capelluto iniziò a contrarsi, con un crescente
formicolio. Si portò, tremante, le mani alla testa. Sentì che gli occhi si
stavano spostando verso le tempie e le narici si dilatavano fino a diventare
grandi come buchi di serrature. Emise un lamento soffocato, imponendosi
di resistere, ma nulla poté contro la violenza di quelle forze. A poco a poco
i tratti del viso gli si cancellarono; non rimase che un cranio nudo, ricoperto
di pelle bianca trasparente.
Lottò febbrilmente, emettendo deboli lamenti; cercò di palparsi le guance
per accertarsi che il viso fosse ancora al suo posto. Il naso si era fatto
molliccio e ripugnante. Ritrasse la mano. Aveva rovinato quel poco che era
rimasto e si rendeva conto che il naso stava scivolando via, perdendo la
forma come una prugna marcia.
Poi, di colpo, tutto si placò. Egli riprese lentamente fiato, sentì che la
faccia stava ritornando normale. Batté più volte le palpebre, aprì e richiuse
la bocca; ma nel momento in cui si apprestava a rientrare avvertì una fitta al
costato, come se lo avessero straziato gli artigli acuminati di un mostro
invisibile.
Si piegò ad arco, le braccia strette intorno al corpo per contrastare le
forze che con crescente energia gli stavano tirando la pelle del torace. I
capezzoli gli sparirono sotto le ascelle. La pelle del torso nudo gli si
assottigliò; pulsando sotto la pressione di un sangue nero, le vene
spiccavano nodose come gomene.
Piegato in due, intuì che stava accadendo qualcosa che lui non avrebbe
potuto impedire.
Improvvisamente, come un troll esposto ai raggi del sole, gli scoppiò la
pelle, provocando la fuoriuscita dei visceri. Cercò di bloccare l'efflusso
stringendo con le dita i margini della ferita, ma si accorse che tutto
traboccava, gli colava tra le dita e si accumulava davanti ai suoi piedi come
frattaglie di scarto in un mattatoio. Ingabbiato dietro le costole, il cuore
continuava atterrito a martellargli tumultuosamente in petto. Per infiniti
momenti rimase così, piegato in due, boccheggiando. La cavità addominale
era vuota. Aprì un occhio e vi gettò uno sguardo allarmato. Dal suo corpo
non fuoriusciva più niente. Con una mano si mise a raccattare
maldestramente il contenuto e lo ficcò alla rinfusa nel ventre, cercando con
l'altra mano di tenere ferma la pelle per evitare che gli intestini ricadessero
nuovamente.
Niente si ricollocò al posto giusto; emergevano protuberanze nei punti
più inverosimili, ma nessuno se ne sarebbe accorto se fosse riuscito a far
rimarginare la ferita. Sapeva di non essere fatto come gli altri, e che questo
non era visibile all'esterno.
Sempre stringendo i lembi della ferita con la mano sinistra, continuava
con la destra a pigiare la massa di intestini, riuscendo infine a introdurne la
maggior parte. Sui gradini non rimase che qualche traccia di sangue.
Premette con forza i margini della ferita e constatò che tutto cominciava a
richiudersi. Respirava piano, nel timore che il suo corpo tornasse a lacerarsi.
Stava ancora irrigidito sulla scala. I raggi bianchi del sole, acuminati come
una spada, splendevano ancora tra gli alberi. Ma lui era di nuovo sano e
salvo. Tutto era accaduto troppo in fretta, niente di più. Non si sarebbe
dovuto alzare dal letto e uscire avventatamente alla luce del sole. Si era
sempre mosso in un altro spazio e aveva visto il mondo attraverso un velo
scuro che attenuava la luce e i rumori esterni. Era lui stesso, con la forza
della concentrazione, a fare sì che quel velo fosse sempre al suo posto.
Questa volta aveva agito con sventatezza, gettandosi a capofitto nella luce
del nuovo giorno, senza riserve, come un bambino.
Gli era parso che la punizione fosse stata irragionevolmente dura. Infatti,
mentre dormiva nella sua branda malconcia, aveva fatto un sogno che lo
aveva spinto a balzare in piedi e uscire precipitosamente senza pensare alle
conseguenze. Chiuse gli occhi e richiamò alla memoria alcune immagini.
Quello che vide era sua madre, ai piedi della scala. Dalla sua bocca usciva a
fiotti sangue rosso e caldo. Grassoccia e tondeggiante nella sua vestaglietta
bianca a fiori, faceva pensare a una brocca capovolta da cui colava una salsa
rossa. Gli tornò in mente la sua voce, sempre accompagnata da un
malinconico suono di flauto. Lentamente rientrò in casa.
Questa è la storia di Errki.
Era cominciata così: aveva lasciato il manicomio alle tre del mattino.
«Non si chiama più manicomio, Errki; e anche se nel tuo universo privato
sei libero di chiamarlo come ti pare, sarebbe comunque opportuno che tu
tenessi conto degli altri e ti esprimessi diversamente. È questione di
cortesia. O di tatto, se vuoi. Non ne hai mai sentito parlare?» Quella donna,
perdio, era di una tale eloquenza da dargli l'impressione che ogni sua parola
scorresse sull'olio. Alle parole faceva seguire un suono, simile a quello di
uno stridulo organo elettrico.
«Si chiama Varden», disse lui allora, con un sorrisetto acido.
«Qui a Varden siamo tutti una grande famiglia. Il telefono suona: "Qui
Varden, posso aiutarla? Qualcuno può andare a ritirare la posta per
Varden?"» «Esattamente, è solo una questione di abitudine. Qui dentro
dobbiamo tutti dimostrare un po' di riguardo.» «Io no», ribatté lui,
immusonito. «Qui dentro mi ci hanno relegato in base al paragrafo cinque:
sono pericoloso per me e probabilmente per gli altri.» Si protese in avanti.
«È grazie alla mia malattia di merda se ti becchi uno stipendio di livello
ventisette!» le sussurrò all'orecchio.
La sorvegliante notturna ebbe un tremito. Era il momento della giornata
in cui si sentiva più vulnerabile. Una terra di nessuno tra la notte e il
mattino, un vuoto grigiastro in cui gli uccelli tacevano e non si era mai
sicuri di poterne risentire il canto. Un vuoto in cui tutto poteva accadere e
che lei ancora ignorava. Si accasciò sulla sedia, improvvisamente esausta.
Senza la forza di percepire il dolore di lui, ricordare chi era, rendersi
conto che era nelle sue mani. Lo riteneva semplicemente disgustoso,
egocentrico e brutto.
«Me ne rendo conto», sibilò. «Ma, dopotutto, sei qui da quattro mesi e, a
quanto pare, ti ci trovi abbastanza a tuo agio.» Pronunciò quella frase con le
labbra strette come il becco di una gallina. E l'organo eseguì un accordo
dissonante.
A questo punto se la squagliò. Fu un'impresa facile. La notte era calda e
la finestra socchiusa aveva uno spiraglio di quindici centimetri. Il battente
era stato fissato al telaio con un listello d'acciaio, ma lui risolse il problema
smontando il tutto con l'aiuto della fibbia della cintura. Le viti si staccarono
con facilità dal legno fradicio di quell'edificio vecchio di almeno cent'anni.
La sua camera era situata al pianterreno. Con la leggerezza di un passero
saltò dalla finestra e atterrò sull'aiuola.
Evitò di attraversare il parcheggio e si inoltrò nel bosco, inerpicandosi sul
sentiero che conduceva al laghetto, che tutti chiamavano il Pozzo. Poco
importava dove stava andando.
L'essenziale era non mettere mai più piede a Varden.
Il laghetto era bello, nella sua modestia. Non si dava importanza, giaceva
tranquillo e senza un'increspatura in quello scenario aperto e silenzioso.
Non lo respingeva, né lo attirava con le lusinghe a gettarsi in acqua. Non lo
toccava. Era lì, semplicemente.
L'ospedale psichiatrico era a un tiro di schioppo, nascosto dagli alberi.
Nestor lo pregò di fermarsi per qualche istante, e lui si fermò. Abbassò lo
sguardo sull'acqua scura del Pozzo. Nella sua mente affiorò il ricordo di
Tormod, che avevano trovato galleggiante con la faccia in giù, i guanti di
gomma che portava sempre e i capelli biondi che fluttuavano nell'acqua
verdastra. Non aveva un bell'aspetto, del resto non l'aveva mai avuto. Era
grasso e flaccido, aveva gli occhi inespressivi e, per giunta, era stupido. Un
tipo gelatinoso e ripugnante, che se ne andava in giro chiedendo scusa a
tutti, timoroso di contagiarli, di scomodarli, di rischiare che qualcuno
avvertisse il suo alito fetido. Quel poveretto, adesso, era nella casa del
Signore. Forse si aggirava su una nuvola sollevando spruzzi, finalmente
liberato da quei suoi guanti umidi. Chissà che non avesse ritrovato sua
madre, forse anche lei a zonzo su una nuvola accanto alla sua. L'aveva
amata, sua madre. Al ricordo di Tormod e dei suoi occhi sfuggenti dalle
ciglia chiare sentì un groppo in gola. Fece con il suo corpo esile un moto di
stizza, poi riprese a camminare.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo