Alberto Sordi segreto – Igor Righetti
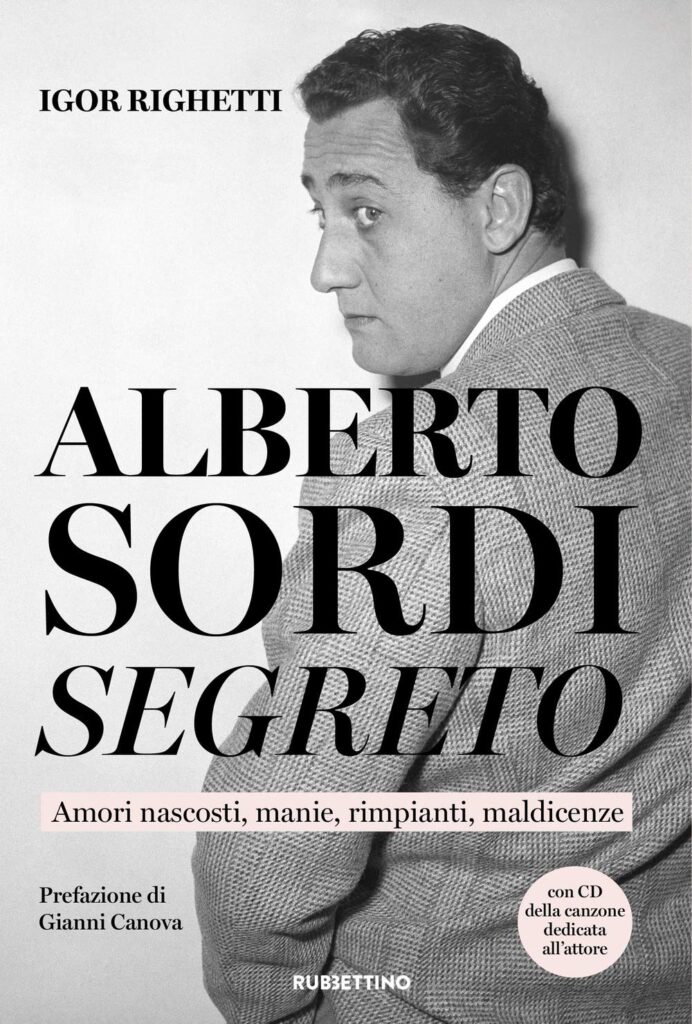
SINTESI DEL LIBRO:
Ciascuno di noi parenti di Alberto ha i suoi ricordi anche in base
all’età anagrafica. Il papà di Alberto morì quando lui aveva appena
vent’anni e non era ancora famoso. Quindi gli sono stati vicino quei
parenti che avevano una maggiore disponibilità economica anche
perché la mamma, Maria Righetti, non lavorava e aveva altri tre figli.
E ovviamente cinque persone non potevano certo vivere con il
lavoro saltuario di Alberto come comparsa. Fu lui stesso, per
esempio, a volere uno dei suoi cugini, Renato Ferrante, molto
somigliante a lui, in alcuni suoi film come L’avaro e Assolto per aver
commesso il fatto.
Alberto non ha mai negato di avere parenti o di non averli
frequentati. Se ciò fosse vero nessuno di noi avrebbe una foto con
lui, non avrebbe chiamato suo cugino Renato Ferrante come attore
in alcuni suoi film, Alberto non sarebbe mai venuto a cena con noi
nei ristoranti romani Cannavota o Perilli (lui amava anche l’Apuleius)
oppure non sarebbe venuto a trovarci a casa né avrebbe parlato
pubblicamente della zia Ginevra, sorella del padre Pietro (articolo di
Giovanna Grassi pubblicato sul “Corriere della Sera” del 14
dicembre 1996). Fin da bambino, come avviene in tutte le famiglie,
Alberto ha frequentato i suoi parenti assieme ai suoi genitori, a suo
fratello e alle sue sorelle. Come dimostrano anche alcune foto dei
nostri album di famiglia tra le quali il matrimonio di Carlo De Luca e
Fulda Sordi, cugina di Alberto. In prima fila c’è Alberto, serissimo con
la coppola. Già dall’espressione corrucciata che aveva in quella foto
si intuisce la sua opinione sul matrimonio! Poi Aurelia, Savina,
Giuseppe, Maria Righetti e il papà Pietro Sordi.
La famiglia Sordi, quindi, pur se molto riservata, ha sempre
frequentato i propri parenti come accade in tutte le famiglie. Quelle di
aver negato di avere parenti o di averli frequentati, quindi, sono mere
falsità (o «un parto della fantasia degli uomini che celano interessi di
parte» come le definiva Alberto) messe in giro dopo la sua morte da
chi millanta grande amicizia con lui, improbabili confidenze da lui mai
fatte in quanto molto diffidente ed estremamente geloso della propria
vita privata e che hanno soltanto interesse a screditare i suoi parenti
per trarne vantaggi esclusivi che non hanno e non avranno mai
perché il sangue si eredita, non si può comprare. E nessuna
vertenza giudiziaria potrà mai riconoscere a queste persone lo status
di parente di Alberto Sordi.
Mi spiace per loro, non hanno nemmeno una cellula di Alberto. Se
ne dovranno fare una ragione. A questi bugiardi, se Alberto avesse
saputo le falsità dei loro racconti detti dopo la sua morte, avrebbe
detto «pussa via!».
Per onore della verità, in occasione della 26ª edizione della mostra
internazionale del Nuovo cinema di Pesaro, nel 1990, Alberto
festeggiò il suo 70° compleanno e in un’intervista al Tgr delle Marche
dichiarò il suo affetto nostalgico verso quella città e quella regione in
quanto sua madre aveva vissuto alcuni anni nella cittadina e lì
conobbe suo padre che si era diplomato al conservatorio. Si
sposarono proprio a Pesaro nel 1910. In quell’occasione (l’intervista
si trova anche sul web) raccontò che la madre gli parlò di alcuni
parenti pesaresi che però lui non ha mai conosciuto. Ma non ha mai
detto, infatti, di non aver frequentato e conosciuto i suoi parenti
romani.
Dei parenti romani Alberto ne parlava eccome anche perché in
tanti lo avevano aiutato a realizzare il suo sogno. Come ha
dichiarato in diverse occasioni pubbliche anche la contessa Patrizia
de Blanck. Del resto, pure con la sua amata Andreina Pagnani (con
la quale Sordi ebbe la sua relazione più importante durata nove
anni) le immagini che li ritraggono insieme sono molto rare e quelle
poche che ci sono riguardano eventi pubblici come una prima
teatrale o una cena con altri attori al termine di uno spettacolo, ma
mai in atteggiamenti affettuosi. Alberto era legato alle Marche anche
per l’amicizia con il regista e impresario teatrale Mario Mattoli, nato a
Tolentino, il quale nel 1942 gli affidò il primo ruolo importante come
co-protagonista nel film I tre aquilotti. Con Mattoli, Alberto collaborò
per molto tempo anche in teatro.
Proprio la sua estrema riservatezza sulla sua vita privata lo ha
portato a chiedere a noi parenti di evitare di raccontare, finché fosse
stato in vita, episodi che lo riguardassero così come lui evitava di
parlare di se stesso o di altre persone che frequentava. Sapeva
bene, Alberto, che parlare di noi più del dovuto ci avrebbe esposti a
livello mediatico e avrebbe potuto provocare problemi nella
quotidianità. Inoltre, lui non amava farsi fotografare fuori dall’ambito
professionale dove invece era costretto e all’epoca, per sua fortuna,
non c’erano gli smartphone quindi è ovvio che immortalarlo non
fosse così facile. Per lui la privacy era fondamentale: proprio per
questo motivo non ha mai voluto mostrare in tv o sui giornali la sua
villa faraonica acquistata dopo anni di duro lavoro, una casa che per
lui rappresentava il rifugio dalla folla, non ha mai raccontato
pubblicamente i suoi amori così come non ha parlato della tanta
beneficenza che ha fatto, soprattutto verso istituti religiosi. Per
Alberto la filantropia va compiuta in silenzio. Detestava anche
l’ostentazione di lusso e ricchezza.
Era una persona semplice, un uomo vero. Dato che Alberto non
ha avuto figli così come le sue sorelle e suo fratello, noi siamo i suoi
soli parenti a portare avanti il cognome e non vorremmo mai che
anche lui, dopo tutto quello che ci ha regalato con la sua genialità,
possa essere dimenticato.
La nostra presenza accanto ad Alberto e Aurelia è sempre stata
discreta così come lo erano loro. Tanti di noi parenti lo abbiamo
frequentato fin da quando non era nessuno e chi ha potuto gli ha
dato una mano all’inizio della sua difficile carriera. Alcuni parenti lo
aiutarono a fare le pratiche all’Enpals segnalandogli le audizioni dei
film, altri ancora come la zia Ginevra, della quale Alberto parla in
alcune interviste, lo ospitava a casa sua a Valmontone e gli cucinava
deliziosi manicaretti.
Alberto non era certo lo “zio della domenica”: un artista che ha
trascorso la sua vita in scena, che ha realizzato oltre 200 film e che
ha dedicato la propria vita al suo lavoro tanto da non sposarsi
proprio per evitare di sottrarre energie preziose alla sua professione,
di tempo libero ne aveva ben poco. Ma le volte che ci siamo visti e
che abbiamo passato un po’ di tempo assieme (anche a mio nonno
Primo e a mio padre Alessandro) non ha mai mancato di essere
affettuoso.
Agli inizi della sua carriera fu mio nonno, Primo Righetti, a
regalargli lo smoking che Alberto indossò nei suoi primi spettacoli
teatrali al Quirino e al Quattro Fontane facendogli trovare anche un
po’ di denaro in tasca. Di questo, come di tanti altri episodi, ne ha
parlato anche Silvana Giacobini nel suo libro Albertone, pubblicato
da Cairo nel 2018. Il papà di Alberto morì nel 1941 quando lui aveva
appena 20 anni e non era ancora famoso. Mio nonno lo incoraggiò a
proseguire nel suo sogno, lo sostenne e fece riflettere Pietro sul
grande talento e la forte determinazione del figlio che non voleva far
altro nella vita se non l’attore. E Alberto gliene fu sempre grato, tanto
che anni dopo, quando mio nonno si paralizzò, provvide a farlo
curare da un luminare della scienza e al suo ricovero in una clinica di
lusso. Il tutto a sue spese. Mio padre, invece, realizzava con lui le
statuine di gesso del presepe per la parrocchia di Santa Maria in
Trastevere. Successivamente Alberto lo volle come capoclaque nei
suoi spettacoli, cioè colui che faceva partire gli applausi nei teatri in
cui si esibiva all’inizio della sua carriera. Gli scriveva sul copione le
parti in cui mio padre doveva far intervenire gli spettatori. Alcuni
elementi decorativi della sala cinematografica della sua villa romana,
Alberto li fece realizzare a mio padre Alessandro. A proposito della
sala cinematografica-teatro dove Sordi vedeva i film con, al suo
interno, un vero e proprio palcoscenico, il soffitto ricoperto
totalmente con bassorilievi a forma di pellicola e ai lati alcune
sculture di Ceroli rappresentanti l’allegoria delle arti, lascia attoniti la
recente scelta di aver sostituito i meravigliosi divani di velluto di
colori diversi (voluti da Alberto) della platea con file e file di anonime
sedie in plastica blu che si possono trovare in un qualunque centro
congressi. Sedie che hanno tolto quel fascino voluto e pensato da
Alberto con i divani di velluto che rappresentavano lo spirito e
l’essenza del suo modo di concepire quello spazio intimo e raccolto
a lui tanto caro. Dal 2015, tra l’altro, gli oggetti della villa sono sotto
tutela dei Beni culturali. Quando si destina a museo la casa di un
personaggio tutto dovrebbe restare come il personaggio ha voluto gli
ambienti per evitare di creare un falso agli occhi del pubblico che,
per la prima volta, la visita convinto di avere di fronte la versione
originale.
Il destino ha voluto che Alberto e mio padre si ritrovassero insieme
grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale di Grosseto
che alcuni anni fa dedicò una via ad Alberto Sordi nella zona degli
artisti. Di recente il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna
assieme alla sua giunta e, in particolare, all’assessore al Bilancio e
Finanze Giacomo Cerboni, hanno deciso di intitolare una via accanto
a quella dedicata ad Alberto anche a mio padre, scultore di fama
internazionale, nato a Roma, ma trapiantato nel capoluogo della
Maremma, territorio del quale rimase affascinato. Qui aveva
realizzato il suo studio frequentato da giovani artisti di tutto il mondo
che venivano ad apprendere da lui le tecniche per la fusione a cera
persa del bronzo e dell’acciaio (di quest’ultimo metallo è stato
pioniere e i suoi monumenti si trovano in tanti Paesi del mondo) e
per imparare le tecniche per scolpire la pietra. A mio padre fu
assegnata dal presidente Sandro Pertini la medaglia d’oro al merito
artistico, era accreditato dall’Ambasciata degli Stati Uniti di Roma
come esperto d’arte e restauro archeologico, venne insignito del
Professorato accademico della Free World International Academy,
nel Michigan, e nel 1977 ricevette il Premio Italia per il bronzetto e la
scultura. I due cugini, quindi, uniti dalla stessa passione verso l’arte,
adesso possono continuare a comunicare e a farsi due risate sul
mondo che li circonda e che passa dalle loro vie.
Ho frequentato Alberto in tante occasioni proprio grazie al rapporto
speciale che aveva con mio nonno e con mio padre. Ricordo con
particolare piacere quando nel 1982 venne a girare nella spiaggia di
Cala di Forno, nel parco della Maremma, a pochi passi dallo studio
di scultura di mio padre anch’egli come Alberto sempre in giro per il
mondo a causa del suo lavoro, una parte del film In viaggio con
papà. Fu ospite a cena a casa nostra. Per attirare la sua attenzione
preparai le imitazioni di alcuni personaggi come Bombolo. Ci
facemmo tante risate e mi diede alcuni consigli su come impostare la
voce.
Sono stato nella faraonica e austera villa di Roma in via Druso,
accanto alle Terme di Caracalla, con mia nonna Adele, molto amica
di Savina, la sorella più grande di Alberto, insegnante di religione e
lettere in una scuola secondaria, con la quale cuciva e faceva lavori
di ricamo. All’epoca io avevo tre anni e mia nonna mi portava con lei.
Aurelia mi offriva sempre una caramella alla menta credendo mi
piacesse dato che per non farla rimanere male la accettavo di buon
grado nonostante non amassi la menta. Aurelia amava le bambole e
i peluche (ne aveva decine) alcuni dei quali le furono regalati da mia
nonna, da mio padre e due da me. Ricordo alcune giornate
meravigliose trascorse assieme alla mia famiglia ospiti della sua villa
a Castiglioncello, in provincia di Livorno, dove Alberto organizzò una
mostra delle opere di mio padre nel castello Pasquini. E ancora: a
casa della contessa Patrizia de Blanck. Mio padre era amico del
fratello pittore di Patrizia, Dario. Ricordo una scena molto divertente:
lei mescolava l’insalata con le mani, dopo un accurato lavaggio,
perché diceva che così si condiva perfettamente e io e Giada, la
figlia di Patrizia, eravamo delegati a togliere i semi ai pomodori
perché Alberto li detestava. Lui la guardava divertito e un po’
perplesso mescolare l’insalata con le mani e diceva che poteva
essere una scena di un suo film con Anna Longhi. E ancora: il 24
aprile del 2002, l’Università degli studi di Salerno gli conferì la
seconda laurea honoris causa in Scienze della comunicazione che
dedicò alla madre, Maria Righetti. È stato lui, con i suoi preziosi
consigli sul linguaggio radiofonico, a farmi innamorare della radio,
strepitoso mezzo di comunicazione che all’epoca non avevo preso in
considerazione.
Nel 1986, a 17 anni, la stessa età in cui Alberto cominciò a fare la
comparsa, mentre stavo studiando al liceo artistico partecipai,
assieme a mio fratello Valter di quattro anni più grande di me, e vinsi
un provino a Videomusic, la prima tv musicale europea sbarcata in
Italia nel 1984 (poi diventata Tmc2 e, successivamente, MTV Italia).
Ero autore dei miei testi e inviato del programma Crazy Time di Clive
Malcolm Griffiths e Rick Hutton, due inglesi che rivoluzionarono con
il loro stile british il modo di condurre programmi musicali in tv. Nel
frattempo studiavo inglese, dizione e recitazione e collaboravo al
quotidiano «La Nazione» perché il mio sogno era quello di diventare
un giornalista-anchorman a tutto tondo come quelli che vedevo nei
film americani. Come seppi di aver vinto l’audizione a Videomusic
chiamai Alberto per comunicargli la notizia. Lui non conosceva
questa nuova emittente musicale, si complimentò con me ma mi
disse: «Scugnizzo (mi chiamava spesso così per via dei miei occhi
furbetti e della mia forte personalità indipendente) prova anche la
radio, è un mondo che ti permetterà di esprimere al meglio la tua
grande creatività».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :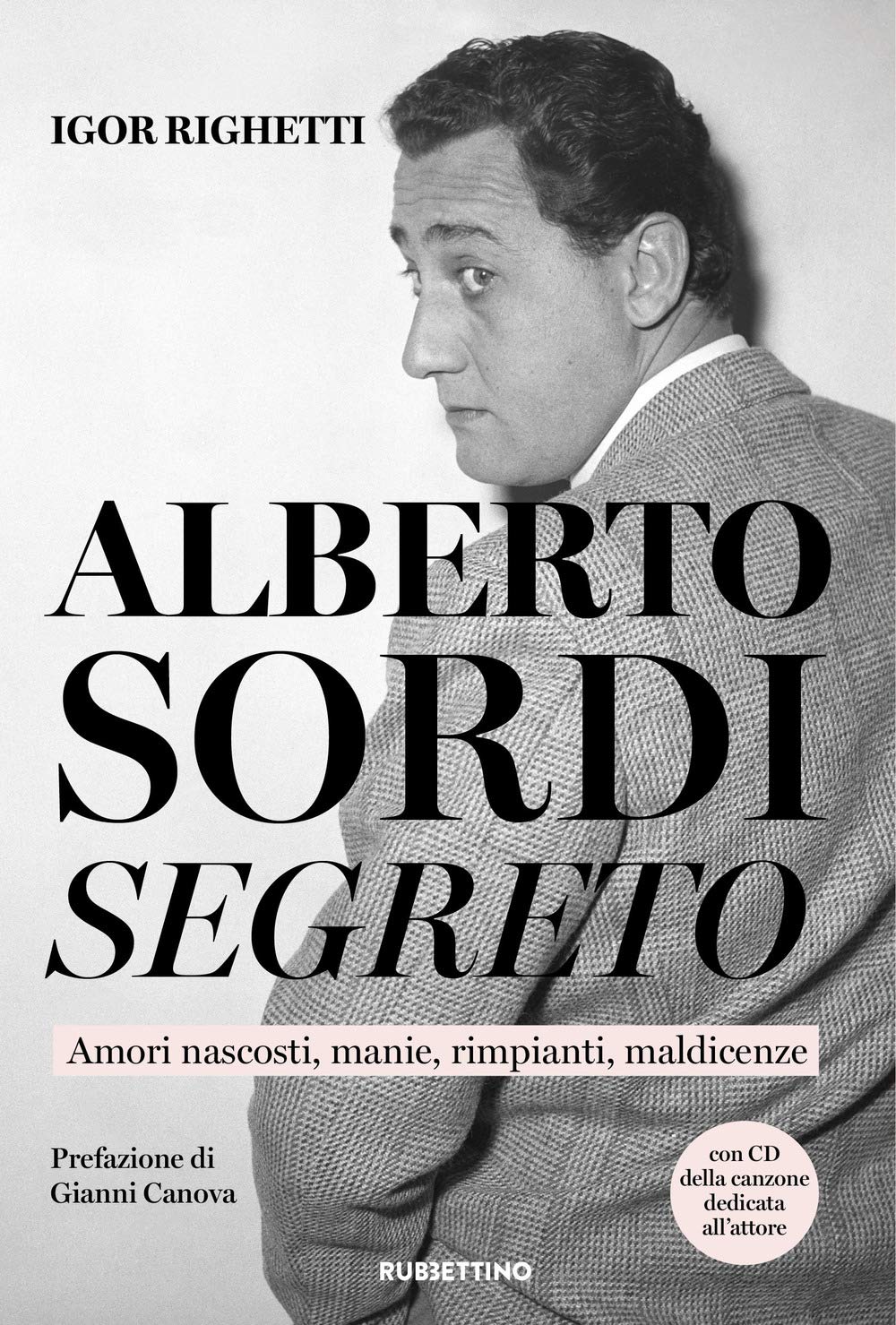






Commento all'articolo