Non per me sola – Valeria Palumbo
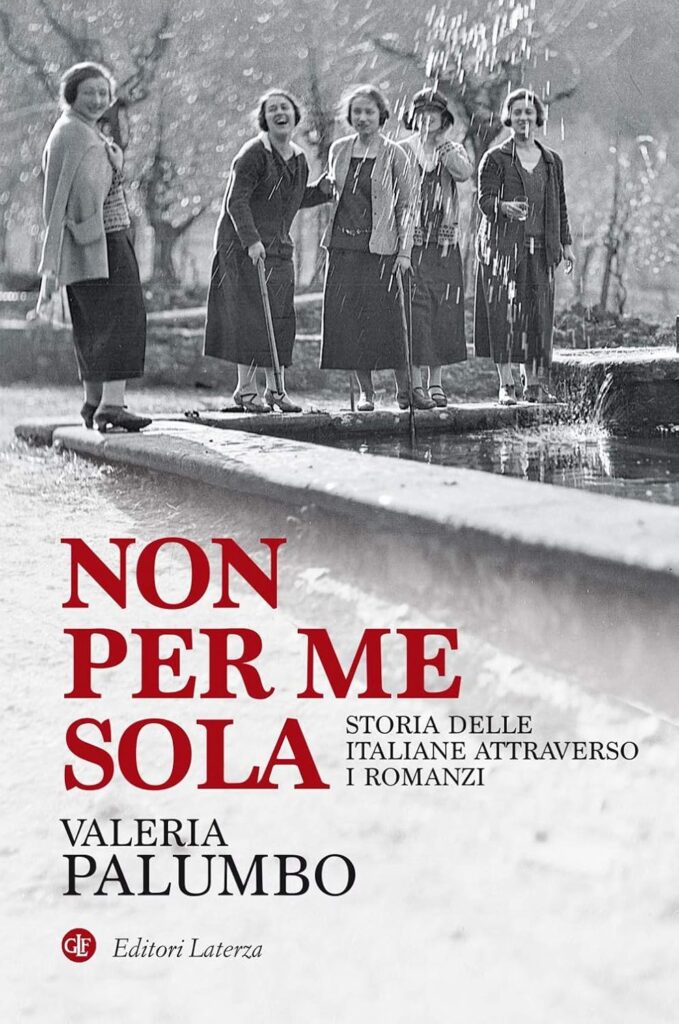
SINTESI DEL LIBRO:
Sto seduta sui calcagni, con gli occhi su questa lapide che di più spoglie
non ce n’è.
Una voce alle spalle, sorda, perentoria:
«E smettila di piangere. La figlia del Manzini non piange».
«Ma io non sono riuscita a meritarmi di essere la figlia del Manzini.
Vorrei che lui non sapesse, che non avesse mai saputo, quanto poco m’è
riuscito trattenermi dal piangere; anzi quante lacrime ho perduto
vergognosamente».
Il babbo, accorrendo:
«Non è vero: non ti ho mai vista piangere».
«Perché ero con te. Finché ero con te».
«E questo non ti sembra sufficiente?».
Gianna Manzini, Ritratto in piedi, 1971
Se non ce l’hanno fatta, il più delle volte è stata colpa loro. Se sono
riuscite, spesso è stato merito loro: dei padri. Perché, complice una
legislazione che delegava loro tutti i poteri sulla famiglia, i padri hanno
deciso per secoli il destino dei figli. E in particolare delle figlie, che non
potevano abbandonare la famiglia e scegliersi una vita. Qualche volta a
dare una mano alle ragazze sono stati i fratelli. Spesso, invece, sono stati
loro a complicare le cose. In questo quadro spiccano, bellissime, figure
come quella di Giuseppe Manzini (1853-1925), mazziniano, socialista e
anarchico, perseguitato dai fascisti. È stato tra i pochi coerenti, tra idee
politiche e atteggiamento illuminato, in privato, verso la figlia, la
scrittrice Gianna Manzini (1896-1974). Lei, in Ritratto in piedi, gli ha
restituito tutta la sua mite grandezza. E ha anche riconosciuto, con una
singolare onestà, la difficoltà di una tale eredità morale e il bisogno di
costruirsi un’identità autonoma:
Ma la cosa tremenda è che bisognava che tu non ci fossi, babbo, perché io potessi finalmente
calarmi tutta nella mia repentina, rapinosa giovinezza. Ti allontanavo. Chiudevo gli occhi sul
pensiero di te, mio orgoglio, mio vero blasone, mio maestro assoluto, poesia fatta vita.
La conclusione del libro ribalta, nell’apparente dichiarazione di
dipendenza, l’idea da sempre così diffusa che le donne fossero perenni
minorenni. Solo una donna libera come Gianna poteva riconoscere
quanto doveva al padre, in un rapporto d’amore che è riconoscimento
reciproco:
Ma, rimasta sola, senza la tua guida, io sbando, finisco col cercare altro, o cerco male. Sola: ho
freddo, babbo.
All’estremo opposto del coerente ma defilato Giuseppe Manzini, un
campione del libero pensiero come il marchese Cesare Beccaria, autore
del pamphlet Dei delitti e delle pene: per sé, scelse un matrimonio d’amore
con Teresa Blasco, nel 1760, salvo poi elemosinare il mantenimento dal
padre. Ma poi, dopo la morte della moglie e un nuovo matrimonio,
impose alla figlia Giulia sei anni nel collegio annesso al convento di
clausura di San Paolo delle Angeliche, una vera reclusione. E la obbligò
alle nozze, a 20 anni, con il conte Pietro Manzoni, che di anni ne aveva
46, ovvero due più di Cesare, godeva fama d’impotente e coltivava idee
opposte a quelle progressiste tra le quali, almeno teoricamente, Giulia era
cresciuta. Il punto è che il matrimonio permise a Beccaria di risparmiare
sulla dote. Finì che Giulia fece un figlio, il futuro scrittore Alessandro
Manzoni, con Giovanni Verri. Poi, nel 1792, ottenne la separazione e
andò a vivere con il grande amore della sua vita, Carlo Imbonati. Dovette
abbandonare Alessandro, che, sia per questo, sia per il suo perbenismo,
non glielo perdonò. Almeno fino a quando non decise di farne la donna
più importante della sua vita. In compenso, a non perdonare mai Giulia
fu la Milano di inizio Ottocento, tutt’altro che illuminata per quanto
riguardava le donne. Giulia, nella memoria collettiva, è rimasta una
strega.
Di queste contraddizioni, tra idee progressiste sostenute, anche con
coraggio, in pubblico, e il più cupo tradizionalismo coltivato in privato,
spesso per motivi di interesse, è tappezzata la storia di molti “padri della
patria”. L’anarchico Andrea Costa, lasciato dalla compagna Anna
Kuliscioff (1855-1925) anche per la sua feroce gelosia, tentò di opporsi al
matrimonio della figlia Andreina con Luigi Gavazzi, rampollo di una
ricca famiglia di industriali milanesi della seta. Anna Kuliscioff, in una
celebre lettera, gli scrisse:
Milano, 27 marzo 1904. Mio caro Andreino, sì, hai ragione, è una gran malinconia di dover
convincersi che noi non siamo i nostri figli, e che essi vogliono far la loro vita, astrazione fatta dai
genitori, come l’abbiamo fatta noi ai nostri tempi...
La grande socialista, rivoluzionaria e “dottora dei poveri” (fu tra le
prime laureate in medicina) non sosteneva affatto di essere felice della
scelta della figlia, ed esprimeva con tutta sincerità di essere delusa da
questa ragazza, religiosa, votata alla famiglia e con nessuno spirito ribelle.
Addirittura dichiarava di considerare un fallimento la sua educazione. Ma
stabiliva un principio che all’anarchico Costa non passava neanche per la
testa: che Andreina avesse il diritto di scegliere.
Come buoni e convinti socialisti dobbiamo rispettare anche la volontà e l’individualità dei nostri
f
igli, sotto questo rapporto non ho nulla da rimproverarmi, ed ho la coscienza tranquilla d’essermi
comportata come onestamente e sinceramente sento il dovere della maternità...
Riconosceva inoltre che le sue scelte politiche avevano penalizzato la
ragazza, e che Luigi, il fidanzato, aveva avuto coraggio nello sfidare la
famiglia e nel voler, a tutti i costi, sposarla:
Io sapevo che un giovane di famiglia borghese, dati i pregiudizi sociali, familiari e religiosi,
difficilmente se non molto innamorato la sposerebbe per le presunte colpe della madre, che
schiaffeggiava la società sotto tutti i rapporti...
E concludeva, con una serenità esemplare:
Mi pare primitivo il sentimento dei genitori che vogliono esercitare pressioni sull’animo dei figli.
Se la Ninetta [Andreina] fosse minacciata da una disgrazia, se l’uomo da lei prescelto fosse
indegno, allora per la sua salvezza, per il suo bene si può anche violare le norme di libertà di
coscienza e di azione. Ma se va incontro alla sua felicità, sia pur benedetta anche dal prete, ne sono
contenta ugualmente...
Pochissimi padri avrebbero condiviso la sua posizione e avrebbero
rispettato la libertà delle scelte “ribelli” delle figlie. Soprattutto per un
motivo che, con la loro felicità o il loro benessere, non c’entrava proprio
nulla. Ovvero, per “l’onore”, una sorta di chiavistello sociale che
impediva alle ragazze qualsiasi libera decisione. L’articolo 587 del codice
penale sul “delitto d’onore” riconosceva anche a padri e fratelli (ma non a
madri e sorelle) una riduzione abnorme della pena in caso di assassinio
per “l’onor suo o della famiglia”. L’assoluzione, poi, era quasi la norma.
Ciò – va detto – caricava sui padri un peso sociale non indifferente e
creava “effetti collaterali” vistosi: nella Traviata (1853) di Giuseppe Verdi,
Giorgio Germont, il padre di Alfredo, si impegna ad allontanare Violetta
per salvare il matrimonio della figlia, il cui onore sarebbe “macchiato” dal
fatto che il fratello frequenti (in realtà si faccia mantenere) da una
prostituta. Non l’onore di Alfredo sarebbe rovinato, dunque, ma quello
della sorella, di cui nemmeno viene fatto il nome.
Detto questo, molti padri neanche si sforzavano di capire perché la figlia
fosse stata “disonorata”, cioè perché avesse scelto di avere rapporti sessuali
o li avesse accettati. In Una donna, Sibilla Aleramo spiega molto bene
come il padre si rifiuti addirittura di comprendere che la figlia è stata
violentata da un suo dipendente perché «si sapeva tanto temuto da
chiunque lo avvicinava» da non poter neanche immaginare che un
impiegato potesse mettere le mani sulla sua bambina. Nonostante il
disperato tentativo della madre di difenderla, Sibilla ha però un destino
segnato e si sente costretta a sposare il suo stupratore, convinta che ciò che
ha subìto la lega ormai indissolubilmente a lui. Ma ciò non la mette al
riparo dall’ira paterna:
Dall’addensarsi del biasimo generale sul suo capo, dal presagio di imminenti catastrofi, traeva
una disperata smania di tirannia e di vittoria ad ogni costo.
Oggi che si parla tanto di violenza sulle donne, tacendone spesso le
radici antiche, si evita di ricordare che i primi violenti sono stati da
sempre i padri. E che la loro violenza era prima di tutto garantita dalla
legge: lo “jus corrigendi” dell’art. 571 del codice penale autorizzava l’uso
della violenza su moglie e figli e fu fatto decadere dalla Corte di
Cassazione soltanto nel 1956. Anche la Chiesa ci metteva del suo, traendo
dalla tradizione ebraica – che parla di “ira di Dio” in modo quasi ossessivo– il diritto dei padri alla furia. In Ezechiele 7, 8-9 troviamo:
Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò
secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze. Né s’impietosirà il mio
occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile della tua condotta e saranno palesi in
mezzo a te le tue nefandezze: saprete allora che sono io, il Signore, colui che colpisce.
Così in cielo, così in terra. Ovviamente la violenza dei padri si esercitava
anche sui figli maschi. Ma lasciava impronte indelebili sulle bambine. Lo
spiega benissimo Natalia Ginzburg (1916-1991) in Lessico famigliare, del
1963, parlando del padre, il celebre professore, medico e anatomista
Giuseppe Levi (1872-1965), maestro di tre premi Nobel: Rita Levi
Montalcini, Renato Dulbecco e Salvador Luria.
Vivevamo sempre, in casa, nell’incubo delle sfuriate di mio padre, che esplodevano improvvise,
sovente per futili motivi, per un paio di scarpe che non si trovava, per un libro fuori posto, per una
lampadina fulminata, per un lieve ritardo nel pranzo, o per una pietanza troppo cotta. Vivevamo
tuttavia anche nell’incubo delle litigate tra i miei fratelli Alberto e Mario, che anche quelle
esplodevano improvvise [...]. «Si amazzano!» gridava mia madre, trascurando l’emme doppia nello
spavento. «Beppino vieni, si amazzano!» gridava chiamando mio padre. L’intervento di mio padre
era, come ogni sua azione, violento. Si buttava in mezzo a quei due avvinghiati a picchiarsi, e li
copriva di schiaffi. Io ero piccola; e ricordo con terrore quei tre uomini che lottavano
selvaggiamente.
La violenza non era dunque soltanto prassi nelle classi più povere e meno
istruite. Lo era, poi, non solo di padri e fratelli, ma anche di zii e tutori. Il
tragico e bel romanzo della scrittrice veneta Paola Bianchetti Drigo
(1876-1938), Maria Zef (1936), racconta il calvario di una bambina,
Mariutine, “adottata” con la sorellina Rosute, dopo la morte del padre,
dallo zio (Barbe, “zio”, in friuliano) fratello del padre. Barbe è un
alcolizzato. Il mondo che circonda Mariutine è un concentrato di
miseria, sporcizia, lavoro durissimo. Perfino la madre delle bambine è
senza pietà. Si è messa con Barbe per sopravvivere, ma lo detesta. Non
prova alcuna tenerezza per le figlie. Alla sua morte, le due ragazze
rimangono in balìa dello zio. L’uomo, fra l’altro, pretende di dormire con
loro nell’unico letto, cosa che la madre era riuscita a impedirgli. Scrive
Drigo dei dubbi di Mariutine:– La mâri non voleva – disse a sé stessa. Ma si sentiva timida, debole, bambina, incapace di
rifiutarsi d’obbedire, se Barbe Zef comandava. – Dio mio... La mâri non voleva...
Se il Barbe insisteva, che fare?... La madre poteva trattar con lui da pari a pari, ma lei, come
avrebbe potuto?... Era lui il padrone, adesso. Veramente, lo era anche prima, ché di una cosa
Mariutine era ben certa, sebbene nessuno gliel’avesse detto, che il padre morto aveva consumato
tutta la sua parte, non aveva nessun diritto sulla malga e sul gregge. Barbe Zef le aveva dunque
tenute per carità, e adesso che non c’era la mâri, se si disgustava, poteva cacciarle da un momento
all’altro. Rosùte forse no, ché era troppo piccina, ma, lei, poteva mandarla serva in qualche malga
di pastori, lontano, separata dalla sorella...
Il romanzo si conclude in modo tragico: dopo essere stata stuprata dallo
zio, Mariutine non fugge. I motivi sono diversi: ha paura di lasciare la
sorella nelle mani del mostro, come ragazza sola non ha molte chances di
rifarsi una vita e poi quell’uomo le fa paura, anche se la morte le appare
come l’unica soluzione ragionevole al suo calvario. È costretta così a
sostituire la madre. Ma a un certo punto realizza che Rosute è figlia di
Barbe. E che lui, lasciato solo con la bambina, non si farebbe scrupolo a
violentare anche lei. Allora prende una decisione terribile: uccidere
l’uomo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :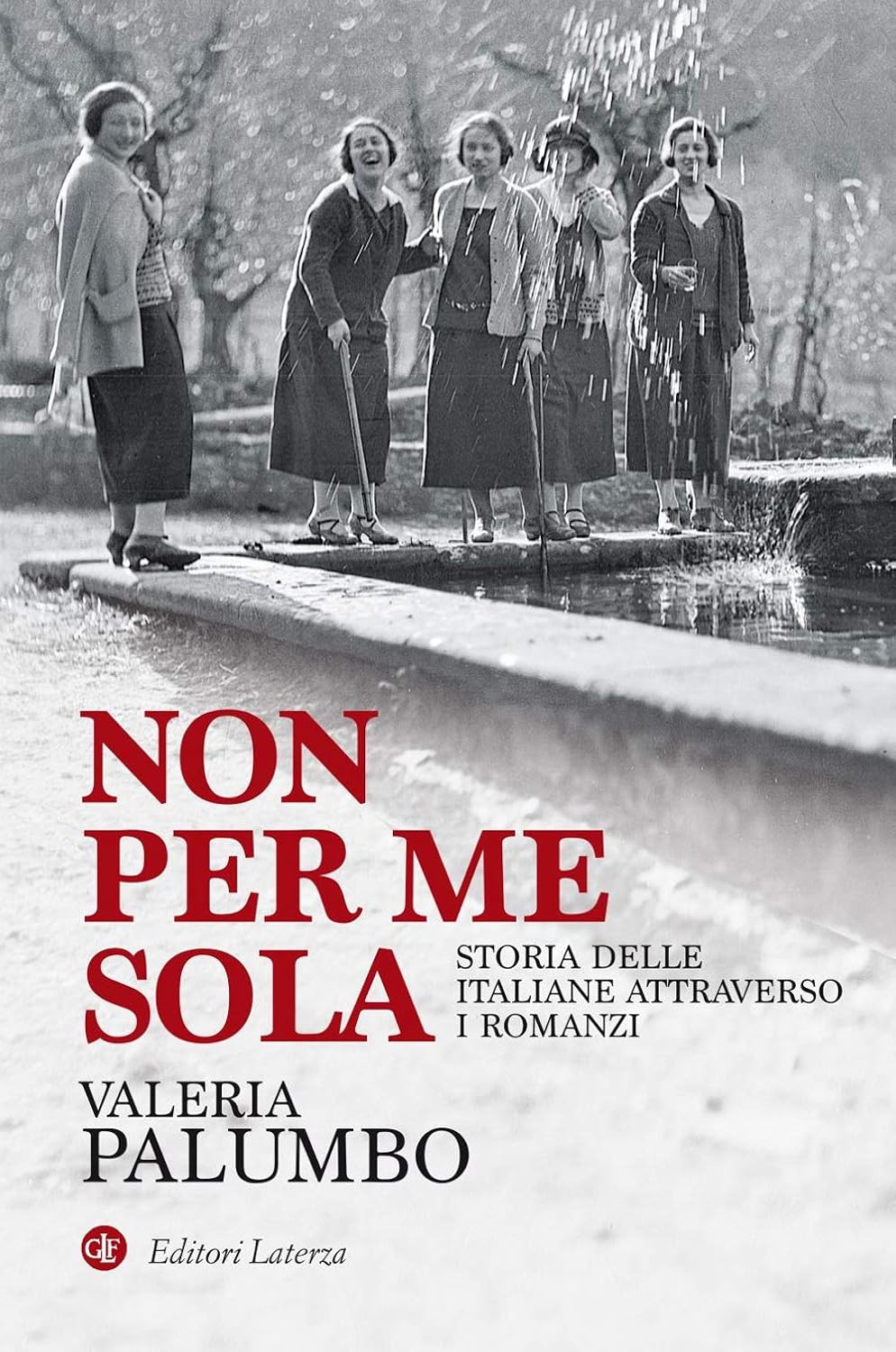






Commento all'articolo