Non esistono posti lontani – Franco Faggiani
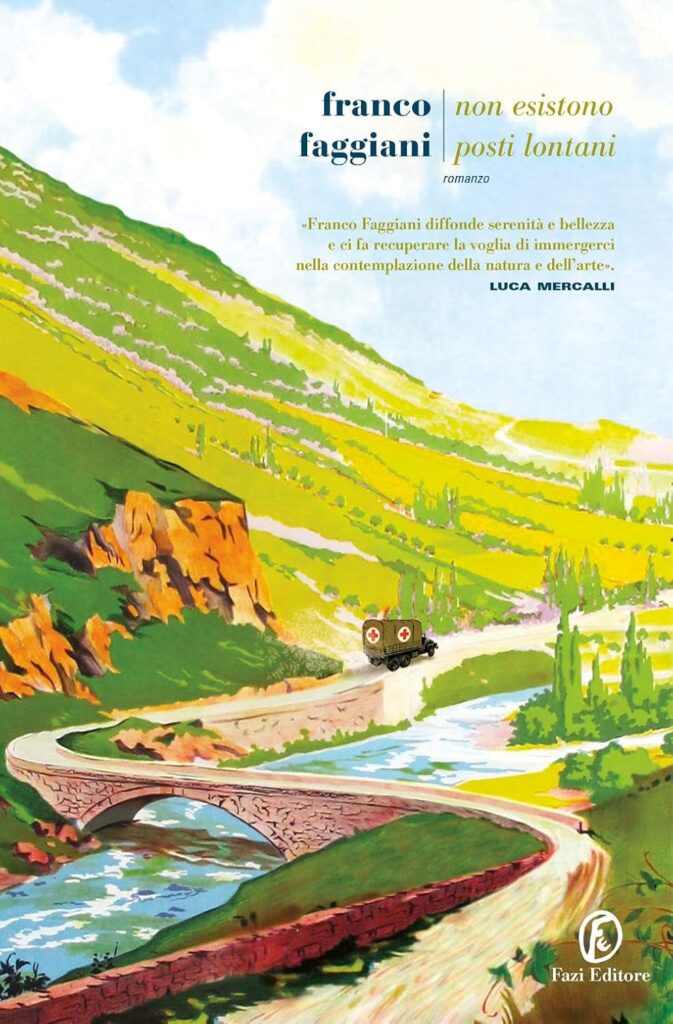
SINTESI DEL LIBRO:
Gli diedi una grattatina sotto il mento, tra il pelo fine e setoso. Lui
chiuse gli occhi, tendendo le piccole orecchie appuntite all’indietro, e
si strusciò contro la mia gamba; poi si ritrasse appena sulle zampe
posteriori e fece un balzo improvviso planando sulle mie ginocchia
con la leggerezza di un fiocco di neve. Allora lo accarezzai sulla
fronte e lui, Kaiser, il gatto nero della Buschenschank, il maso che
aveva la grande stanza del piano terra adibita a osteria, si
acciambellò e chiuse gli occhi. Proprio come faceva la mia Nenè.
La proprietaria del maso, dove agli scarsi avventori di passaggio
venivano serviti a tutte le ore il vino della casa e un’abbondante
minestra di orzo e lardo, accennò finalmente una specie di sorrisetto
storto, più che altro una smorfia di approvazione. Sebbene io
parlassi tedesco come un cittadino di Innsbruck, appena poco al di là
del confine con l’Austria, e mi comportassi in maniera educata, ero
italiano. Romano per l’esattezza, e Roma era molto, molto a sud di
Bolzano, perciò ero automaticamente meritevole della più assoluta,
seppur silenziosa, ostilità o, a essere proprio indulgenti, di una
malcelata indifferenza. Insomma, Kaiser quella sera ebbe un grande
merito: mi rese meno sgradito agli occhi della sua padrona.
Così – con il gatto che ronfava sulle ginocchia, la minestra
squisita, Frau Katharina meno arcigna del solito e il calore diffuso
dalla stufa –, il tramonto mi sembrò più sopportabile. Avrei cenato
ancora una volta in silenzio, poi, con molta calma, mi sarei avviato
lungo la strada sinuosa tra i vigneti, poche centinaia di metri fino
all’abbazia di Novacella, dove da alcuni giorni avevo affittato una
stanza. In realtà, nonostante i buoni uffici di monsignor Bartolomeo
Bauer, della Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, agostiniano
così come lo erano i monaci di Novacella, mi avevano sistemato in
una camera dagli arredi assai spartani e, quel che era peggio,
decisamente gelida. Così ogni sera, dopo essermi spogliato a fatica,
ero costretto a seppellirmi sotto cinque strati di ruvide coperte fino al
mattino successivo, con la speranza di essere svegliato, oltre che
dai fastidiosi rintocchi di una piccola campana, anche da un
benevolo raggio di sole.
Avevo preso l’abitudine di fermarmi al maso fin dalla seconda
sera in cui, dopo un interminabile viaggio in treno, avevo messo
piede a Bressanone. C’ero entrato quasi per caso; l’edificio in pietra
e legno si trovava lungo la strada che i monaci mi avevano subito
indicato per muovermi a piedi nei dintorni dell’abbazia; aveva inoltre
un aspetto solido e un’insegna che prometteva una buona cucina
casalinga. Ma soprattutto, scrutando attraverso lo spiraglio tra le
tendine di una finestra, avevo notato un tavolo libero accanto a una
grande stufa di maiolica verde che, proprio in quel momento, Frau
Katharina stava caricando con dei bei ciocchi di legna da ardere.
Non c’era niente di più invitante di un posto caldo in quell’inizio di
aprile del ‘44, che non ricordava affatto il debutto della primavera ma
piuttosto la coda ancora guizzante dell’inverno. Da nord la sera
soffiava un vento gelido e anche di giorno il freddo mi sembrava
decisamente pungente. Forse perché, a Roma, l’inizio della
primavera ero abituato ad assaporarlo dalle finestre aperte che
davano sul piccolo giardino interno del caseggiato in cui abitavo, col
sole che entrava nella stanza consentendomi di vedere in controluce
le prime foglie tenere, quasi trasparenti, di un tiglio.
A scaldarmi la pancia, quando rimanevo in poltrona e, tra le
tegole e i comignoli della casa di fronte, osservavo i merli andare a
caccia delle lucertole affacciate dai loro stretti nascondigli,
provvedeva Menelik, che mi ero portato a casa da una campagna di
scavi a Adulis, a sud di Massaua, in Eritrea. Menelik era chiamato
affettuosamente Nenè perché, sebbene avesse un nome importante,
quello del grande imperatore etiope, era in realtà una gatta. Austera,
a tratti selvatica e indomabile, sfoggiava un pelo morbido e fitto di un
colore simile a quello di una lepre: marrone fin sulla punta della
coda. Nenè, ogni volta che mi lasciavo andare in quella poltrona
davanti alla finestra attraversata dal tepore del sole, con un balzo
silenzioso ed elegante mi finiva in grembo e lì, dopo essersi
stiracchiata le zampe e aver inarcato la schiena per qualche istante,
si concedeva profondi pisolini e si guadagnava prolungate carezze.
Lei era la mia unica compagnia, in quella grande casa di famiglia
ormai piena solo di stanze vuote.
Da quando ero partito per venire quassù, a due passi dall’Austria,
andava Artemio, il portinaio, a darle da mangiare. Senza però mai
vederla, come al solito, perché lei se ne sarebbe rimasta nascosta e
guardinga fin quando lui non fosse uscito dall’appartamento tirandosi
dietro la pesante porta.
Artemio, che da quando era diventato vedovo dedicava la sua
vita a quella dei condomini, meglio se benestanti, era da almeno sei
mesi la mia principale fonte di sostegno. Non tanto perché accudiva
la gatta quando io ero via, ma perché riusciva molto spesso a
procurarmi quello che serviva per vivere in un periodo molto
complicato.
L’11 settembre 1943 il feldmaresciallo Kesselring aveva
dichiarato Roma zona di guerra e il 22 gennaio 1944 gli alleati erano
sbarcati ad Anzio, dove si erano però fermati per riorganizzare le fila
prima di puntare a nord, con l’obiettivo di prendere la capitale. Ma in
città tutto era degenerato il 24 marzo, il giorno dopo l’attentato di via
Rasella; era scattato un inarrestabile susseguirsi di arresti, di
fucilazioni, di azioni di guerriglia, specie nelle borgate, e di
repressioni violente. La quotidianità si era trasformata in caos anche
per chi, come me, se n’era sempre stato defilato: niente più gas,
luce, possibilità di muoversi liberamente per la città. Nelle vie strette
intorno a casa mia, a Campo Marzio, non c’era più niente e non
passava più nessuno; c’erano solo negozi vuoti, in abbandono o
distrutti da rappresaglie dimostrative, per fare in modo che la paura
si trasformasse in terrore. Anche uscire di casa per cercare di
procurarsi qualcosa da mangiare era un grosso rischio. Un mio
vicino, un notaio galantuomo, poco prima che io partissi venne
pestato ferocemente proprio sotto il portone da due suoi conoscenti,
solo per rubargli una busta di pasta e un sacco di patate mezze
ammuffite che era riuscito a trovare chissà dove, spendendo chissà
quanti soldi.
Non capivo se Artemio fosse astuto, fortunato, avventato o
avesse contatti privilegiati, ma, in mezzo ai disagi e ai pericoli,
riusciva ancora a ricevere con una certa regolarità da Pozzaglia, il
suo paese d’origine nascosto tra i boschi della Sabina, formaggi,
salami, pane, olio, verdure fresche e, ogni tanto, anche della carne
di pecora, oltre a qualche sacco di carbone per cucinare. Non avrei
saputo dire se Artemio mi rifornisse perché mi doveva ricambiare per
alcuni vecchi favori, per stima o per i soldi che gli passavo senza
battere ciglio, ma grazie a lui negli ultimi mesi ero riuscito a mettere
in tavola qualcosa di nutriente e spesso anche di gustoso.
Tutto questo fin quasi al termine di marzo, quando, un po’ a
sorpresa, il mio direttore al Ministero dell’Educazione nazionale,
l’esimio professore Alberico Musmeci, mi aveva fatto chiamare per
dirmi che sarei dovuto partire in missione. «Per Bressanone», aveva
detto puntando l’indice sulla carta geografica appesa a una parete
del suo ufficio, come se fosse stato un posto in capo al mondo.
A dir la verità, del vecchio e glorioso Ministero restava ben poco,
solo qualche polveroso ufficio di scansafatiche, gente che
girovagava da una stanza all’altra a cianciare di politica, del regime,
del re, dei comunisti, di che fine avevano fatto certi dirigenti che non
si erano fatti più vedere da un giorno all’altro. Anche io, per molti, ero
una figura aliena. Anni prima, quando era arrivata l’età del mio
pensionamento e mi ero già rassegnato a una vita di solitari studi
accademici, i miei superiori mi avevano chiesto, pregandomi quasi,
di rimanere al mio posto. Perché ero ancora una figura di spicco,
ben nota nel mondo archeologico internazionale, «un fulgente
esempio», proprio così avevano detto. E io, per vanità e per
interesse, avevo accettato, senza sapere che ben presto sarei finito
come un biglietto da visita sgualcito sul fondo di un cassetto.
Inoltre, da qualche tempo, nessuno sapeva più da che parte
stare. Avevamo ormai due organismi contrapposti, uno a nord, a
Padova, dunque nella Repubblica di Salò, e uno a sud, nella Salerno
liberata, dove s’era installato il governo Badoglio. E noi, una
manciata di logori funzionari senza più arte né parte, eravamo stati
abbandonati al centro, per dare testimonianza che Roma fosse
ancora una capitale artistica e culturale, ma con le stanze dei musei
e delle pinacoteche sempre più vuote e con ormai nessun’altra
attività che non fosse quella di firmare inutili carte.
Era da un po’ di tempo che Musmeci non si faceva vivo con me.
Forse si sentiva in imbarazzo per la mia ultima “presa di posizione
professionale”, chiamiamola così. Io e il professore eravamo stati a
lungo amici e al Ministero ero stato per molto tempo anche il suo
diretto superiore. Entrambi avevamo svolto con soddisfazione il
lavoro di archeologi, per il quale avevamo ricevuto pure degli encomi
pubblici e ci eravamo meritati articoli sulle pagine dei quotidiani; lui si
era rivelato un eccellente catalogatore di opere, tuttavia, detto senza
mezzi termini, ero stato io a fargli fare carriera al Ministero. Le cose
avevano cominciato ad andare storte nel momento in cui, dalle alte
sfere, quei personaggi che frequentavano più la politica che i siti
archeologici e le grandi esposizioni ci avevano chiesto, anzi,
ordinato, di aderire, addirittura con una cerimonia pubblica, al partito
fascista.
«Neanche per idea», avevo ribadito apertamente più volte, e lui,
Musmeci, aveva sempre cercato di frenare il mio istinto. «Filippo,
non opporti, ti prego. Cerca di ragionare. Se non rispetti gli ordini
superiori rischi di bruciarti in un attimo la carriera. Ti cacceranno via,
tu che sei una colonna dell’archeologia italiana, un professore, uno
stimato dirigente, non...».
«Alberico, lascia stare. Ti ringrazio per i consigli, ma in mezzo a
questa gentaglia in camicia nera non vuole starci nemmeno la mia
ombra».
Grazie alla magnanimità e, per certi versi, al senso di gratitudine
del professor Musmeci, diventato d’incanto responsabile del
dipartimento, un mese e mezzo dopo mi ero ritrovato in un
sotterraneo del palazzo, o meglio, in un sottoscala angusto e
polveroso, a stampare con il ciclostile moduli che nessuno avrebbe
mai utilizzato e norme che qualcuno avrebbe subito modificato. Era
stato il massimo che il mio collega fosse riuscito a ottenere per me,
per permettermi di incassare un piccolo stipendio, ottocentotrenta
lire al mese. Ben poca cosa rispetto a quanto avevo guadagnato
come archeologo in missione e come dirigente ministeriale, ma in
qualche modo dovevo pur vivere. Non in banca, fortunatamente, ma
in casa, avevo nascosto una buona scorta di denaro, risparmi di
anni, mantenuta intatta in previsione di tempi peggiori che, come
avevo intuito, sarebbero arrivati e di cui non si scorgevano i confini.
Con Musmeci i rapporti si erano rapidamente raffreddati; ci
eravamo persi di vista pur continuando a lavorare nello stesso
immenso edificio, ma su piani e tra arredi ben diversi. Non lo odiavo
e nemmeno lo biasimavo; probabilmente anch’io nelle sue condizioni
familiari – sei figli in età scolare ossuti come attaccapanni, una
moglie cagionevole di salute e pure gli anziani genitori di lei a carico– avrei aderito al fascismo senza esitazione. Lui in fondo era sempre
stato
un
brav’uomo, studioso, gentile, mansueto, persino
eccessivamente ossequioso – anche se Artemio diceva che è
proprio la gente così che, con il passaggio di casacca, diventa
pericolosa –, e se avesse rifiutato avrebbe fatto patire molte persone
a lui vicine. Io, invece, vivevo da solo e avrei potuto tirare la cinghia
senza far soffrire nessuno.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :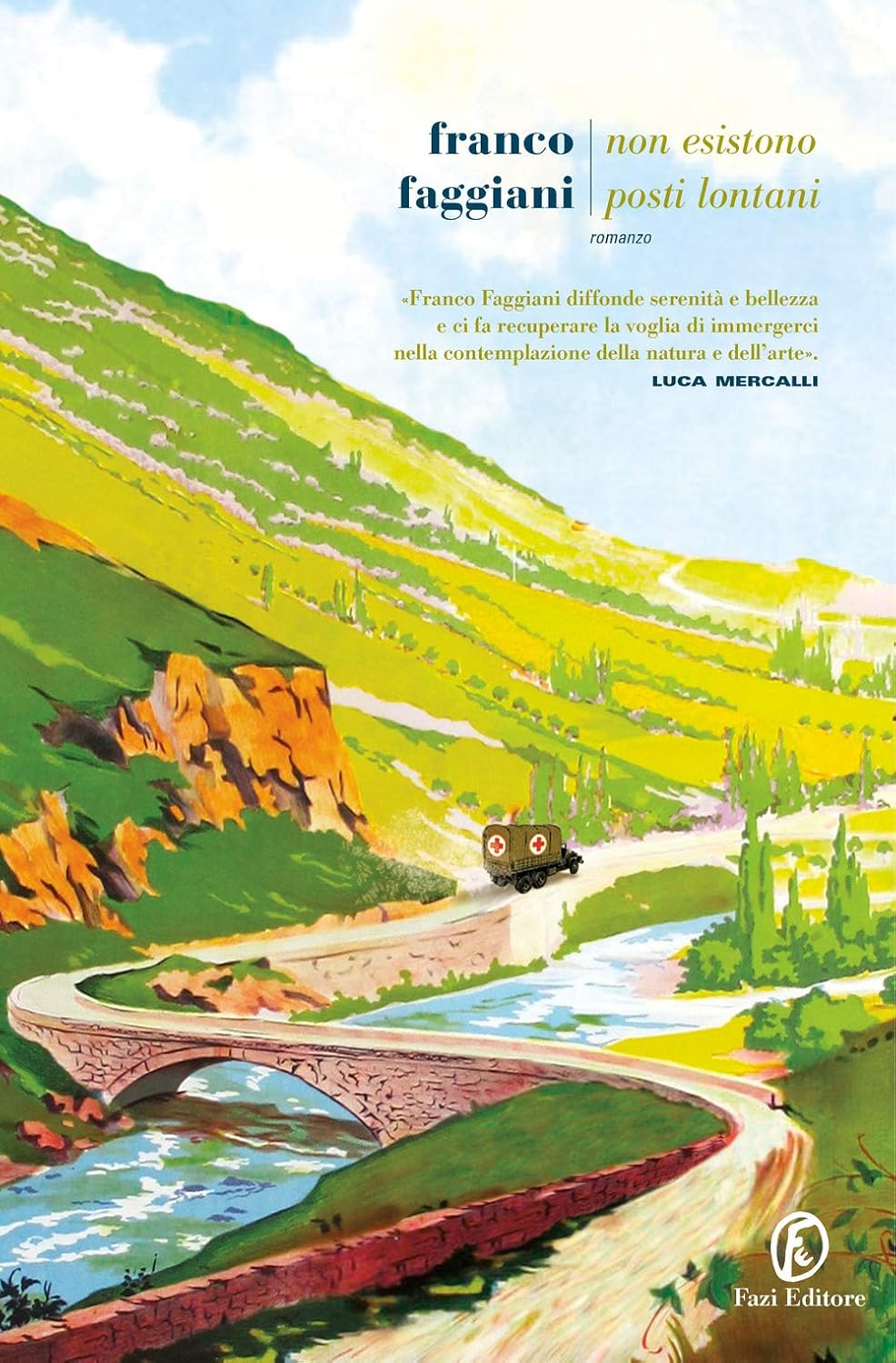






Commento all'articolo