Muro di casse – Vanni Santoni
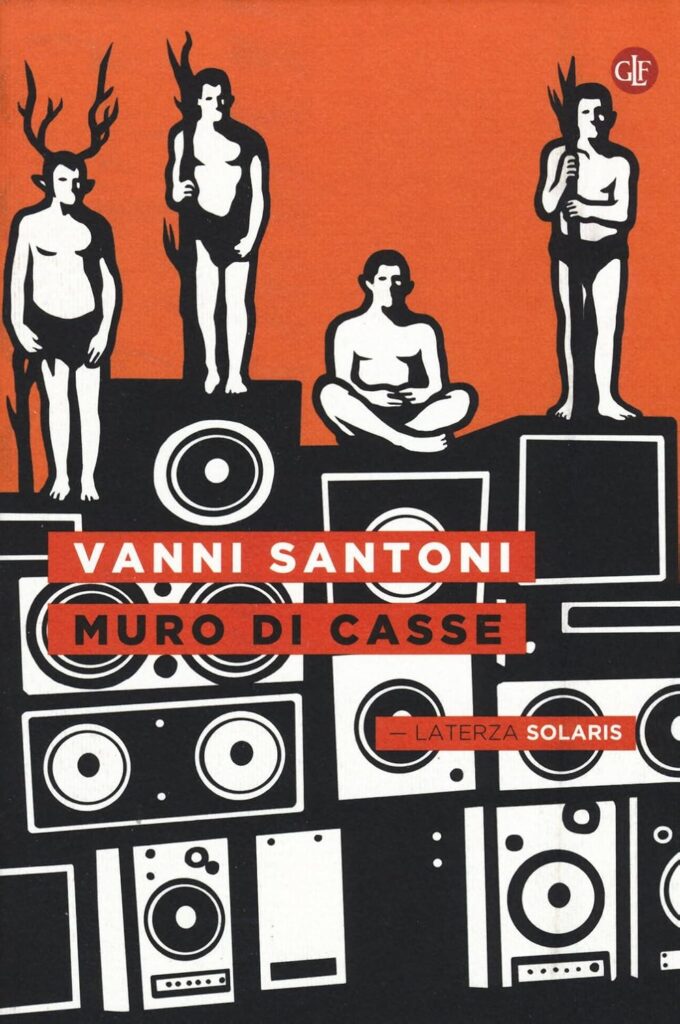
SINTESI DEL LIBRO:
Mi avevano pubblicato un romanzo che si basava su cose che
avevo visto con i miei occhi al paese e mi sembrava logico scriverne
un altro partendo da altre che avevo visto fuori, qualche anno più
tardi. Tra l’altro erano cose molto più interessanti: al mio paese avevo
visto soprattutto serate al bar e strippate in casa della peggio gente,
mentre in giro per l’Europa avevo avuto esperienza dell’unica cultura
giovanile genuina dei miei anni – la azzardo, e tu interpretala nella
direzione che preferisci: della cosa migliore realizzata dalla mia
generazione. Avevo pensato che per fare un romanzo dalla mia
esperienza delle feste, ovvero di tutto quel complesso di persone,
eventi, assembramenti e spostamenti che i giornali chiamano rave (e
quelli un po’ più avveduti, free party e teknival, dato che, a voler
essere precisi fino alla pedanteria, rave sono soltanto quelle feste
svoltesi nel Regno Unito tra il 1986 e il 1993
1), sarebbe stato
necessario anzitutto dividersi in due protagonisti. Questo perché
erano state due le grandi stagioni, strettamente imparentate, sebbene
una fosse decisamente più selvaggia dell’altra: c’erano le feste, e poi
c’erano le serate nei locali, quella che i giornali che volevano apparire
vicini ai giovani chiamavano “club culture”. Oggi la club culture è
sepolta, di feste se ne fanno meno e comunque non così grandi o
non così a occidente, e soltanto una terza e più tardiva stagione,
quella dei festival, ovvero dei raduni goa (o psytrance, a essere, di
nuovo, precisi) vive una bella salute. Per questo mi sembrava
sensato ambientarci un romanzo, in quelle decennali stagioni. Per
documentare (dimenticavo, o meglio non sapevo, che non bisogna
mai scrivere un romanzo solo per documentare) e anche per rendere
giustizia a qualcosa la cui portata e il cui splendore erano sconosciuti
a chi non era insieme a noi quelle notti e quei giorni (e quelle notti e
quei giorni e quelle notti e quei giorni e quelle notti e quei giorni... Ma
ignoravo anche che non bisogna mai scrivere solo per celebrare).
Pensai allora che la figura di un personaggio troppo vicino a me,
qualcuno che avesse vissuto entrambi i contesti, spostandosi dalla
fruizione, che forse un tempo si sarebbe potuta dire “borghese”, delle
serate, magari nell’ambito di un Erasmus o di una vacanza in giro per
capitali europee, alla partecipazione attiva e dunque, sia pure con
una componente edonistica, “militante” (che poi, chi me l’ha messa in
testa questa idea che edonistico accanto a militante richiede un “sia
pure”?), al movimento delle feste, non fosse abbastanza
interessante. Era forse un desiderio di purezza, quello che mi portò a
creare due figure, a tentare di dividermi tra Isabella, la raver
irriducibile, e suo fratello Aurelio, un cimbellone che se ne andava in
giro un po’ a casaccio per i club delle varie capitali europee. Il
risultato era che Isabella era un’idealizzazione, e quindi rimaneva
sulle palle a leggerla, mentre suo fratello, al quale avevo affidato tutte
le parti di me che valutavo peggiori, era una persona così orrenda da
essere fondamentalmente impossibile da amare. La sorella tornava a
casa dei suoi dopo anni, il fratello partiva (naturalmente per una
vacanza, il maledetto nullafacente), gli equilibri familiari si
spezzavano, la verità veniva messa a nudo, e intanto i salti tra i
ricordi di lei, tutti di feste in giro per i più assurdi angoli d’Europa, e
quello che faceva lui a Londra, Madrid o Amsterdam, avrebbero
dovuto far emergere una storia e una mappa di quello che era stato il
movimento dei free party da un lato, e la club culture dall’altro; di tutto
ciò che era fiorito, maturato e marcito intorno all’avvento della musica
elettronica in Europa.
All’inizio del romanzo, si sarebbero dovuti incontrare a Christiania.
Christiania è quella cittadella hippy piazzata in mezzo a Copenhagen,
negli edifici di quella che era stata una base navale. Non c’entra poi
troppo con le feste se non per l’essere a sua volta una zona
autonoma, la sua storia è altra cosa, altro discorso, ma quando a
cavallo del duemila tutta Europa era uno spuntare di muri di casse e
furgoni Westfalia pieni di spostati a cucinare ketamina in padella, ogni
snodo controculturale preesistente diventava per forza di cose un
punto di riferimento. Per dire, anche a Firenze avevamo uno spazio
autogestito, per storia politica pure moderato, nel quale mai
mancavano due o tre furgoni di cani e teknusi parcheggiati in cortile.
Mentre scrivevo la scena in cui il fratello, in visita a Christiania in uno
dei suoi giri da turista, incontrava la sorella dopo anni, e lei si
aggregava e si faceva riportare in Italia, pensavo che sarebbe stato
sensato farli partire da lì perché Christiania era comunque la più
grande esperienza di autogestione in Europa, la madre di tutte le
TAZ, eccetera eccetera, ma la verità era che mi premeva piazzare
Isabella a Christiania perché ci avevo vissuto anch’io, e in qualche
modo, sia pure con i mille filtri della finzione romanzesca, lo volevo
dire. La sindrome da medaglia, atteggiamento affatto adolescenziale
e purtroppo frequente tanto negli ambienti degli squat quanto in quelli
delle feste, dove i “gradi” si misurano in base alla radicalità delle
esperienze fatte e al tempo speso sulla scena, in una continua e futile
sacralizzazione dell’autenticità (a meno di esserti trasformato in
vecchia gloria, e allora puoi esserti pure preso i cartoni con gli Spiral
Tribe ma strapperai solo qualche sorriso bonario), e infatti la prima
volta che arrivai, poco più che adolescente, a Christiania e mi persi
tra quei banchetti che vendevano plance di marocco da un etto e
venticinque e quelle grandi case ricavate dai prefabbricati e tutte
coperte di graffiti, pensai che avrei dovuto venirci ad abitare; e
quando più tardi lo feci, per anni non mancai di ricordarlo a chiunque,
quasi che la cosa mi ponesse su un gradino più alto rispetto a questo
o quel compagno di viaggio. Quello che non dicevo è come
funzionano le cose lì. Perché a Christiania non è che ci siano troppe
case, né del resto se ne costruiscono (il rischio è piuttosto che le
tirino giù) sicché l’unico modo per abitarci, per piazzare insomma
quella medaglia sulla felpaccia, è mettersi con qualcuno che già ci
abita.
Marilith era più grande di me di dieci anni; con quei dreadlock
biondi e quelle braccia sempre nude, giuro che la prima volta che la
vidi mi sembrò pure bellissima. Del resto metà degli scombinati di lì le
facevano la corte, sono cose che un’opinione la influenzano. Ma
neanche potevo pensare in simili termini, a quei tempi. Lei era la
chiave per quel posto, e poi a ventidue anni hai ancora addosso
quella logica da liceo in cui tutto ciò che non è orribile è scopabile, e
se dà pure status, se ti fa entrare di diritto in una consorteria,
neanche ci pensi su. Mi seduceva anche il fatto che una donna
adulta, una donna che aveva accesso a riserve infinite di canapa e
funghetti, potesse prendermi a vivere con lei.
Non era molto bello scoparci, perché Marilith era fatta bene ma
alta, un metro e ottantacinque, e solida, sicché pesava molto e aveva
una forza brutale, anzi molto presto diventò proprio un’esperienza
sgradevole, era troppo tosta, una enorme massa di gomma dura che
scattava e si agitava intorno a una vagina, che mi schiacciava e
divorava. In effetti, dopo due settimane da che mi aveva preso in
casa, mi ero bell’e divertito. Mi era venuto a noia il modo in cui
gridava Iacopo, che era tipo YA-GÅ-PÅ, e il modo in cui rideva, e
quello in cui si ubriacava e su tutto la sua mole rispetto a me che ai
tempi ero davvero molto magro, e quando poi un giorno (stavo lì da
una ventina, più o meno), si piazzò in casa un suo vecchio amante
che te lo avrei fatto vedere, sembrava Freewheelin’ Frankie dei Freak
Brothers ma senza più un braccio, e aveva pure la pretesa di
rimanere lì da noi per non si sa quanti giorni – c’era qualcosa di non
detto? Lei si aspettava che facessi l’uomo? Che mettessi alla porta
quell’invalido o che lo menassi (con tutto che poi magari era l’invalido
a dare una coltellata a me)? Dovevo scopare anche con lui? Farci
amicizia? COSA? – mi forzai a entrare in confidenza con un camper
di tekno traveller inglesi che si erano parcheggiati a Christiania per
qualche giorno, e con loro scappai. Prima di capire che dovevo tirar
via anche quella felpa di Christiania con i tre tondi gialli sulla schiena,
ci misi un po’ di anni.
Venni via con quegli inglesi perché avevano in programma, dopo
un passaggio a Roubaix, di scendere fino a Bologna. Dove fosse di
preciso Roubaix non lo sapevo ma era chiaro che stava in Francia
(c’era del resto la Parigi-Roubaix) e mi parve ragionevole. Che poi, lo
dovevo capire subito che saremmo finiti chissà dove, ma avevo pochi
soldi e la casa dell’orchessa andava abbandonata. Avevano un
modesto soundsystem e come tribe si chiamavano Rolling Thunder,
anche se poi tra loro solo due sapevano mettere i dischi e per gli altri
il
discorso era più che altro muovere ketch e fumo e vendere i
palloncini con l’ossido d’azoto. Inglesi poi in realtà erano solo i due
che suonavano, c’erano poi un francese, un’austriaca, un’italiana,
due cani e una coppia di scozzesi con un altro furgone. In ogni caso
si parlava inglese. Rispetto alle tribe che conoscevo di persona, tutte
italiane, tutte un “figa” o un “dé”, secondo che fossero brianzole o di
Cecina, costoro mi sarebbero poi sembrati i più adatti come base per
dare forma ai compagni di viaggio di “Isabella”. C’erano Jody,
l’inglese violento e spiccio e però cazzuto e giusto che a ripensarci
oggi sembrava uscito da This is England, e poi Mike il mezzo
giamaicano, quello di talento che infatti qualche anno dopo avrebbe
lasciato la tribe per andare a suonare nel giro dei club, Renault il
francese allucinato, Beatrix di Vienna, Viridiana l’italiana, Scot e
Sophie i veterani che arrivavano dai new age traveller, da un mondo
anteriore, ascendente per più d’un verso di quello che andavo
esperendo, e poi, tutti un leccare, un abbaiare, uno scalpicciare e
rotolarsi nella polvere impestata, i due molossi Maya e Vingt-trois. E
con loro Isabella, ovvero io, ma il punto è che quei sette, nella realtà,
mi rimanevano sulle palle, giusto i cani e Viridiana mi stavano
simpatici, ed è dura far materia romanzesca di qualcosa che non ti
piace. Se da un lato incarnavano l’ideale cosmopolita delle feste
libere (e anzi se ero partito con loro era forse per mettere un’altra
medaglia sulla felpa), dall’altro – oh, forse ero io – mi trovavo troppo
meglio con i cecinesi o i brianzoli che con degli inglesi teste di cazzo,
un francese allucinato, una stronza austriaca e tutto il resto della
banda. L’unica che si salvava era Viridiana, appunto, ma era ostile e
dura come un pannello di ferro, e a volte penso che se dopo la sera,
diversi giorni più in là, in cui facemmo l’amore, non volle più farlo, non
era perché prima stava col francese, ma perché non aveva ancora
stabilito se ero abbastanza addentro le feste o no (se aveva
acconsentito una prima volta era perché aveva visto che vivevo a
Christiania, immagino).
Seduto nel retro del furgone dei Rolling Thunder mi feci
Copenhagen-Roubaix, che sono 997 chilometri senza contare che
Jody sbagliò strada due volte e da Brema finimmo a Hannover, e poi
in Belgio perdemmo non si sa come un giorno intero intorno a
Charleroi, e siccome di soldi non ce n’erano tanti, si mangiava di
merda e si fumava il giusto (e quindi figuriamoci il resto, a parte
Beatrix che stagnolava di nascosto, ma si vede che la roba era sua) e
a tornare oggi a certi tramonti sulle piazzole autostradali del Belgio
momenti che sarebbero stati perfetti per offrire la sponda a frasi tipo
Non potrete certo venirci a dire che non eravamo liberi – in quella
bellezza io pensavo solo Ma quando cazzo gireranno il culo verso
l’Italia ’sti spostati, e però a ripensarci devo fare comunque i conti col
fatto che, oh, non mi saranno piaciuti e io non sarò piaciuto a loro, ma
non mi avevano mai visto e mi avevano preso su, e quel che c’era
l’avevano sempre diviso senza approfittarsi. Fatto sta, comunque,
che arrivato a Roubaix avevo già litigato due volte con Jody e una
con Scot e voglia di far festa ne avevo poca.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






Commento all'articolo