L’ospedale dei bambini – 1869-2019. Una storia che guarda al futuro – Andrea Casavecchia
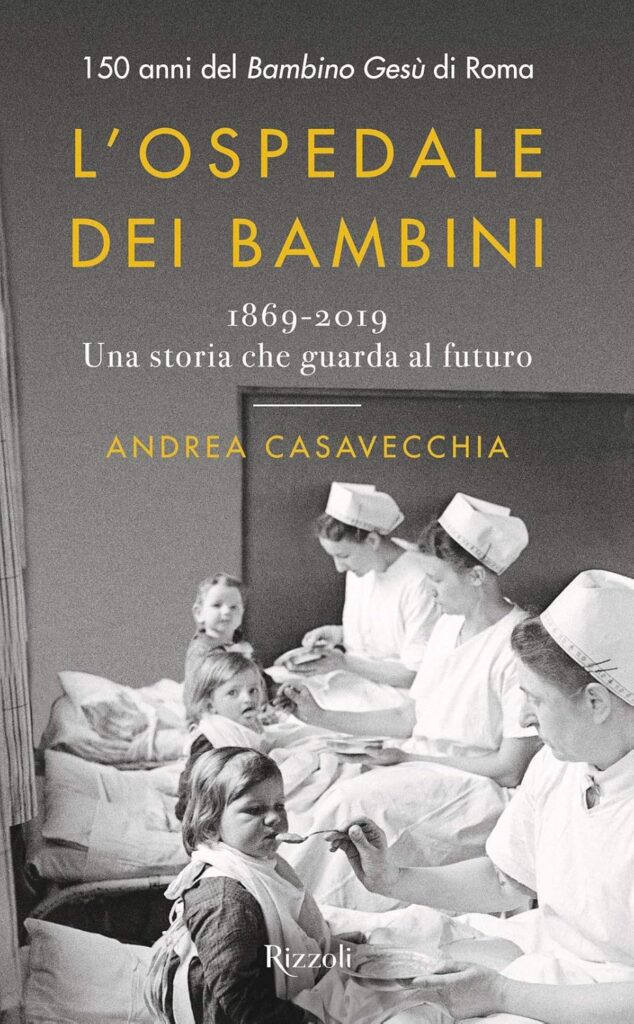
SINTESI DEL LIBRO:
Nella sede di Sant’Onofrio dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù,
custodito in una teca di vetro presso il foyer, all’ultimo piano del
padiglione Salviati, c’è un piccolo salvadanaio di terraco a. Le varie
fenditure che ne percorrono la superficie lasciano supporre che sia
stato ricostruito dopo essere stato rido o in pezzi. Quando ci si
avvicina è possibile leggere una dedica: «Offerta a Gesù Bambino
per le mani d’una moglie e madre amatissima nella circostanza del
suo compleanno 25 febbraio 1869»1.
Quello fu il giorno in cui la duchessa Arabella Fi-James Salviati
riceve e in dono dai suoi bambini il cosidde o dindarolo, un
salvadanaio che custodiva i loro piccoli risparmi. Nelle se imane
precedenti i bambini avevano discusso più volte e in modo acceso,
ma non erano riusciti ad accordarsi per trovare un regalo speciale
per la loro mamma. Solo l’intervento del padre, il duca Scipione
Salviati Borghese, era riuscito a dirimere le dispute. Come per
qualunque regalo, gli indizi migliori provengono dal destinatario
stesso.
Salvadanaio donato ad Arabella Fi-James Salviati – 1869 (Foto 2000)
Circa un mese prima, mentre era in visita agli ammalati
dell’Ospedale San Giacomo, la duchessa aveva visto due bambini
sistemati in uno stesso le o all’interno di una camerata in cui si
trovavano altri pazienti adulti. Quella visione l’aveva tanto
scandalizzata che, tornata a casa, aveva monopolizzato l’a enzione
dei commensali con il racconto dell’episodio. Roma, la capitale della
cristianità, non disponeva di un istituto sanitario dedicato
unicamente ai piccoli infermi, e la situazione nel resto d’Italia non
era differente. Alla duchessa doveva essere parso inacce abile che
non fossero prestate ai bambini malati le cure mediche adeguate in
ambienti consoni alla loro età. Forse, però, si sarebbe potuto fare
qualcosa.
Il duca Salviati propose ai suoi ragazzi di radunare i loro risparmi
per sostenere il sogno della mamma e concretizzare l’apertura del
primo ospedale per bambini; lui stesso avrebbe poi contribuito a
completare la somma per finanziare l’impresa. L’idea fu acce ata
con entusiasmo. Il 25 febbraio 1869, Arabella Salviati visse un
bellissimo compleanno.2
La duchessa si decise dunque a passare all’azione e, dopo aver
mobilitato altri donatori, scrisse dire amente al papa, chiedendo
l’assenso ad avviare il proge o dell’ospedale.
Beatissimo Padre,
La Duchessa Salviati, prostrata al bacio del sacro piede, umilmente espone
com’ella non solo ma molte pie persone avevano sentito da un pezzo il maggior
bene chei sarebbe e fisico e morale in questa ci à, se i fanciulli infermi, invece di
essere ammessi nei comuni ospedali, avessero un ospedale a parte. E poiché la
carità di molti ha generosamente contribuito nelle mani della supplicante
quanto basta ad iniziare la caritatevol opera, s’implora dalla Santità Vostra,
insieme con l’Apostolica Benedizione la opportuna facoltà di stabilire il
sudde o ospedale tu o a spese di privati, col titolo del Bambino Gesù e so o la
direzione delle Figlie di Carità. Che della grazia. 3
Le era di richiesta della duchessa Arabella Salviati e benedizione di Pio IX in
calce
La duchessa chiese a Pio IX che l’ospedale potesse essere dedicato
al Bambino Gesù, dopo essere riuscita a coinvolgere nell’impresa
altri nobili benefa ori4 e le religiose Figlie della Carità di San
Vincenzo de’ Paoli, alle quali fu affidata la direzione del complesso
in virtù dell’importante esperienza pregressa nelle opere sanitarie. Il
15 marzo 1869 il permesso di Pio IX fu concesso con queste parole:
«Dio benedica il buon pensiero, lo consolidi e perfezioni». Le poche
righe autografe sono la prima testimonianza della vicinanza dei
pontefici
all’ospedale
e
dell’interesse
immediato riscosso
dall’iniziativa, che diventava un segno della carità della ci à di
Roma, allora capitale dello Stato Pontificio. Qua ro giorni dopo, il 19
marzo 1869, il Bambino Gesù apriva ufficialmente le porte.
Un ospedale per gli infanti
Fu così che, nella seconda metà dell’Oocento, nacque il primo vero
ospedale pediatrico del nostro Paese: una storica innovazione
organizzativa sanitaria e, insieme, la premessa per lo sviluppo di
una nuova branca della medicina.5
A dire il vero, l’Italia si adeguò un po’ in ritardo rispe o al resto
d’Europa, dove l’assistenza sanitaria dedicata ai bambini aveva
mosso i primi passi tra la fine del Se ecento e l’inizio dell’Oocento.
Il primo ospedale pediatrico in assoluto, l’Hôpital des Enfants Malades,
fu fondato a Parigi il 13 maggio 1802; seguirono, tra gli altri,
l’Ospedale infantile San Nicolò della Pietroburgo zarista (1834),
l’Ospedale pediatrico Sant’Anna di Vienna (1837), l’Ospedale
Elisabe a di Berlino (1843) e il F.F. Sick Children di Londra (1852).
I primi ospedali pediatrici in Europa
Oltre che negli ospedali, le cure per i fanciulli trovarono spazio
negli ambulatori. Il primo fu fondato a Londra da George
Armstrong, nel 1769, con lo scopo di offrire un servizio di assistenza
sanitaria in una ci à che andava trasformandosi so o l’impulso della
Rivoluzione industriale. Una delle prime sfide della pediatria era
convincere della possibilità di curare i piccoli non solo il mondo
scientifico, ma anche le stesse famiglie.
Prima di quel momento, infa i, la società occidentale e la stessa
medicina non riconoscevano dignità specifica ai bambini, che erano
piu osto considerati adulti in miniatura. Ai bambini iniziò ad essere
prestata un’a enzione specifica anche dal punto di vista educativo.6
L’introduzione della vaccinazione per contrastare le epidemie di
vaiolo, che avevano decimato la popolazione del Seicento e
Se ecento, aveva segnato l’inizio di un’a enzione dei medici nei
confronti dell’infanzia.7
Per millenni, le cure dei bambini furono affidate alla sola
responsabilità delle famiglie e all’autorità della saggezza popolare,
custodita in particolare dalle donne e basata sull’uso di rimedi
semplici e antichi rituali di preghiera. Un simile contesto culturale,
tu avia, ostacolava la diffusione della pratica medica. Di fa o il
do ore era visto con diffidenza e chiamato solo quando le condizioni
dei piccoli malati erano disperate e perlopiù irrecuperabili.
Purtroppo, ancora nel XIX secolo, le condizioni sanitarie erano
precarie ed estremamente diversificate a seconda del contesto
sociale: la miseria, la mancanza di acqua pulita, le carenze
alimentari, l’ignoranza verso le norme igienico-sanitarie incidevano
sensibilmente sulla salute dei bambini. A segnare un ulteriore
impedimento allo sviluppo dei fanciulli si aggiungeva il lavoro
minorile, che marcava inoltre una forte distinzione tra benestanti e
poveri. La società manifestava insomma una «indifferenza
stru urale»8 nei confronti dell’infanzia. Ci vollero molti anni
affinché ignoranza e sfru amento entrassero nell’agenda politica
come autentiche e urgenti questioni sociali: soltanto nel 1877, con la
legge Coppino, fu decretato l’obbligo scolastico fino alla terza
elementare, mentre si dove e a endere il 1886 perché la legge Berti
impedisse il lavoro ai minori di nove anni. Entrambi i provvedimenti
furono, per lungo tempo, scarsamente applicati.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :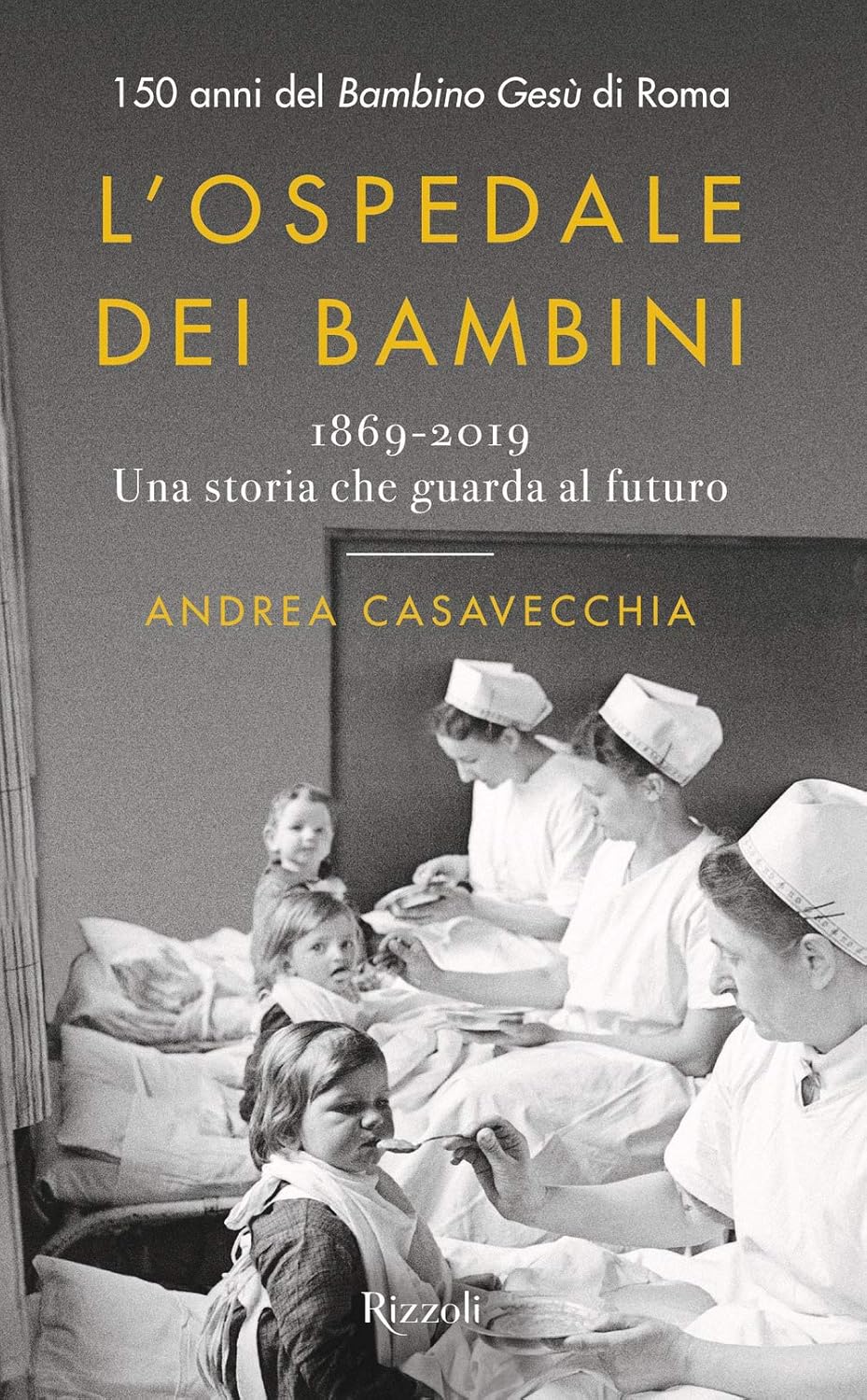






Commento all'articolo