La scuola senza andare a scuola – Diario di un maestro a distanza – Giuseppe Caliceti
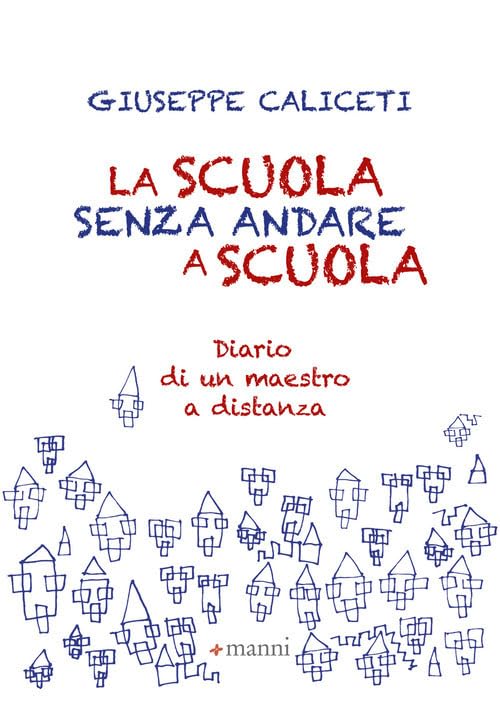
SINTESI DEL LIBRO:
La scuola italiana all’epoca del Covid 19 è rigorosamente a
distanza. È una scuola senza andare a scuola. Con docenti che
cercano di fare lezioni on line, riempiono di compiti gli studenti e
sperimentano per la prima volta la Didattica a Distanza, conosciuta
come DaD.
Nonostante molti docenti non siano preparati, tutti ci provano:
sono costretti. Inviano compiti via internet. Anche se non tutti gli
studenti sono pronti a recepirli.
Tutto avviene in perfetto stile italiano: ogni scuola procede per
conto suo. Con dirigenti scolastici che si muovono in ordine sparso
per mostrare come, nonostante la chiusura, la scuola non chiude.
Anche se non è più scuola.
Il ministro all’Istruzione incita i dirigenti scolastici a resistere. E loro
lo ripetono ai docenti sottoposti. E loro agli studenti e alle loro
famiglie.
Ma ragazzi e bambini sentono la mancanza della scuola, cioè
della loro vita sociale. La domanda più frequente: «Maestro, quando
finirà tutto questo? Quando riprende la scuola vera?»
La DaD accentua gli aspetti classisti di cui, negli ultimi decenni, si
è ammorbata la nostra scuola.
La DaD non arriva a tutti: sono più del 6% gli studenti non
connessi: migliaia di migliaia.
La DaD chiede ai genitori di fare gli insegnanti. Ma per alcune
famiglie la scuola non è in cima alla lista delle priorità. Come non lo
era prima di questa crisi sanitaria. E per tutti è un lavoro in più che
non hanno mai fatto.
La DaD ripropone gli aspetti più regressivi del processo educativo:
i
compiti, la lezione frontale, l’interrogazione a tu per tu studente
professore, l’idea che gli studenti siano vasi da riempire di contenuti.
Nonostante Plutarco, secoli fa, abbia detto che non sono vasi da
riempire, ma fiaccole da accendere. E Dewey che noi impariamo ciò
che facciamo: il contenuto critico di ogni esperienza didattica è il
metodo, cioè il processo mediante il quale avviene l’apprendimento.
Insomma, quello che conta non è quello che agli studenti diciamo,
ma l’esperienza che riusciamo a fargli fare.
Allora perché la DaD?
Per salvare la faccia di fronte alle famiglie. E la forma: i voti, le
certificazioni. Il famoso pezzo di carta.
È probabile che la DaD, nei suoi step più avanzati, in futuro saprà
coniugarsi con una pedagogia alta e spettacolare. Oggi non è così.
Accentua l’esclusione sociale e pone un ricatto molto semplice: o
così, o niente.
Come è iniziato questo pandemonio? Quando?
Qui in Emilia Romagna, in piena zona rossa, una settimana dopo il
24 febbraio, data di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in
tutta Italia.
Subito c’è stata una settimana di riposo e incredulità, poi i presidi
hanno sparso la voce tra i docenti che il registro elettronico di classe
doveva proporre ogni giorno compiti agli studenti. E occorreva
registrare videolezioni da inviare agli alunni. E predisporsi per la
DaD.
O lo stipendio rischiava di essere tagliato.
Via libera, allora, all’assalto alla rete del corpo docenti, per
rassicurare gli studenti, salutarli, raccontare favole, recitare
filastrocche, organizzare riunioni e lezioni a distanza.
Di tutto, di più: come alla tv.
Comunicare, comunicare, comunicare, comunicare: questa la
parola d’ordine.
Anche se magari, all’inizio, di fronte agli studenti, maestri o
professori riuscivano a comunicare solo l’angoscia per il bollettino
serale dei morti e dei contagiati.
Didattica a Distanza
Passeggiata serale accanto a casa insieme a mia moglie, anche
lei docente di scuola primaria. Portiamo Bebèl, la nostra pincher
nana, a fare i suoi bisogni.
Quest’anno io sono in prima elementare, mia moglie in terza.
Lavoriamo in due istituti comprensivi diversi.
Insegniamo entrambi italiano, storia, geografia, educazione
musicale, educazione all’immagine ed educazione alla cittadinanza.
Io e le mie colleghe di team abbiamo programmato un’ora al
giorno di videolezione su WeSchool metà classe alla volta, dalle 18
alle 19, quando tutti i genitori sono tornati a casa dal lavoro e
possono aiutarli a usare computer, tablet o cellulare. Le due
insegnanti di sostegno si sentono anche individualmente con gli
studenti che hanno bisogno di più aiuto. Ogni giorno leggo una
filastrocca o una storia e la pubblico sul mio blog. Diamo compiti
quotidiani sul registro elettronico: esercizi sui libri di testo, schede
didattiche da completare. Ci sono due compiti scritti settimanali: uno
di italiano e uno di matematica. Io chiedo di scrivere un testo
individuale in stampato maiuscolo e illustrarlo con un disegno. I
genitori degli alunni fotografano le pagine del compito e inviano alla
mia posta elettronica per la correzione.
Mia moglie e il suo team fanno cose diverse: videolezioni
registrate per ogni materia, lezioni on line al mattino e al pomeriggio,
segnalazioni di link con documentari o film da guardare su youtube,
file di schede e moduli di autocorrezione, correzioni su G Suite o su
Classroom, mail, videochiamate individualizzate agli alunni, sms,
messaggi whatsapp, smile, telefonate.
Da tempo i docenti italiani sanno che l’autonomia scolastica è
anarchia. Un modo per disgregare progressivamente la scuola
pubblica, diminuirne gli investimenti, disfarsene, affidarla ad enti
locali sempre più poveri, assoggettarla ad aziende private presenti
sul territorio.
Durante la pandemia l’anarchia scolastica raggiunge livelli
apocalittici. Mancano direttive comuni da parte del ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, uffici regionali, tavoli
provinciali dei presidi. Ogni scuola procede in ordine sparso.
Appassionatamente. Ma questo è il problema minore.
La DaD non arriva a tutti allo stesso modo: per gli alunni della
primaria richiede necessariamente la forte presenza dei genitori.
I bambini delle prime classi sono i più disorientati, insieme a quelli
con disabilità o disturbi dell’attenzione: è già difficile coinvolgerli in
presenza, figurarsi attraverso una comunicazione virtuale.
Per chi ha difficoltà strumentali o di relazione, limiti cognitivi o
psichici, non avere accanto chi gli propone le attività è un ostacolo
insormontabile.
Eppure tra docenti si è già diffuso un nuovo virus: l’ansia da
prestazione.
Sui giornali e in tv ci sono maestre e presidi che sostengono come
gli studenti italiani – anche i bambini di quattro e cinque anni delle
scuole materne o di sei e sette anni della scuola primaria – grazie al
Covid 19 abbiano avuto l’opportunità di scoprire la modernità, la
bellezza e le potenzialità del digitale. Per la scuola e gli studenti il
Covid 19 sarebbe un’occasione per entrare nel futuro.
Chiacchiere.
Vi dirò un segreto: spesso le maestre sono chiacchierone.
Ve ne dirò un altro: spesso alcuni presidi lo sono ancora più delle
maestre.
Colleghe, colleghi, un po’ di contegno, diamine!
Non chiamiamola Didattica a Distanza, ma Didattica di
Emergenza.
Soprattutto, non chiamiamola scuola a distanza: perché non lo è.
La scuola senza andare a scuola non è scuola.
La scuola è una cosa seria, si fonda sull’unità costante di tempo e
di luogo e su un quotidiano rapporto tra docenti e studenti, e tra
studenti tra loro. Affascinante, delicato, difficile, straordinario.
Una delle sue funzioni è proprio allontanare per qualche ora al
giorno il bambino dai genitori, in particolare dalla madre: solo così il
bambino aumenta la sua autonomia e può crescere: insieme ai
coetanei, in gruppo, affrontando e gestendo un insieme complesso
di emozioni, conoscenze e relazioni intrecciate tra loro in modo
indissolubile.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




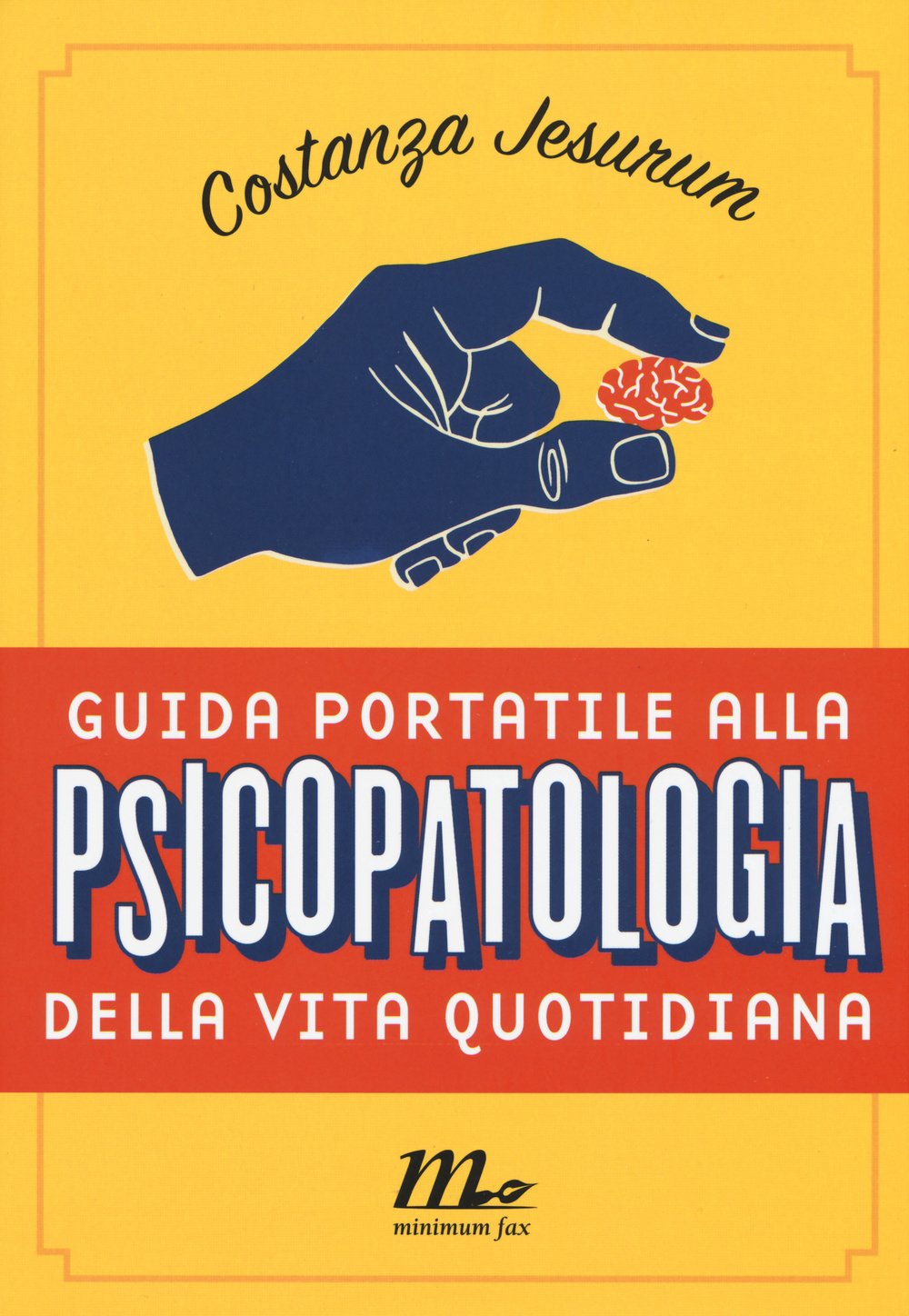
Commento all'articolo