La ricchezza di pochi avvantaggia tutti – Zygmunt Bauman
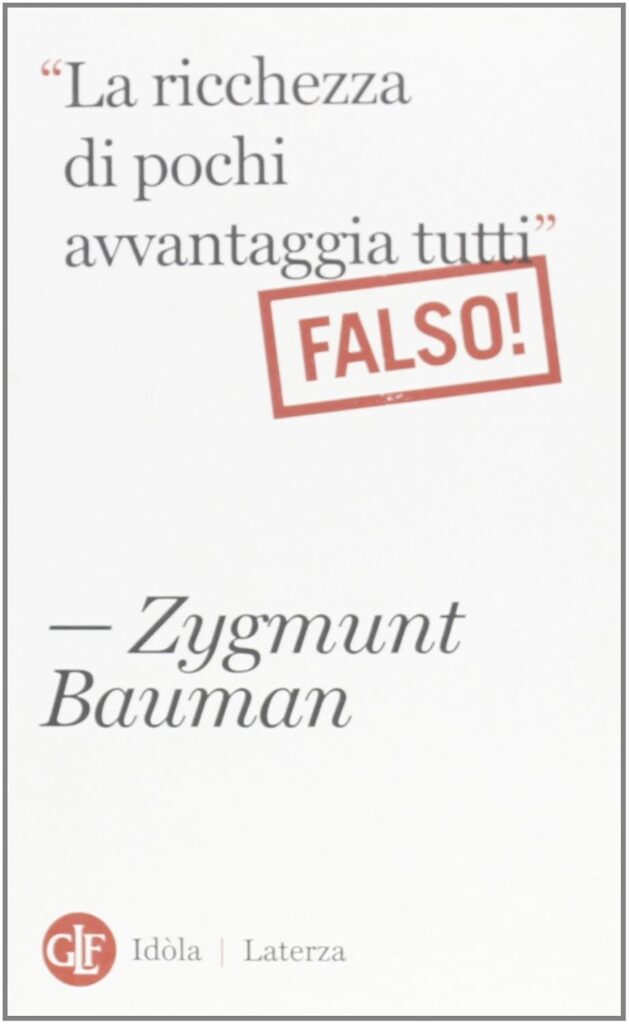
SINTESI DEL LIBRO:
«È l’economia, stupido» è una frase coniata contro George H.W. Bush da
James Carville, stratega della campagna presidenziale di Bill Clinton del
1992. Negli anni dopo che fu coniata, la frase ha fatto una carriera
spettacolare nel vocabolario politico mondiale. Ad oggi è saldamente
insediata nel linguaggio della politica come pure nella doxa (cioè l’insieme
di credenze abitualmente utilizzate dal pubblico dei profani come
strumenti del loro pensiero, ma su cui raramente o forse mai si riflette, e
che tanto meno vengono analizzate e sottoposte a verifica), e affiora
ripetutamente nei discorsi dei politici e nelle relazioni degli spin doctor in
occasione delle successive campagne elettorali, o anche al di fuori di
queste e altre occasioni. La frase assume come un dato di fatto evidente,
dimostrato dall’esperienza comune al di là di ogni ragionevole dubbio,
che i sentimenti pubblici, le simpatie o le antipatie, la pubblica
disposizione a offrire o negare il sostegno ai fronti contrapposti nelle
battaglie elettorali, e l’inclinazione degli elettori a riconoscere i loro
interessi nei programmi e negli slogan elettorali, siano tutti
completamente o quasi determinati dai meandri della «crescita
economica». Essa assume che quali che possano essere gli altri valori e
preferenze degli elettori, è la presenza o l’assenza della «crescita
economica» che tende a guidare le loro scelte più di ogni altra
considerazione. Ne segue che sono le cifre che si suppone misurino il
grado di crescita economica a essere usate come gli indicatori più
affidabili per le previsioni delle possibilità elettorali dei contendenti per
l’occupazione delle stanze del potere. La stessa aspettativa è spesso espressa
con un’altra frase popolare: «votare col portafoglio» (voting with a
pocketbook in inglese americano, o with a wallet in inglese britannico,
espressione definita dal Longman Dictionary come disposizione morale
dell’uomo «a votare per qualcuno o per qualcosa che si pensa possa aiutare
ad avere più denaro»).
E questo sembra essere oggi l’atteggiamento dominante, vista la
convinzione diffusa di recente e ora sostenuta con decisione che è dalle
cose che le cifre ufficiali della «crescita economica» apparentemente
misurano che dipendono in primo luogo le possibilità di una vita decente,
gratificante e dignitosa, in breve di una vita degna di essere vissuta. Ma il
problema è che questa convinzione non è né endemica né in alcun altro
modo «naturale» per gli uomini; anzi, è di origine relativamente recente...
Le menti più formidabili fra i pionieri della moderna economia
consideravano la «crescita economica» una spiacevole seccatura piuttosto
che una benedizione: un urticante per fortuna temporaneo ed
eminentemente passeggero, causato da una disponibilità ancora insufficiente
di beni indispensabili per soddisfare la somma totale delle esigenze
umane. La maggior parte di loro ritenevano che questa somma totale
potesse essere calcolata, e una volta che la capacità produttiva della società
l’avesse raggiunta sarebbe seguita l’economia «stabile» o «costante», più in
sintonia e più amichevole con la disposizione umana «naturale». John
Stuart Mill, pioniere del pensiero economico moderno e uno dei più
acuti filosofi e studiosi del XIX secolo2, preannunciava per esempio la
reale inevitabile transizione dalla crescita economica a uno «stato
stazionario». Nella sua opera più importante, Principi di economia politica,
scriveva, come chiunque può leggere nella attuale edizione di Wikipedia,
che «l’incremento della ricchezza non è infinito. La fine della crescita
porta a uno stato stazionario. Lo stato stazionario del capitale e della
ricchezza [...] sarebbe un miglioramento notevolissimo rispetto alla nostra
presente condizione». E ancora: «Una condizione stazionaria del capitale
e della popolazione non implica affatto uno stato stazionario del
miglioramento dell’umanità. Ci sarebbe lo stesso spazio di sempre per
tutti i tipi di cultura mentale, e progresso morale e sociale, altrettanto
spazio per migliorare l’arte del vivere, e molta più probabilità che essa sia
migliorata, se le menti cessassero di essere occupate esclusivamente a
prosperare»3. Mentre fino al secolo scorso inoltrato, come possiamo
leggere anche in Wikipedia, John Maynard Keynes, uno dei più
autorevoli economisti del XX secolo4, aspettava ancora l’immancabile
avvento del giorno in cui la società potrà concentrarsi sui fini (felicità e
benessere, per esempio) anziché, come fino ad ora, sui mezzi (crescita
economica e ricerca individuale del profitto). Egli scriveva che l’«avarizia
è un vizio, la riscossione dell’usura è una colpa, l’amore per il denaro è
spregevole [...] Torneremo ad apprezzare di nuovo i fini sui mezzi e
preferiremo il bello all’utile»5. E insisteva che «non è lontano il giorno in
cui il problema economico passerà in secondo piano, che è quello che gli
compete, e l’arena del cuore e della testa sarà occupata, o rioccupata, dai
nostri problemi reali, i problemi della vita e delle relazioni umane, della
creazione e del comportamento e della religione»6: in altre parole quei
problemi che non solo sono «reali», ma sono immensamente più nobili e
attraenti delle esigenze di «semplice sopravvivenza» che guidano al
momento le preoccupazioni economiche o le tentazioni di ingrandirsi
sempre più, in attesa di soppiantarle; problemi che, se finalmente
affrontati sul serio, aprono la strada a un tipo di vita e di coabitazione umana
davvero salutare.
Sono passati altri sessant’anni di sfrenata ricerca capitalistica della
ricchezza per se stessa – una caccia in cui la visione della ricchezza
pubblica come strumento per la costruzione di una società ospitale per le
diverse, sfaccettate richieste di una vita umana buona, degna di essere
vissuta, è stata cancellata e ignorata – ed ecco, ora Robert e Edward
(figlio di Robert) Skidelsky hanno pubblicato uno studio intitolato How
Much Is Enough? The Love of Money, and the Case for Good Life, in cui
arrivano alla conclusione (nella sintesi che ne fa Michael O’Leary nel suo
saggio dal titolo eloquente Drowned by the Rising Tides [Sommersi dalla
marea montante]7) che «il mito che la marea montante solleva tutte le
barche oggi non inganna più nessuno» (osservazione ahimè un po’
prematura, dal momento che l’inganno sembra operare ancora con pieno
vigore contro l’aspettativa degli autori di un effetto di attenuazione delle
manifestazioni più recenti e distruttive della disuguaglianza globale che
aumenta a una velocità senza precedenti). L’edizione 2012 del rapporto
annuale dell’OCSE intitolato Going to Growth [Obiettivo crescita]
suggerisce, secondo O’Leary, che nelle interpretazioni ufficiali delle radici
delle attuali inquietudini «ai poveri viene addossata la colpa ma i ricchi si
prendono il piacere». E John Evans, il Segretario generale del Trade
Unions Advisory Committee, commenta che
Going for Growth non trae lezioni dalla crisi e continua a insistere sulla deregolazione del mercato
del lavoro. Le politiche che contribuiscono alla crisi attuale vengono presentate come soluzioni. È
particolarmente preoccupante che l’OCSE raccomandi di ridurre la protezione per i lavoratori, in
un momento in cui si richiede maggiore fiducia.
La «mano invisibile del mercato», che con molta fantasia si pensa operi
per il benessere universale – la mano che la politica di deregolazione dello
Stato mira a liberare dalle manette giuridiche precedentemente
predisposte al fine di limitarne la libertà di movimento – può anche essere
davvero invisibile, ma non abbiamo molti dubbi a chi quella mano
appartenga e chi ne diriga i movimenti... La «deregolazione» delle banche
e del movimento dei capitali permette ai ricchi di muoversi liberamente,
di cercare e trovare i migliori terreni di sfruttamento e quelli più capaci di
generare profitti e così diventare più ricchi, mentre la «deregolazione» del
mercato del lavoro rende i poveri incapaci di star dietro agli exploit, e li
mette ancor meno in grado di arrestare o almeno rallentare le
peregrinazioni dei possessori di capitali (rinominati «investitori» nel gergo
della Borsa), e quindi alla fine non può che renderli più poveri. Oltre al
danno arrecato al loro livello di reddito, le loro possibilità di impiego e di
salario per vivere si trovano ora esposte ai capricci dei capitali a caccia di
ricchezza, le loro prospettive di competizione diventano cronicamente
precarie e producono acuto sconforto spirituale, perpetua preoccupazione
e cronica infelicità: flagelli che non spariranno e non cesseranno di
tormentare neanche nei (brevi) periodi di relativa sicurezza. Gli effetti
endemicamente divisivi della «politica di deregolazione» rientrano tuttavia
fra i segreti ufficiali meglio tutelati; in documenti ufficiali destinati al
pubblico la deregolazione è presentata come la strada maestra per il
benessere di tutti; e le statistiche del prodotto interno lordo, che
dovrebbero misurare gli alti e bassi della «ricchezza totale» della nazione
identificata col benessere del paese, tacciono sul modo in cui quella
ricchezza è distribuita. Lo nascondono anziché rivelarlo; in particolare, ed
è la cosa più importante, la verità che quelle statistiche evitano di far
emergere è che l’aumento della «ricchezza totale» va di pari passo con
l’approfondirsi della disuguaglianza sociale e con l’ulteriore allargamento del
già incolmabile divario fra la sicurezza esistenziale e il benessere generale
del vertice della piramide sociale e la situazione delle fasce inferiori. E
ricordiamo che la cerchia che sta al vertice di quella piramide si restringe
sempre di più di anno in anno, mentre il resto di essa, fino al fondo più
basso, si espande inarrestabilmente.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :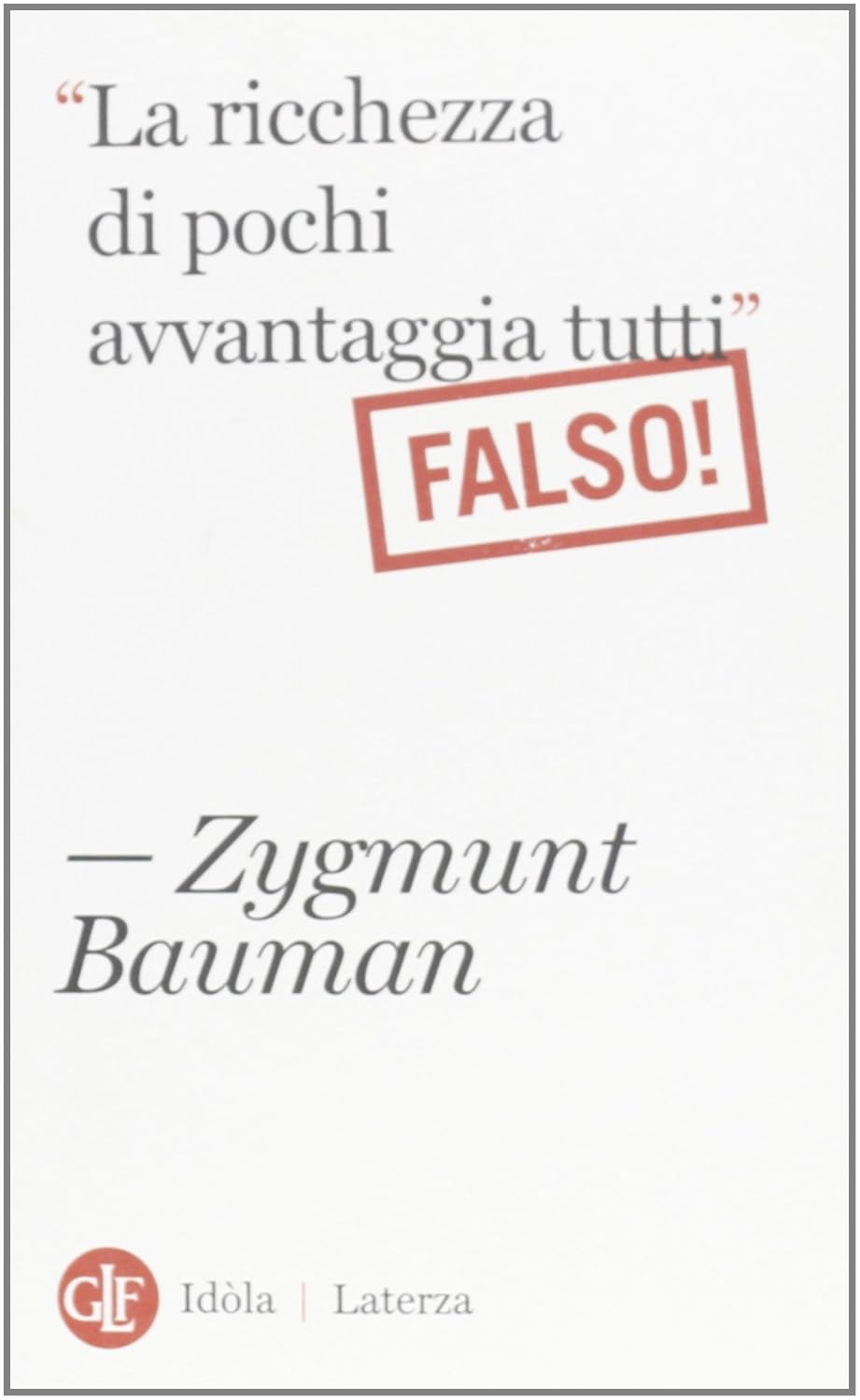






Commento all'articolo