I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta – Stefano Liberti

SINTESI DEL LIBRO:
Il mattatoio più grande del mondo
I movimenti sono cadenzati, meccanici, ripetitivi. I maiali sono appesi a un
gancio, che scorre lungo un nastro a velocità regolare. Gli uomini sono
disposti lungo il nastro, a distanza fissa l’uno dall’altro. Hanno tute bianche,
stivali di gomma, guanti, mascherine, cuffiette per i capelli. Tra loro sono
indistinguibili: non fosse per le differenze di altezza, si direbbe un esercito di
robot. In mano hanno gli strumenti di lavoro: chi un coltello, chi una
mannaia, chi un gancio. Ognuno ha il suo ruolo, ognuno compie il gesto che
gli è assegnato, piccolo ingranaggio di un meccanismo standardizzato: uno
pratica un taglio sul ventre dell’animale, un altro allarga il taglio, quello dopo
estrae le budella, il seguente opera un altro taglio. Le interiora sono posate in
apposite vasche; i coltelli e le lame immersi in un liquido sterilizzante tra un
taglio e un altro. Anche le bestie sono tutte identiche, l’una clone dell’altra:
stessa grandezza, stessa altezza, stesso colore. Sembrano – e in verità sono –
il frutto di un esperimento genetico teso a creare l’animale perfetto per la
macellazione e il consumo.
La scena ha un che di ipnotico. Da dietro il vetro mi sorprendo a guardare,
più che i maiali ridotti progressivamente in pezzi, questi uomini che si
muovono a tempo, sicuri e determinati, e trattano il corpo degli animali di
fronte a loro con un misto di perizia e noncuranza. Su quel corpo non si
accaniscono: fanno il loro lavoro meccanico, come se dovessero mettere
insieme le componenti di un’automobile. Taglia, allarga, estrai, ritaglia.
Quella a cui mi trovo ad assistere è una catena di montaggio, né più né meno:
la fabbrica della carne industrializzata moderna.
La stanza seguente è più ampia, la scena ancora più suggestiva. Altri
uomini in divisa scompongono il già tagliato e riducono la carne informe in
pezzi definiti. Rispetto allo spazio precedente sembra di guardare attraverso
un caleidoscopio, con il suo effetto moltiplicatore. Il nastro non è unico. Ce
ne sono diversi, che scorrono lungo tutto lo spazio in diagonale. Gli operai
sono molti di più; una distesa di camici bianchi, tutti alla stessa distanza, tutti
fermi al loro posto, immobili, se non fosse per quel singolo movimento che
ognuno di loro ripete incessantemente. Qui i pezzi sono via via selezionati e
impacchettati, quindi mandati verso la cella frigorifera. Ci sono una
precisione e un ordine geometrico che stridono con la brutalità della morte.
Tutto il processo avviene in modo freddo, funzionale, pulito: non una goccia
di sangue, non un pezzo di carne fuori posto. Dietro i vetri, che impediscono
ogni contatto con il mondo esterno, non si sente nulla. Il mattatoio moderno è
una fabbrica perfetta e sincronizzata.
In verità, non tutto il processo è così pacifico. Le fasi precedenti sono più
cruente: per mandarla al macello, la bestia è dapprima stordita mediante gas o
una scarica elettrica, poi sgozzata con un taglio all’altezza della giugulare,
quindi immersa in una vasca di acqua bollente, per ripulirla dal sangue. Il
corpo esanime è spellato e ulteriormente lavato facendolo entrare in una
macchina speciale. La testa viene tagliata e il grande corpo appeso al gancio e
mandato alla fase successiva, quella da cui ho iniziato la visita. Anche questi
passaggi sono standardizzati, compiuti da uomini che ripetono gesti sempre
uguali: uno stordisce, un altro taglia la giugulare, un altro aziona il nastro
trasportatore che getta la bestia nella vasca. Ma il momento della morte non
riesce a essere asettico: spesso l’animale si agita e si ribella al suo destino – a
volte non è sufficientemente stordito dal gas, o non muore per il taglio e urla
di dolore quando è bollito vivo nella grande vasca. A queste scene non è dato
assistere. Il futuro consumatore non le deve vedere, perché non deve
associare quello che ha nel piatto con il dolore di un essere senziente. Ai
visitatori sono mostrate solo bestie inermi, pronte per il consumo. Più che
animali, carne. «Il nostro mattatoio si avvale delle tecnologie più avanzate.
Rispetta al cento per cento le norme igieniche e anche gli standard di
macellazione tesi a ridurre al minimo le sofferenze dei capi di bestiame», mi
dice l’addetto stampa che mi accompagna nel tour per i visitatori.
Sono a Shuanghui, «il più grande trasformatore di carne della Cina», come
proclama a caratteri cubitali la scritta in inglese sul palazzo che ne ospita la
sede. In realtà la scritta è vecchia: perché Shuanghui è ormai il più grande
trasformatore di carne suina al mondo. Da quando, nel 2013, ha acquisito
l’americana Smithfield Food – il maggior produttore e trasformatore di maiali
del Nordamerica – non ha concorrenti. Ha in mano buona parte del mercato
planetario della carne di maiale. E ne controlla tutta la filiera:
dall’allevamento alla macellazione, dalla trasformazione alla
commercializzazione. Un affare da qualche decina di miliardi di dollari.
L’uomo che mi accompagna nel tour è un trentenne baldanzoso che ha
passato tutta la sua vita professionale nell’azienda. Mentre ci muoviamo tra i
ballatoi vetrati sopra il mattatoio e osserviamo l’esercito di uomini bianchi
all’opera nello stagliuzzamento, lui descrive processi, snocciola cifre, dà
forma e sostanza alle scritte che campeggiano per tutto lo stabilimento e
segnalano al visitatore che l’azienda è la numero uno in Cina, che ha una
strategia globale, che è leader del mercato. «Siamo i primi al mondo», ripete
con fierezza molte più volte del dovuto. In tutta la Cina Shuanghui ha decine
di impianti di trasformazione come quello che sto visitando, oltre ai
capannoni industriali da allevamento che gestisce in parte direttamente, in
parte attraverso aziende sussidiarie. Questi «purtroppo non si possono visitare
perché è necessaria una quarantena di una settimana in modo da evitare la
trasmissione di malattie», mi dice l’uomo mostrando una qualche
mortificazione d’ordinanza. Concluso il tour nelle stanze della macellazione,
vengo introdotto in una sorta di showroom. È una stanza ampia, in cui i vari
prodotti Shuanghui sono esposti in teche, ognuna delle quali ha la propria
etichetta in doppia lingua, inglese e mandarino. Ci sono le Pizza Hut Spare
Ribs, ossia le costolette di maiale che vendono da Pizza Hut, le Spare Ribs
with Gristle, quelle a cui è stata lasciata la cartilagine, più una varietà di
würstel di tutte le forme e i sapori come l’Hot Dog with Corn, lo Spicy
Crispy Sausage e il Luncheon Square Sausage. Le scatole hanno un design
fiabesco, con personaggi da cartoni animati: qui c’è un leone, lì un
pesciolino, lì ancora una pannocchia di mais antropomorfa, più in là un
pinguino. Su una confezione è stilizzata la bandiera degli Stati Uniti con una
sfilza di salsicce al posto delle stelle. Su nessun prodotto è raffigurato il
maiale. La cosa non mi sorprende: per nulla al mondo la carne deve essere
associata all’animale da cui proviene, ogni minimo riferimento deve essere
cancellato. Nella sala attigua, un paio di hostess hanno disposto un comitato
d’accoglienza in mio onore: su un fornello elettrico vengono cucinati
salsicciotti, rettangolini di bacon, würstel al mais e altre prelibatezze di
derivazione suina, che mi trovo a ingurgitare di prima mattina in una specie
di imprevista seconda colazione. Tutti i prodotti in mostra qui sono destinati
al mercato interno cinese. Un mercato gigantesco che vale miliardi di dollari.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






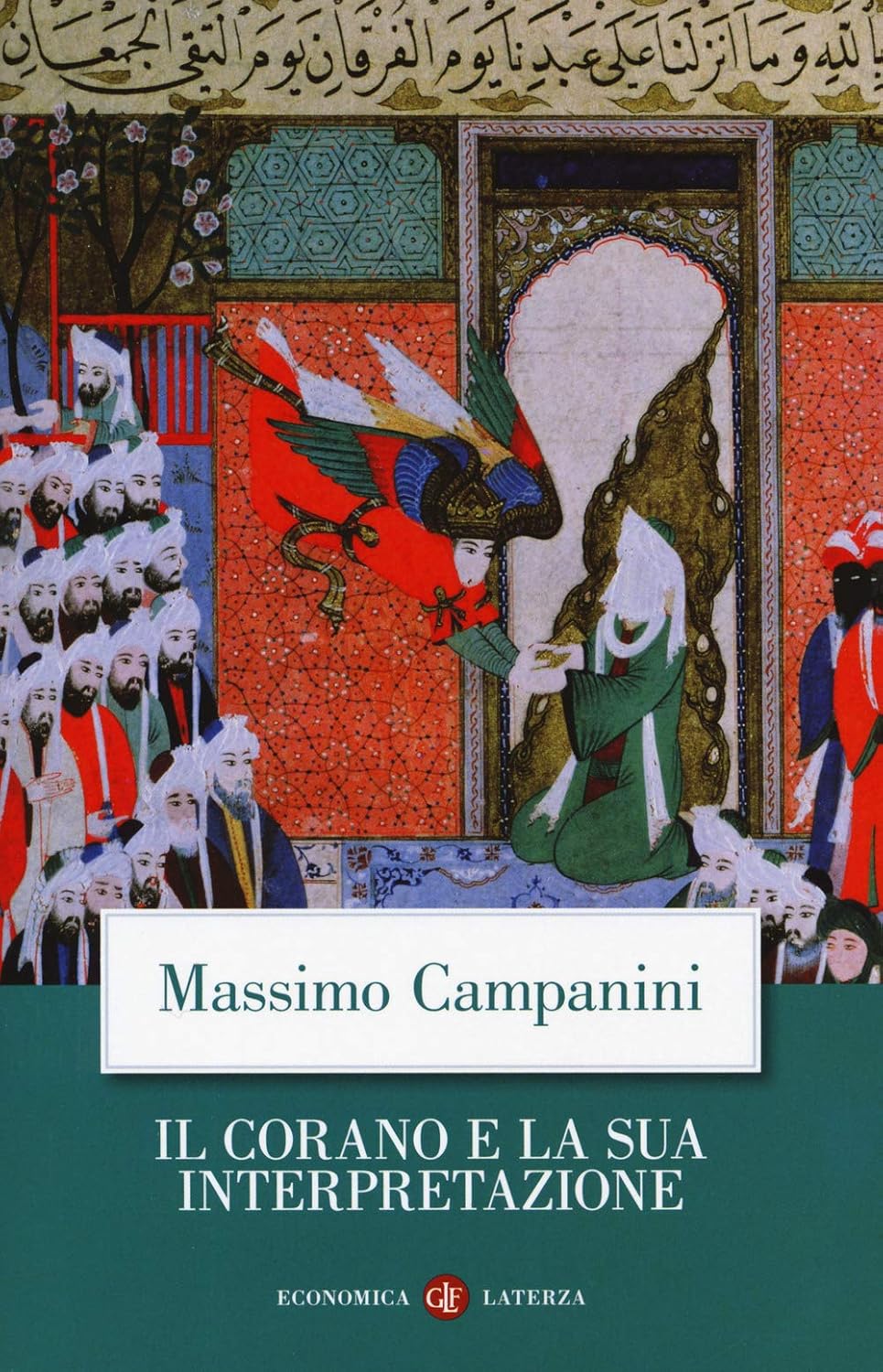
Commento all'articolo